
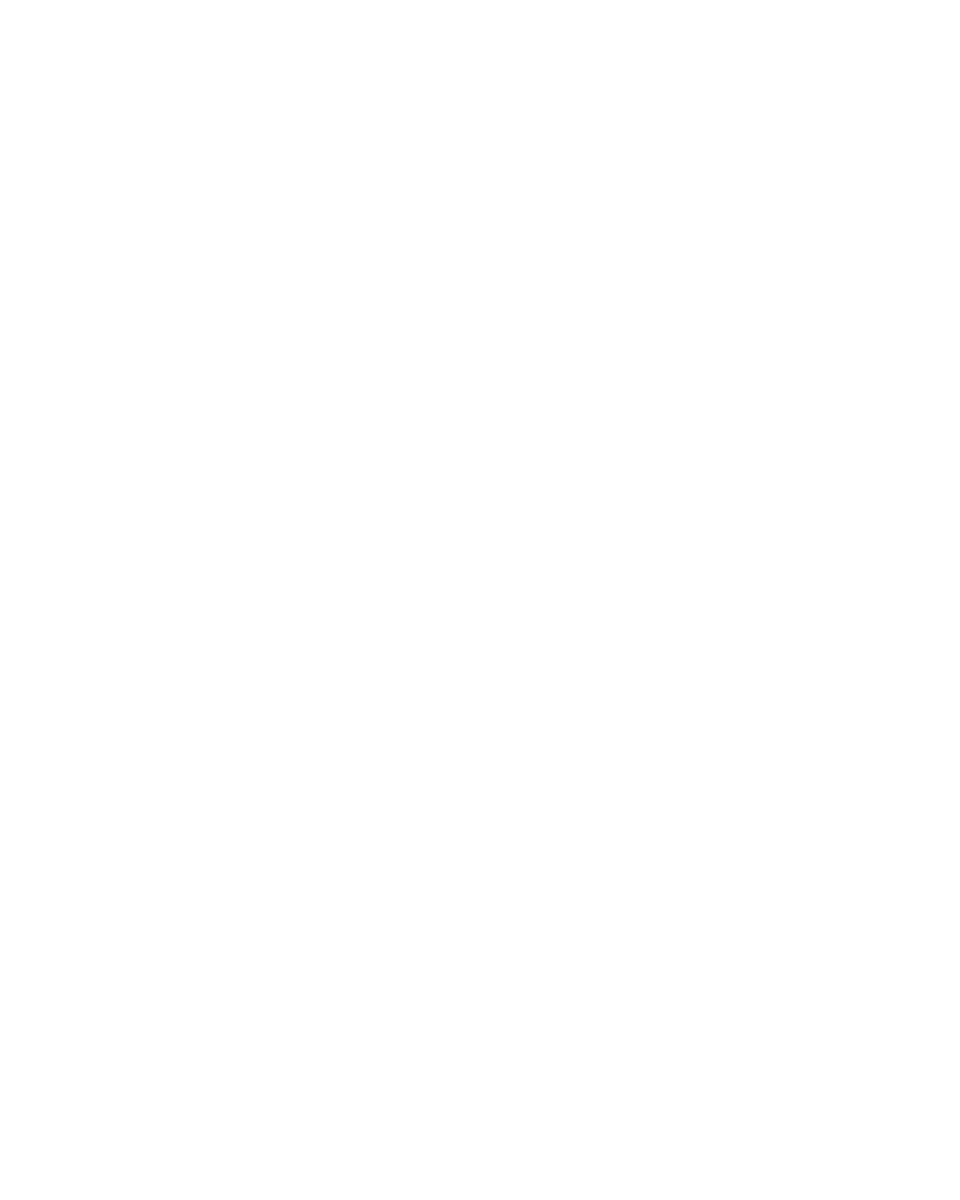
Nasce come attore, poi drammaturgo e anima creativa del Backa Theater, oggi direttore artistico del Royal Dramatic Theatre: Andersson porta a Venezia il suo nuovo spettacolo Vi som fick leva om våra liv (We Who Lived Our Lives Over).
È necessario che il pubblico sviluppi un interesse per questa forma d’arte, che ne sia attratto. Il mio desiderio è che l’esperienza teatro rimanga viva e attiva per generazioni
C’era una volta la Svezia, Paese incontaminato, esempio per tutti di socialdemocrazia e campione di rispetto dei diritti umani. Libertà e facilità nei rapporti. Lavoro per tutti. Vi ho vissuto e lavorato negli anni Ottanta. L’ho amata proprio per questa attenzione verso gli altri, per una cultura industriale decisamente orientata alla motivazione. Ricordo di aver visitato una prigione nei pressi di Gothenburg: villette a schiera in mezzo al verde, nessuna recinzione visibile, televisore in ogni camera. Ma il mondo cambia e Mattias Andersson ne è l’occhio e il testimone. Nasce come attore, poi drammaturgo e oggi direttore artistico della più importante istituzione teatrale della Svezia: The Royal Dramatic Theatre, da tutti conosciuto come Dramaten, a Stoccolma. Un’istituzione dalla cui scuola sono nati attori del calibro di Greta Garbo, Ingrid Bergman, Max von Sydow, Bibi Andersson, per citarne solo alcuni. Prima, Mattias era stato per quindici anni direttore artistico e anima creativa del Backa Theater, molto conosciuto e attivo a Gothenburg, con la vocazione di richiamare i giovani al teatro e alle sue attività socializzanti. Il 21 e 22 giugno lo vedremo al Teatro alle Tese all’Arsenale con Vi som fick leva om våra liv, ovvero come possibile traduzione Noi che abbiamo vissuto le nostre vite di nuovo. Abbiamo voluto conoscerlo più da vicino.
In una Biennale che ha tra le proprie priorità la formazione e la promozione di giovani artisti, le vorremmo chiedere come e perché si è dedicato al teatro e quali sono state le sue esperienze precedenti.
Ho avuto una formazione da attore all’University College of Acting di Gothenburg, tuttavia ho iniziato a scrivere teatro molto prima, quando frequentavo il liceo. Nel corso degli anni ho fatto l’attore mentre continuavo a scrivere, poi il regista sempre da libero professionista. Ho lavorato moltissimo al Backa e nel 2007 ne sono diventato direttore artistico. Dal 2020, invece, ho assunto il mio attuale incarico di direttore artistico al Dramaten, il Teatro Reale Drammatico di Stoccolma.
La sua vita prima del 2007?
Era tutto più difficile. Volevo disperatamente portare in scena i miei progetti, ma non sempre era possibile trovare i finanziamenti. A volte riuscivo a realizzare qualcosa grazie alla commissione di qualche ente pubblico, altre volte riuscivo a produrre qualcosa autofinanziandolo. Ero sempre in giro. All’epoca facevo di tutto pur di stare in teatro il più possibile; ho addirittura accettato l’incarico di addetto alle pulizie per stare vicino alle scene. Non avevo ancora vent’anni, ma il teatro era già il mio interesse esclusivo.

Ho avuto la possibilità di vedere il suo spettacolo The Misfits a Bologna nel 2016. Una narrativa molto cruda sulla gioventù bruciata, sugli emarginati, sul sacrificio di capri espiatori in una società dominata da una gerarchia basata su soldi e potere. Spettacolo in un certo senso emblematico della sua produzione al Backa e del teatro stesso.
Il Backa è molto simile a un progetto sociale e si rivolge a un pubblico eterogeneo per estrazione economica, di classe e anche per etica. È stato molto interessante creare teatro e al tempo stesso creare significato per affrontare le questioni sociali del momento attraverso l’arte, senza ricorrere a mezzi pedagogici usuali, in modo da fornire al pubblico strumenti alternativi di comprensione e riflessione sul mondo in cui ci troviamo oggi a vivere. Tuttavia non è mai stato nostro interesse forzare una tesi politico-sociale piuttosto che un’altra.
Il teatro è però anche intrattenimento. Come gioca questo fattore nei suoi lavori?
Certo, io e tutti noi abbiamo bisogno anche di questo e ne avremo bisogno per generazioni. È chiaro che lo spettacolo deve essere attraente e intrattenere, anche se intrattenimento non significa per forza superficialità o impossibilità di affrontare temi complessi. È necessario che il pubblico sviluppi un interesse per questa forma d’arte, che ne sia attratto. Il mio desiderio è che l’esperienza teatro rimanga viva e attiva per generazioni.
Come definirebbe il suo ruolo?
Sono prima di tutto un drammaturgo. Anche se in quest’ultima opera mi baso su atti documentari e fatti realmente accaduti, il testo è sempre una mia creazione. Nello spettacolo che porteremo a Venezia utilizzo a piene mani interviste condotte da sociologi e ricercatori, ma questo è in qualche modo solo il materiale grezzo, su cui poi intervengo creando una composizione autonoma.
Come ha operato nella scrittura di questo testo?
Per questo lavoro ho iniziato analizzando le interviste, centinaia di pagine da assorbire ed indagare in profondità. Poi ho cominciato a scrivere, cercando di dare a queste interviste un ritmo, che è ciò che dà forma allo spettacolo. Ho inserito gli attori in campo aperto, provando ad associare persone diverse a testi diversi. Mi sono servito anche dell’aiuto di un coreografo, quindi nella versione finale vedrete anche molta danza. Il risultato è un lavoro collettivo, grazie anche all’apporto prezioso che gli attori hanno dato nelle prove. È un lavoro da svolgere “step by step”, che impone di andare avanti e tornare spesso indietro, riscrivendo anche interi passaggi; si tratta di operare grandi e piccoli cambiamenti incessantemente, di essere disponibili a rivedere tutto da capo ogni volta. Gli attori sono agenti di cambiamento e al contempo devono essere in grado di accettare cambiamenti nei loro ruoli anche all’ultimo minuto. Tutto è in divenire sino al debutto. Se alla fine tredici sono gli attori in scena, in realtà almeno altri cento hanno contribuito in qualche modo all’esito conclusivo della messinscena. Lavorare al Dramaten non è facile. È il teatro più grande di Svezia, le produzioni sono numerose. L’attenzione dei media verso le sue attività e le sue proposte è alta ed intensa, conseguentemente la qualità degli spettacoli deve sempre essere a sua volta elevata.

Lei ha anche lavorato sul filone dei polizieschi nordici, che sono diventati negli ultimi decenni celebri in Italia e in tutta Europa. Abbiamo anche notato molta attenzione a Dostoevskij…
Ho lavorato sul nordic crime in un progetto molto specifico. Questo genere ha sicuramente portato immagini sanguinose sui nostri schermi, violenza mista a intrattenimento che entra nelle case la sera, all’ora di cena. Queste produzioni costruiscono sicuramente una particolare narrazione della nostra società. Ciò che personalmente ho cercato di fare è di associare ad essa del materiale documentario. È molto interessante vedere come l’industria televisiva riproduca stereotipi e narrazioni sulla società contemporanea, ritraendo l’attrazione verso la violenza che esiste realmente ed è di anno in anno crescente nella società. Condivido il parere di molti osservatori e critici di questi prodotti sul fatto che l’industria dell’intrattenimento possa contribuire non poco a questa crescita. Di Dostoevskij, a cui ho attinto per film per la tv svedese e per la radio, in particolare nel lavoro Delitto e Castigo, mi ha interessato la tematica relativa al perdono, al valore assoluto della creatura umana, all’etica nel contesto di un omicidio.
Pensa che il teatro debba anche combattere la violenza?
Il teatro oggi è un’alternativa all’esperienza individualistica delle nostre micro piattaforme, telefonini, tablet, computer… Andare a teatro significa trovarsi insieme in una stessa sala e vivere un’esperienza collettiva. In questo senso il teatro è motore di empatia e umanità, di possibile comprensione reciproca. Non penso che lo spettacolo sia di per sé interattivo, ma il solo fatto di condividere un’esperienza comune crea una forma di dialogo, dimensione sideralmente altra e decisamente più socializzante rispetto al trascorrere ore e ore a guardarsi video su TikTok, Instagram o YouTube chiusi soli nella propria stanzetta. È questo che fa la differenza, e che differenza!
Non possiamo non rivolgerle la stessa domanda che sta alla base del suo spettacolo We who lived our lives over: cosa farebbe se avesse la possibilità di vivere la sua vita una seconda volta?
È una domanda assai drammatica, perché ti costringe a pensare a cosa possiedi, a cosa hai realizzato, a quali sono stati i tuoi successi nella vita. Ovviamente mi considero un privilegiato, vivo in un Paese sicuramente dal buon tenore di vita. Posso fare quello che voglio e dispongo di molti beni e servizi. A volte penso però che dovremmo lavorare di più per gli altri che per noi stessi; non lo so, mi sembra che vi sia un che di decisamente narcisistico nel fare arte. È però anche vero che le altre persone sono sempre pronte a giudicare il tuo operato. La pressione sociale è sempre forte. Forse svolgere un lavoro orientato ad aiutare gli altri, come l’assistente sociale o l’insegnante, potrebbe calmare un po’ di questa pressione. Anche se devo confessarlo, il mio lavoro è sempre stato anche, in un certo senso, quello di ‘assistente sociale’.
Immagine in evidenza: Mattias Andersson © Dramaten
51. Biennale Teatro – Emerald