
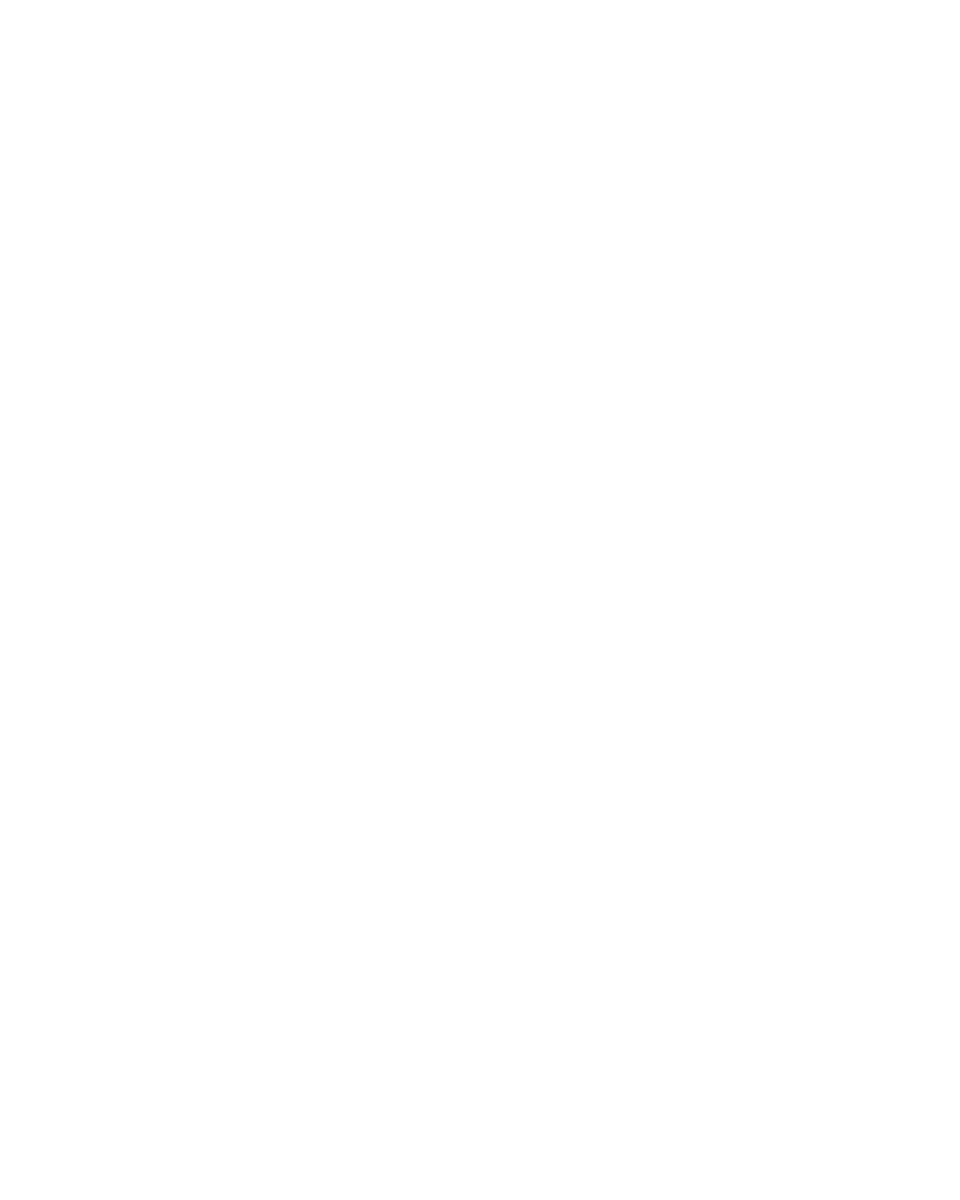
I direttori ricci/forte premiano il fondatore della Compagnia della Fortezza di Volterra per il suo teatro all’interno delle carceri, un lavoro quotidiano e a tempo pieno con circa ottanta detenuti-attori.
Una vita in carcere, senza essere un detenuto, favorendo l’apertura di spazi di cultura e libertà mentale infiniti e portando il Teatro a livelli di eccellenza con attori non professionisti. Questa potrebbe essere in estrema sintesi la bio del regista Armando Punzo, nato a Cercola (Napoli) nel 1959, fondatore della storica Compagnia della Fortezza di Volterra, la prima nata in un carcere nel 1988 e divenuta una delle realtà più importanti della scena di ricerca, cui è stato assegnato il Leone d’Oro alla carriera della Biennale Teatro 2023. Nella motivazione del Premio i direttori della sezione teatro di Biennale Stefano Ricci e Gianni Forte riconoscono a Punzo e alla Compagnia della Fortezza di avere utilizzato il teatro per «ricominciare a sognare un nuovo uomo e imporlo alla realtà nonostante il pregiudizio, perché lo spirito e la fantasia non hanno sbarre che contengano». Un percorso lungo trentacinque anni di lavoro quotidiano e a tempo pieno con circa ottanta detenuti-attori quello compiuto da un artista a dir poco intrigante quale è Armando Punzo che ha portato alla realizzazione di oltre quaranta spettacoli. I suoi lavori hanno ottenuto significativi riconoscimenti sia in Italia che all’estero: Marat-Sade, I negri, I Pescecani ovvero quello che resta di Bertolt Brecht, Hamlice – Saggio sulla fine di una civiltà, Beatitudo sono solo alcuni dei titoli che, attraverso l’indagine diffusa sui grandi temi umani, hanno fatto di un carcere penale come la Fortezza medicea di Volterra un centro culturale all’avanguardia. Lo abbiamo intervistato alla vigilia dell’assegnazione del Leone d’Oro. Ciò che emerge in maniera inequivocabile dalle sue parole è l’idea chiara e pienamente vissuta dell’associare attraverso il teatro la dimensione del carcere all’idea di libertà, contrapponendola al fatto di quanto noi esseri umani siamo prigionieri senza accorgercene.
Il Leone d’Oro alla Carriera. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento?
Mi fa pensare una cosa, ovvero che se c’è un’idea precisa, come la definisco nel mio libro Un’idea più grande di me (Editore Luca Sossella, 2019), e una persona lavora e vi si dedica appieno, anche se ci vuole del tempo e può risultare un percorso in salita, ad un certo punto questa idea prende piede e si impone. Mi pongo con questo spirito di fronte al Leone d’Oro. Evidentemente qualcosa nato trentacinque anni fa e che ha richiesto tanto lavoro non è stato affatto vano; ora è un’idea che può essere riconosciuta, può essere letta per quello che è, e questo secondo me è l’aspetto più importante di tutto questo lungo e duro percorso. Al di là del riconoscimento personale, quindi, il Leone d’Oro rappresenta un riconoscimento a quest’idea e a tutto il lavoro svolto per realizzarla.
Alla Biennale presenterà lo spettacolo Naturae che parla del «sogno di un’umanità perfetta e luminosa, che costituisce la nostra autentica natura», come scrive nelle note di regia. Lei ha deciso di svolgere il suo lavoro in un luogo di chiusura piuttosto che di apertura, dove c’è innegabilmente il senso del male, che in un’occasione lei ha definito “trasparente”. Può chiarirci questo concetto?
Non si può sfuggire al tema del male, inteso come il male nell’uomo, il male in questo mondo. Lavorando all’interno del carcere mi sono interrogato dentro, chiedendomi quale fosse il mio rapporto con il male. Sono arrivato alla conclusione di ritenere che evidentemente per me il male è e deve essere di una densità trasparente, altrimenti diventa pietra, muro invalicabile e insormontabile. Per me il male non può che essere assolutamente trasparente, quindi, sì; non posso fermarmi a quelle che sono le cronache, le mere azioni compiute da una persona in un determinato momento. Devo saper e poter andare oltre per riuscire a vedere cosa c’è dall’altra parte. In questo senso il male deve essere trasparente, altrimenti nulla di ciò che faccio avrebbe senso: se ci si ferma davanti al male, si possono trovare tutte le giustificazioni di chiusura del mondo. Fermarsi davanti al male non basta, bisogna provare a guardare oltre e capire cosa c’è in quell’altrove; non per giustificare, alleggerire o addirittura idealizzare alcunché, ma semplicemente perché è umanamente indispensabile, necessario cercare sempre e comunque il bene. Questa è la mia esperienza personale. Giorno per giorno mi rendo conto quanto incessantemente vada ricercato il bene e questo non solo in carcere, ma in ogni frangente della quotidianità. Molti non smettono di cercare il male negli altri, anche in banalissime occasioni di confronto o scontro, come possono essere quelle in famiglia o al bar; sembra sempre si vogliano far emergere gli aspetti negativi, si parla solo di quelli, tutto il resto diviene secondario. Questa è una caratteristica umana a dire il vero, forse anche culturale, ma finisce solo col suscitare ulteriore male e non porta a nulla di buono, di umanamente positivo.

Lei ha sempre asserito che il teatro in carcere è soprattutto arte. Ci spieghi meglio le ragioni di questa sua convinzione.
Preciso: il mio teatro in carcere è soprattutto arte. Esistono altre realtà e altre esperienze che invece individuano nel teatro uno strumento al servizio della rieducazione. Ecco, detto in generale, questa idea del teatro al servizio di altro scopo proprio non mi convince. Piergiorgio Giacchè, studioso e storico del teatro, aveva sottolineato questa disposizione aperta, fuori dalle strettoie canonicamente rieducative, sin dall’inizio della nostra esperienza, nei primissimi anni Novanta: da subito si era reso conto che nell’utilizzo strumentale di questo linguaggio espressivo vi è qualcosa di costitutivamente sbagliato, che depotenzia il teatro e l’atto artistico in sé. L’atto artistico è contraddittorio, deve essere libero, non può essere vincolato a un fine, perché altrimenti si perde il senso di cosa sia l’arte, ovvero un viaggio di conoscenza. L’arte non è una tesi, qualcosa di già pronto, confezionato; è piuttosto un dirigersi verso un tema e casomai scoprire di aver cambiato punto di vista su quel tema stesso nel corso del tempo. Quindi l’arte deve essere un percorso di scoperta e di conoscenza prima di tutto per l’artista e in secondo luogo per il pubblico che eventualmente ne fruisce. L’idea del teatro come strumento di rieducazione rappresenta a mio avviso uno svilimento del teatro stesso; nel mio caso, quindi, rappresenterebbe una detrazione radicale dell’identità prima del mio progettare, perché non sono entrato a lavorare in carcere per questi motivi. Non ho mai vissuto l’esperienza della Fortezza accompagnato dall’idea di poter salvare qualcuno; se avessi dovuto salvare qualcuno, avrei dovuto salvare prima di ogni altro me stesso! Sono entrato in carcere mosso da ben altre ragioni, in primis dall’idea che il Teatro andasse rifondato mettendolo alla prova in un luogo difficile. Più nello specifico pensavo a come fare reagire massima chiusura e massima apertura insieme: la massima chiusura è rappresentata naturalmente dal carcere, mentre la massima apertura è il teatro, che credo personifichi lo spazio di maggior libertà in assoluto, ed è geneticamente, fisiologicamente così.
Leggendo le sue note biografiche pare che l’insoddisfazione verso il teatro con cui si trovava a fare i conti era tale che la Rocca di Volterra è arrivata quasi come una folgorazione, si può dire che sia stata la sua “via di Damasco”. Come è nata questa esperienza e perché proprio il carcere di Volterra, considerato di massima sicurezza, con detenuti che devono scontare pene anche molto lunghe, se non addirittura ergastoli?
Il fatto che Volterra sia una casa di reclusione dove si scontano pene molto lunghe costituisce un aspetto importante di questo progetto, perché con persone che hanno davanti a sé molti anni di pena è possibile svolgere un lavoro anche nel tempo, a differenza di quanto potrebbe accadere in un carcere circondariale, dove la permanenza è molto più breve. In teoria quest’ultima potrebbe sembrare una migliore opportunità, ma nel concreto non è così, perché i detenuti non vivono la prospettiva di un lungo arco temporale di detenzione, proiettandosi già all’esterno e di conseguenza meno interessati a scoprire e intraprendere percorsi nuovi. Al contrario una persona in carcere con una pena molto lunga, se decide di interfacciarsi a qualcosa di stimolante, in questo caso al teatro, può effettivamente compiere un’esperienza formativa importante, fino a potersi costruire un nuovo profilo professionale. Nel caso nostro divenendo magari a tutti gli effetti un attore, o comunque arrivare ad occuparsi di arte a livello professionale e non soltanto per un certo periodo ristretto della propria vita.
Una curiosità: quando lei entra in contatto con i detenuti le loro storie la influenzano oppure, trovandosi in quel luogo, il loro ‘curriculum’, se così possiamo chiamarlo, diventa a tutti gli effetti un elemento marginale da prendere in considerazione nel suo percorso di lavoro?
Non ho mai voluto leggere i loro fascicoli o essere messo a conoscenza di fatti specifici oggetto della loro detenzione. Naturalmente con il tempo ho saputo e imparato tanto di loro personalmente, ma non è davvero questo l’aspetto più rilevante del percorso. Se io entrassi in carcere e prima di incontrare una persona mi andassi a leggere il fascicolo per sapere tutto quello che ha fatto o detto, a che scopo dovrei farlo? Il mio problema, il mio obiettivo, è capire cosa possiamo fare insieme dal momento del nostro incontro in poi. Il passato fa parte del passato e di una vita ordinaria, per quanto irregolare essa sia stata, mentre a me interessa andare oltre l’io ordinario, voglio conoscere qual è l’io straordinario che possiamo mettere in campo io e quella determinata persona, o quello specifico gruppo di persone: questo è veramente l’elemento sostanziale, direi identitario dell’atto artistico. Ad altri interessa invece maggiormente l’io ordinario, il classico “inciucio da bar” per sapere cosa ha fatto questo o quell’altro; una morbosità questa sì deviata che mortifica l’essere umano.
Di quante persone è composta la Compagnia e come si struttura il lavoro all’interno del carcere?
Io sono lì presente tutti i giorni. Dal 1988 ho capito che non potevo lasciare il carcere. La prigione è come un buco nero che inghiotte tutto, è la sua natura. È stata creata appositamente con l’intento di annichilire la natura umana di base e poi rimangiare tutto quello che di positivo potrebbe essere fatto lì dentro: con questo luogo, lavorandoci, si ingaggia una battaglia quotidiana. La Compagnia è composta da oltre 80 elementi e normalmente in scena siamo tra le 60 e le 80 persone per gli spettacoli presentati in carcere, mentre quando andiamo in tournée chiaramente non tutti possono uscire, quindi abbiamo due scritture parallele, una per l’interno e una per l’esterno. La scorsa estate ne sono usciti una trentina per recitare nelle scene “normali”, un numero comunque significativamente assai alto considerando la provenienza.
Come è cambiato il rapporto con le istituzioni nel corso di oltre trent’anni?
È stato un crescendo di apertura e possibilità. All’inizio, stiamo parlando di trentacinque anni fa, la struttura carceraria nel suo complesso, sia agenti che detenuti, non capivano chi fosse questa figura di artista che entrava nel loro spazio con una proposta decisamente fuori dagli schemi. Alcuni tra gli agenti pensavano fossi stato mandato dalla camorra, mentre i detenuti credevano io fossi una sorta di spia, un delatore incaricato dall’istituzione carceraria al fine di carpire i loro segreti. È stato un lavoro lento, lunghissimo, anche molto difficile e conflittuale in alcuni momenti, per affermare in maniera inequivocabile che il mio unico intento era fare arte. Mi interessava l’uomo da quel punto di vista, tutto il resto no, né il carcere, né tutte le altre beghe; desideravo solo avere spazio, tempo e persone con cui stare insieme e con cui poter lavorare. Ho dovuto conquistare progressivamente il mio spazio e devo farlo ancora oggi, anche se chiaramente ora riesco a fare cose che trentacinque anni fa erano semplicemente impensabili. È stata la lenta conquista di un’apertura; il teatro si è guadagnato lo spazio immaginativo, ha messo solide radici dentro a un carcere e quindi questa apertura continua ad espandersi. All’inizio era davvero molto faticoso. In verità continua ad esserlo, perché bisogna comunque giorno per giorno affermare le nostre necessità e anche i diritti e l’esistenza di questo lavoro.

Torniamo allo spettacolo Naturae: ce ne può raccontare la genesi? Cosa effettivamente vedremo a Venezia?
La genesi in realtà è molto complessa: si tratta di ben otto anni di lavoro. In estrema sintesi: otto anni fa Shakespeare e l’umanità che racconta sono divenuti il nostro tema di lavoro. Un tipo di umanità che ci assomiglia drammaticamente, tragicamente, sia negli aspetti positivi che in quelli negativi. Non parlo solo delle tragedie, del sangue, delle vendette, ma dell’essere umano così come noi lo comprendiamo, come lo viviamo, così come noi siamo in definitiva. Abbiamo preso ad esempio questa esperienza di narrazione dell’essere umano chiedendoci se effettivamente non fosse arrivato il momento di metterla in crisi, perlomeno in discussione, provando a domandarci se l’essere umano è e sarà sempre davvero solo così, perché è questo ciò che ci consegna Shakespeare, ovvero la sensazione che nulla mai cambierà, perché sono passati quattro secoli eppure siamo ancora fermi allo stesso punto. Abbiamo svolto un lavoro enorme per cercare di demolire quest’immaginario shakespeariano fino ad arrivare a Dopo la Tempesta, diretto riferimento all’ultimo testo del Bardo, dove l’idea era quella di non mettere più in scena alcunché di tangibile, di tradizionalmente leggibile con i canonici registri teatrali. Il capocomico si ferma e ha intorno a sé solo fantasmi; ripensa a questi fantasmi, che tante volte ha messo in scena lui stesso, ma ad un certo punto è come se si rendesse conto che quello che fa non ha più alcun senso e quindi ferma il gioco della rappresentazione dell’uomo. Interviene un bambino molto piccolo, nel nostro caso era Marchino, il nipote di un amico, che rappresenta l’innocenza. Alla fine di questo primo lavoro, Marchino prende il capocomico per mano e lo porta via, lasciando lì ferma quell’umanità e iniziando un viaggio alla scoperta di altre possibilità. Nel frattempo ho letto Borges e ho individuato in lui un autore che ci poteva accompagnare per capire dove condurre questo capocomico. Con Borges e Beatitudo abbiamo affrontato un’altra umanità, più bidimensionale; è stata una vera sfida, perché con Borges non riesci ad immedesimarti o ad avere lo stesso approccio che puoi avere con Shakespeare. Passati due anni di lavoro, anche al termine di questo spettacolo, ritorna il bambino a prendere per mano il capocomico e lo porta di nuovo via con sé, fino ad arrivare a Naturae, nelle sue diverse declinazioni. Quella che verrà mostrata a Venezia è l’ultima fase e rappresenta l’idea di mettere in luce queste “naturae”, cioè parti all’interno dell’essere umano che sembrano essere minoritarie, come ad esempio l’armonia, una qualità che tutti conosciamo benissimo ma che frequentiamo poco. Abbiamo iniziato dunque a lavorare sull’idea di queste qualità umane considerate “secondarie” che esistono concretamente, ma che vengono normalmente trascurate. Lo spettacolo è il tentativo di raccontare un uomo che dà vita alle sue “naturae”, mostrando cosa accade se diamo più spazio alle nostre qualità, senza essere sempre prigionieri di questa natura umana per come viene descritta e raccontata da Shakespeare, ma più in generale per come viene restituita ancora oggi da tanti scrittori, artisti e teatranti. Il tema dell’essere umano letto nelle sue più aggrovigliate contraddizioni sembra sempre attuale; io trovo che sia invece un argomento semplicemente superficiale e anche forse superato, polveroso, nonostante molti artisti si credano rivoluzionari nel trattare sempre questi temi di ‘attualità’. Ora abbiamo addirittura l’Europa che ci fornisce i temi contemporanei di cui occuparci, come ad esempio i migranti… Un dettato “corretto” che personalmente non mi coinvolge e non mi convince in alcun modo.
Lei ha già lavorato alla Biennale nel 1999-2000 con dei laboratori di produzione, quindi si tratta di un ritorno a Venezia. A guardare i dati degli spettatori del teatro “ufficiale” pare ci sia di che preoccuparsi, mentre festival come la Biennale Teatro trasmettono la sensazione di un fermento, in particolare per il crescente interesse e la rinnovata partecipazione da parte dei giovani verso questa forma espressiva. Dal suo osservatorio particolare come vede il presente e il futuro prossimo del teatro nel nostro Paese?
Mi sembra ci sia stato un grande fiorire di interesse attorno al teatro anche in questi difficili anni di chiusure e riaperture; bisogna fortunatamente riconoscere che le persone vanno ancora a teatro, sì. Che l’Italia sia sempre un po’ indietro rispetto alle innovazioni penso faccia parte della natura del nostro Paese, incline da sempre a una sorta di innata chiusura verso il nuovo a favore di tutto ciò che è tradizione. Però io nutro fede, perché evidentemente ci sono degli spazi, e la Biennale è sicuramente uno di questi, dove è possibile confrontarsi con quanto di nuovo e anche contraddittorio c’è al momento, e questo è fondamentale. Quindi, sì, ci sono degli spazi in Italia; la vera questione è che ce ne dovrebbero essere di più. Ad esempio abbiamo avuto in visita recentemente delle scolaresche da Livorno, prime e seconde classi delle scuole superiori, e mi sono reso conto di quanto lavoro serva ancora fare non tanto per raccontare il mio teatro in carcere, ma proprio per far capire quanto sia importante riuscire a sviluppare dei punti di vista diversi scoprendo ciascuno le proprie potenzialità. Mi colpisce molto quanto questo purtroppo venga poco praticato un po’ ovunque.
Ora sta per riuscire a dare una concretezza materica al proprio teatro grazie al progetto di Mario Cucinella, in cui finalmente si delinea uno spazio fisico per un pubblico più vasto all’interno del carcere di Volterra. Diventare un teatro stabile nel ventre di una struttura carceraria è sicuramente una grande conquista. Ci sono altri esempi di questo tipo in Europa o nel mondo?
No, non c’è nessuna esperienza così longeva. E non c’è nessuno che abbia fondato il proprio lavoro artistico solo su questo tipo di esperienza, nel senso che io faccio questo in maniera esclusiva, non è uno dei vari miei lavori: è il mio lavoro, mentre normalmente questo tipo di interventi si fanno o per periodi limitati o per progetti ben definiti. Non ci sono esperienze simili per ora. Credo di non peccare di presunzione dicendo che si tratta di un’esperienza di rara importanza, ma quel che è ancora più significativo è che una simile esperienza si stia consumando proprio in Italia, perché siamo da sempre abituati a pensare che cose del genere debbano accadere necessariamente altrove, quando invece l’Italia ha una legge precisa che regola questo genere di attività. Senza parlare della Costituzione, che è straordinaria e che per prima permette che queste esperienze si possano concretamente realizzare. Il progetto di Mario Cucinella poi è qualcosa di davvero importante, di veramente prezioso.
Immagine in evidenza: Naturae © Stefano Vaja