
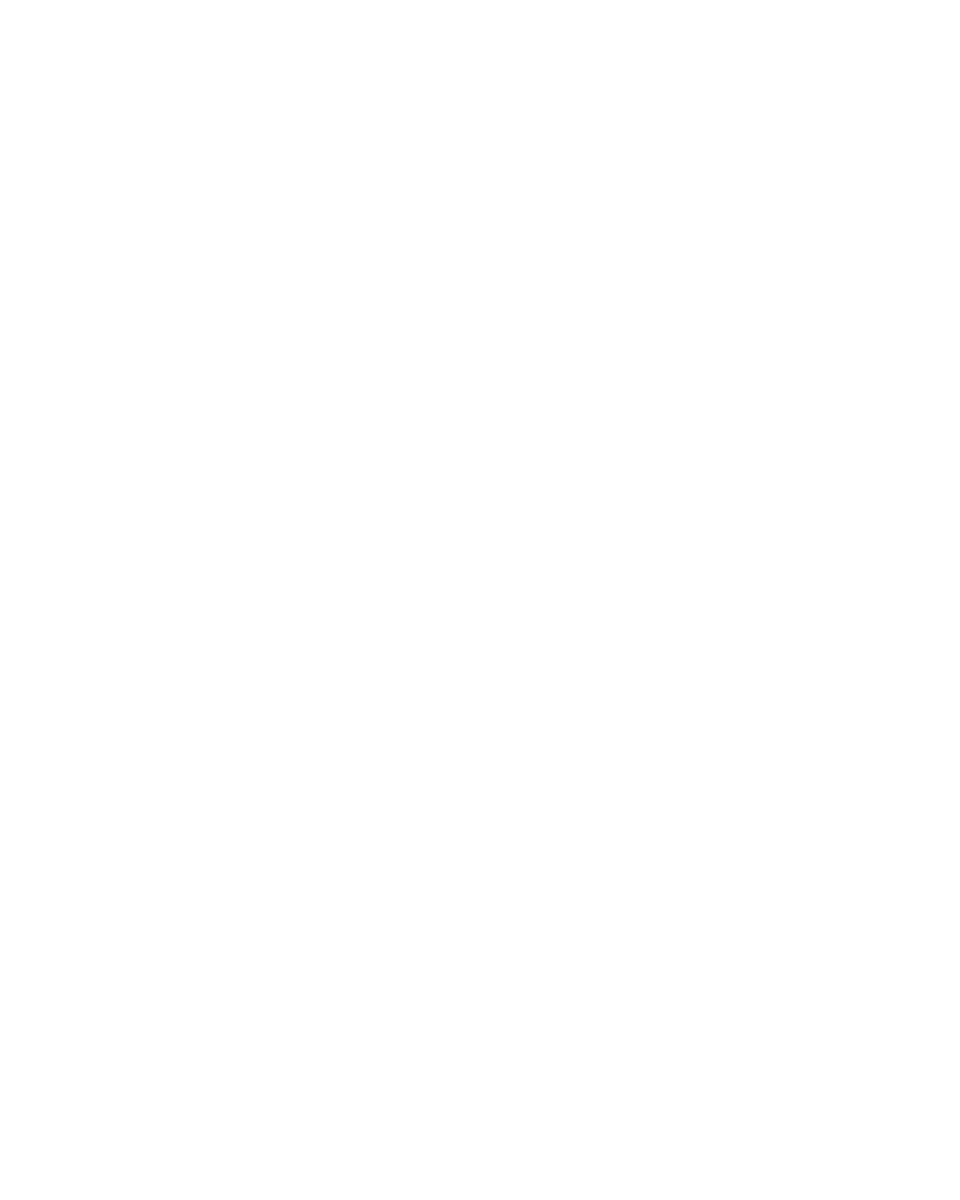
Incontrarlo a Venezia non è così infrequente, anzi. Da sette edizioni Carlo Giordanetti si occupa di coordinare la presenza di Swatch alla Biennale Arte. In questa intervista ci guida nel multiforme e coloratissimo mondo dell’azienda di orologi fra le più famose al mondo.
Incontrarlo a Venezia non è così infrequente, anzi. Carlo Giordanetti, torinese ma cresciuto a Milano e da lì viaggiatore nel mondo, è anche un po’ veneziano. Dal 2012 al 2019 è stato direttore creativo di Swatch, ora è membro del Design Committee di Swatch e CEO dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai. Da sette edizioni si occupa di coordinare la presenza di Swatch alla mostra d’arte contemporanea più famosa e prestigiosa al mondo. Swatch è quest’anno ai Giardini con l’opera site-specific del giovane artista grafico giapponese VERDY, mentre all’Arsenale ha creato un ponte diretto tra Venezia e Shanghai con Swatch Faces 2024. Alla base del DNA di Swatch vi è una volontà precisa di innovare e creare e anche in questa 60. Biennale non mancano due nuove, attese edizioni di orologi. Carlo Giordanetti ci guida nel multiforme e coloratissimo mondo Swatch.
Per celebrare la 60. edizione della Biennale, Swatch ha creato un orologio speciale, chiamato BIENNALE 60TH. Disegnato in collaborazione con il collettivo parigino e palermitano Claire Fontaine, BIENNALE 60TH It is a pure, essential, direct design with an unexpected touch (“È un design puro, essenziale e diretto con un tocco inaspettato”) è realizzato in materiale biosourced nero con dettagli bianchi fosforescenti. Prima di tutto volevamo sapere la sua idea di tempo e poi naturalmente com’è nato il progetto BIENNALE 60TH e la relazione con Claire Fontaine. Insomma, come nasce uno Swatch speciale?
La percezione del tempo cambia a seconda di come sei. In questo momento il tempo per me rappresenta una sfida, nel senso che diventa quasi un cerchio all’interno del quale mi trovo a girare in continuazione, cercando di compiere più giri possibili. A volte mi sembra di fare persino più giri delle lancette di un orologio! È un momento così dal punto di vista professionale e dei progetti che seguo e mi piace, perché vincere la sfida con il tempo è sempre una bella impresa. Per fortuna poi non mi sento così costretto dal tempo; credo di essere abbastanza bravo a gestirlo e non mi fa paura in generale. Direi che il mio rapporto con il tempo è di convivenza serena, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida. Tutti gli anni per Biennale abbiamo sempre realizzato un orologio dedicato. Ammetto che, nel momento in cui ho iniziato a pensare alla nuova edizione e agli artisti da coinvolgere, non sapevo che Foreigners Everywhere, il titolo della 60. Biennale Arte, nascesse da un’opera di Claire Fontaine (Fulvia Carnevale e James Thornhill) e che avrei contattato proprio “lei” per la creazione del nuovo orologio! Così ho deciso di approfondire il loro lavoro e ho scoperto il loro bellissimo mondo – come per esempio il lavoro fatto con Maria Grazia Chiuri per Dior. D’altro canto Fulvia e James non si aspettavano che qualcuno gli chiedesse di realizzare l’orologio per la Biennale; c’è stato subito uno scambio molto divertente, anche perché in quel momento stavano lavorando intensamente su un nuovo progetto. Il risultato è un design estremamente essenziale per essere uno Swatch, con un piccolo gioco: il Foreigners si esprime in maniera importante sull’orologio e l’Everywhere invece è al posto del logo Swatch; il logo c’è lo stesso ovviamente ma è quasi invisibile, lo devi cercare. Trovo sia un bellissimo esercizio di occupazione dello spazio. Oltre al BIENNALE 60TH, come ad ogni edizione abbiamo commissionato un orologio all’artista ospite in mostra ai Giardini, che quest’anno è un artista giapponese, non tradizionale e molto pop, che usa un linguaggio street fatto di piccole provocazioni. Per ospitare la sua opera ai Giardini abbiamo ideato una presenza diversa: normalmente occupiamo lo spazio in senso orizzontale, questa volta lo occuperemo in senso verticale, con un gesto creativo molto divertente, assolutamente in linea con il tema Foreigners Everywhere. Come dicevamo il progetto, al momento dell’intervista, è ancora sotto embargo, ma posso anticipare per chi accederà ai Giardini che troverà la nostra presenza evidente, positiva e aperta, forte e diversa. Lo Swatch sarà una sorta di rappresentazione dell’opera, restituendo un forte legame con essa.

I linguaggi del contemporaneo, come moda, design e arte, ma anche musica, danza, teatro, architettura, cinema e digitale sono sempre più connotati da una contaminazione fortissima. Quale evoluzione in questa direzione Swatch ha disegnato attraverso il suo speciale osservatorio, vale a dire Swatch Art Peace Hotel?
Questa è proprio la realtà del nostro quotidiano. La maggioranza degli artisti che arrivano all’Art Peace Hotel quando devono rispondere alla domanda del questionario sulla disciplina artistica attraverso la quale si esprimono non indicano mai un solo linguaggio. Oggi anche chi sceglie “visual art”, che è un termine comunque abbastanza ampio, aggiunge sotto qualcosa. È un tratto, questo, che emerge palesemente soprattutto nei più giovani: l’ambizione ad esprimersi attraverso tutti i linguaggi, un ardente desiderio di essere presenti in tutte le possibili forme di espressione, anche quando in realtà non sono dotati delle capacità basiche per cimentarvisi. “Un giorno lo potrei fare”, dicono, come se il mondo fosse un infinito negozio di giocattoli e tu potessi scegliere quello che vuoi. I grandi artisti non sono mai stati limitati da ristretti recinti disciplinari; sappiamo che Caravaggio scriveva anche, però non sono i suoi scritti ad essere passati alla storia, non erano quelli che interessavano. Questa particolare ambizione totalmente “aperta” dei giovani ho il dubbio che possa derivare un po’ dall’educazione che ricevono nelle scuole; il rischio è quello poi di trovarsi al cospetto di un panorama assai confuso. Nella tensione immaginifica di sperimentare tutto è inevitabile che alla fine si crei della confusione. Secondo me sarebbe interessante, direi doveroso, trovare il modo di aiutare i giovani ad individuare innanzitutto una pratica di espressione ad essi più congeniale, per poi in un secondo momento, dopo aver assorbito sufficientemente la grammatica di una disciplina, magari passare a sperimentarne altre. Questa compresenza orizzontale, questa presunta possibilità nomade di passare da una forma espressiva all’altra seppur dotati di ben pochi fondamentali trovo che sia, se non gestita correttamente, una modalità di lavoro, di ricerca, che può rivelarsi rischiosa per quanto concerne la lettura di un progetto artistico.
Quando nasce Swatch Art Peace Hotel e perché proprio a Shanghai? Avete considerato di esportare la formula anche in altri luoghi?
Nasce nel 2011 a Shanghai per una ragione molto chiara e diretta, che fa parte dei fondamentali stessi del progetto. Quando Swatch ha iniziato seriamente ad entrare nel mercato cinese, cominciando ad aprire negozi, era il momento della Cina “bling bling”, in cui il prezzo e l’apparenza erano i criteri di scelta di successo. Swatch voleva e vuole continuare ad offrire un approccio di grande accessibilità verso i propri prodotti anche dal punto di vista dei prezzi. Parliamo di anni in cui i nostri orologi erano fatti di plastica, non di bioceramica; orologi colorati, il cui prezzo rischiava di essere irrisorio agli occhi della cultura del diamante e dell’oro giallo che imperversava in Cina. Dovevamo dare un valore aggiunto immateriale al brand, questa è stata quindi la circostanza che ha informato la nostra decisione di aprire una struttura-laboratorio come lo Swatch Art Peace Hotel a Shanghai: far comprendere al mercato Cinese la nostra visione, la volontà di far diventare il prodotto un’espressione artistica. Chiaramente gli orologi d’arte li abbiamo sempre fatti, fin dal 1984, però volevamo che si capisse che gli artisti in residenza allo Swatch Art Peace Hotel non lavoravano per noi, ma per loro stessi. Questo è diventato l’investimento di Swatch nel mondo dell’arte. C’è stato per un attimo l’impulso a replicare l’operazione altrove, ma abbiamo capito che non sarebbe stato giusto, anche perché rifarlo con la stessa qualità in un altro luogo avrebbe rappresentato un investimento davvero molto importante anche per un gruppo come il nostro. Abbiamo pensato allora a dei ‘satelliti’, magari limitati nel tempo. La vera ricchezza del progetto consiste però nella comunità in continuo divenire che si viene a formare, cosa che residenze temporanee satelliti non avrebbero potuto garantire. Inoltre nel frattempo il progetto è diventato sempre più grande, contiamo ormai oltre 500 artisti che vi hanno partecipato. Venezia sarebbe in realtà il luogo ideale per replicarlo, per la sua relazione atavica con l’Oriente, ma anche per altre mille ragioni identitarie che ben conosciamo, in primis in quanto casa per eccellenza delle arti, antiche e contemporanee; sarebbe fantastico, sì, però al momento stiamo lì, a Shanghai, ben ancorati. È un progetto molto identitario, questo è sicuro, ma il lavoro che facciamo e di cui siamo più fieri è quello di portare in giro per il mondo i nostri artisti e questo per chi viene selezionato ha un valore fondamentale.

Questa esplorazione di nuovi territori e nuovi linguaggi si concretizza ora nel Swatch Faces 2024 all’Arsenale. Sei ex artisti in residenza allo Swatch Art Peace Hotel presentano le loro opere all’interno della Biennale. Come e perché la scelta è ricaduta su questi artisti e in che modo le loro opere contribuiranno al dibattito della Biennale 2024 incentrato sul concetto di Stranieri Ovunque?
Un po’ come tutte le decisioni della mia vita, quella degli artisti da portare a Venezia per me è una scelta che mette insieme il cuore e la pancia. Sono artisti che durante l’incontro mi hanno in qualche modo ‘parlato’, mi sono rimasti dentro e, soprattutto, credo possano essere associati al mondo Swatch. Mi è capitato di imbattermi in progetti che mi hanno colpito magari in maniera anche più profonda, ma ho una responsabilità rispetto ad un marchio; deve esserci equilibrio alla base di queste scelte che devo riuscire a far condividere all’azienda. Mi sono accorto di avere una quota significativa di artisti sudamericani in questo viaggio empirico, ma è una cosa avvenuta in maniera del tutto casuale, e poi con il tema Foreigners Everywhere stiamo ancora qui a guardare il passaporto…? Ci sono, tra le opere selezionate, alcune che rispondono direttamente al tema dato da questa Biennale, una in particolare è quella del messicano Juan Pablo Chipe, un personaggio fantastico, quasi un fumetto. È nato e cresciuto a Tijuana, quindi ha sempre vissuto in terre di frontiera, avendo da una parte la cultura tradizionale della sua famiglia e dei suoi amici e dall’altra parte quell’“altra cosa” lì a due passi, la cultura americana. La sua opera, forse la più Swatch mai presentata, è una statua di tre metri e mezzo raffigurante Marge Simpson con il volto di Frida Kahlo. La reazione quando la vedi è il classico: “non ci posso credere!”. Intorno alla statua, Chipe presenta una serie di collage sul tema delle contaminazioni molto divertenti e interessanti, che fanno riflettere oltre che sorridere. Gli argentini Leo Chiachio & Daniel Giannone, coppia artistica e nella vita, sono invece legati all’espressione della cultura queer in un contesto come l’Argentina dove non è proprio facilissimo esprimersi in maniera compiutamente libera a riguardo. Artisti connotati da una peculiarità che trovo personalmente meravigliosa: ricamano tutto quello che fanno. Avevo già visto il loro lavoro tempo fa, lo trovavo molto Swatch; così nel 2016 gli ho proposto di fare un orologio. Hanno accettato con grande entusiasmo, ponendo però la condizione inderogabile di farlo ricamato, secondo la loro pratica. Ho risposto che non c’era problema e lo abbiamo realizzato ovviamente con un ricamo a macchina. Ad un certo punto, mentre chiacchieravo con loro in occasione della presentazione dell’orologio a Parigi, gli ho parlato dello Swatch Art Peace Hotel ed ho visto questi due signori di una certa età illuminarsi di meraviglia. Hanno compilato la loro application e sono partiti per Shanghai. All’Arsenale Leo Chiachio & Daniel Giannone presentano un’opera che invita al dialogo: due muri ricamati che rappresentano l’ambiente domestico un po’ vecchio stile, dove c’è un personaggio per loro fondamentale, il bassotto di casa di nome Piolin. I due artisti saranno presenti durante l’inaugurazione rendendo viva l’installazione: il visitatore è invitato a sedersi davanti a quest’opera e a dialogare con loro. Luo Bi, una ragazza cinese deliziosa, ha invece realizzato un video immersivo composto da rappresentazioni digitali e fiabesche della natura. Sembra di entrare in un giardino, tra rami, fiori meravigliosi e cose che accadono, con una tecnica speciale per cui tutto sembra venirti incontro. È un lavoro molto girly, ma possiede una grande forza. Jiannan Wu, anche lui cinese, realizza altorilievi dove miscela dimensioni anche controverse con situazioni esageratamente pop, quasi da cartoon. È come se, attraverso la sua opera, da un lato volesse erodere la serietà o comunque il peso di certe condizioni, ma facendolo le mette inevitabilmente in ridicolo. Tre i temi scelti: il primo, molto originale, rappresenta il set tv di un telegiornale con il cronista che legge le notizie su una catastrofe in atto mentre dal nulla sbucano Tom e Jerry; un’altra è una presa in giro della cultura cinese attraverso la ricostruzione di un pranzo in una casa tradizionale dove davanti al cibo i convitati perdono qualsiasi dignità; la terza è una declinazione politically correct di un’altra opera che aveva realizzato in precedenza, una giostra su cui aveva posizionato Putin, Kim e altri, cosa che qui non potevamo prendere in considerazione; così nella nuova versione sono stati sostituiti da animali fantastici che girano sulla stessa giostra, al contempo bella ma inusuale. Infine Maya Gelfman, artista nata in Israele ma assolutamente nomade, che si muove tra Parigi, New York e altri luoghi ancora. Maya ha realizzato quattro opere che creano una specie di scatola dipinta con uno sfondo, un tetto e due pareti. È un’artista che possiede una tecnica densa e decisa grazie alla quale forme e profili rimangono però sempre riconoscibili: è come guardare da una finestra su Shanghai, una sorta di visione prospettica su quello che si vede dallo Swatch Art Peace Hotel. Nel caso di Maya Gelfman è la tecnica ad essere particolarmente interessante: dal punto di vista estetico è molto forte, presenta una texture incredibile. Qui il gesto d’artista emerge davvero in forma decisa.
Quale il suo punto di vista sulla ricerca di un’arte diversa, “strange”, che è poi la radice viva del titolo di questa Biennale, Foreigners Everywhere, che può assumere diverse sfumature a seconda dell’idioma in cui il termine viene tradotto? Dalla sua posizione di CEO della Residenza, quale contemporaneo stiamo vivendo?
Innanzitutto a me di Swatch piace lo strano, il diverso, il provocatorio, su questo siamo molto in sintonia. Il bemolle sta nel fatto che lo strano deve avere una ragione di esistere, un suo ordine. Faccio un paragone con la moda: guardando certe collezioni molto di avanguardia si ha quasi l’impressione che facciano tutti la stessa cosa, però in alcuni c’è un ordine, una ragion d’essere, in molti altri c’è invece solo un’insalata mista che non si può definire moda, non c’è una linea. Come marchio Swatch qualche volta siamo sollecitati a non essere troppo ordinati, troppo nei binari, il lavoro degli artisti ci consente di realizzare questo con “lettere di nobiltà”: il gesto di un artista legittima anche la più provocatoria delle posizioni. Swatch è un marchio che ha un grande successo perché vive sempre su un binario doppio: una costruzione perfetta dal punto di vista qualitativo informata da una cultura diversa, più aperta al mondo, ai mondi per meglio dire. È così che il marchio deve vivere: un caos da cui nasce un ordine.
Swatch e La Biennale. Quale significato in termini di immagine e di contenuto esprime questo saldissimo sodalizio?
Credo sia un mattone importante nella costruzione della relazione tra Swatch e il mondo dell’arte. In primo luogo perché è chiaro che ci dona una visibilità che non è semplicemente quella del logo. L’idea dello sponsor che mette semplicemente il logo infatti non ci appartiene assolutamente, è una missione che ci è addirittura negata, perché noi viviamo di creazione di contenuti. La bellezza del rapporto con la Biennale è che ci consente, pur essendo un partner commerciale, di creare del contenuto. In questo devo dire che c’è del merito da entrambe le parti, perché se è vero che noi avevamo contenuto da creare, è altrettanto vero che nella gestione del presidente Baratta si è fatto un grosso passo in avanti in questa direzione connettiva. Il primo anno chiaramente c’è stata una assunzione di rischio da parte della Biennale, che ci riservò uno spazio in fondo alle Gaggiandre. Lì abbiamo realizzato un progetto meraviglioso. Quella prima partecipazione ha ottenuto un ottimo apprezzamento, per cui dall’anno successivo siamo entrati di fatto all’interno degli spazi dell’Arsenale. Quella con La Biennale di Venezia è una collaborazione che gestiamo in maniera discreta e rispettosa ed essendo arrivati ormai alla sesta edizione è chiaro che a questo punto c’è un vero racconto, una storia da poter restituire senza soluzione di continuità. Tra l’altro questa è una storia un po’ anomala per il marchio, perché se Swatch possiede un elemento distintivo è proprio l’incostanza; il concetto di base che connota la nostra progettualità è infatti da sempre “innovazione e sperimentazione”. C’è una frase celebre di Nicolas George Hayek, inventore e fondatore di Swatch, che dice: «L’unica nostra coerenza è l’incoerenza». Questa presenza in Biennale forse è l’unica eccezione a questa nostra granitica regola, unitamente al Festival di Locarno a cui siamo molto affezionati sia in termini di contenuti che di appartenenza geografica.