
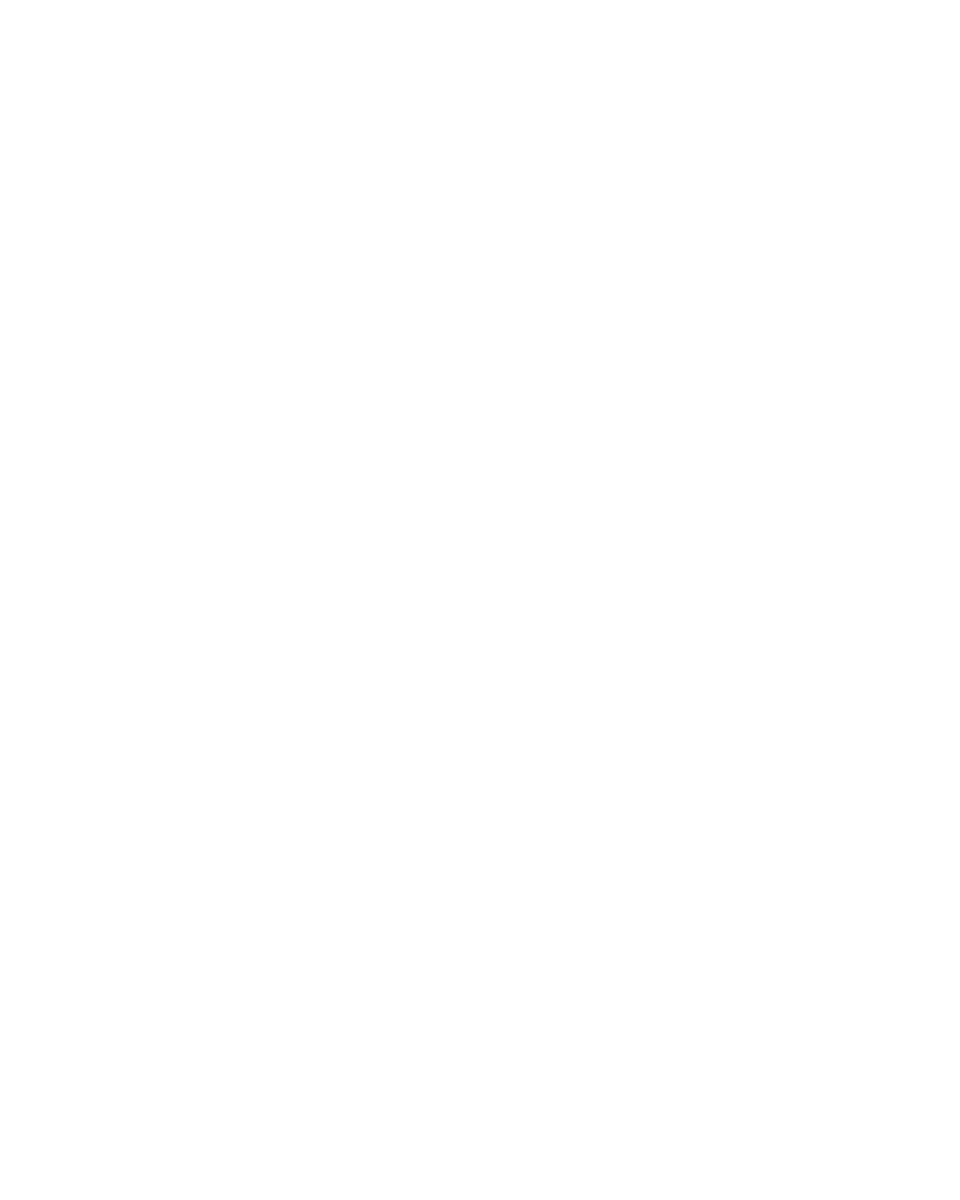
Abbiamo avuto il privilegio di visitare la mostra Extraction/Abstraction con Edward Burtynsky, facendoci guidare dentro le sue spettacolari e monumentali fotografie, lampi di bellezza che fissano gli effetti dell’agire umano sul nostro Pianeta.
Ampia retrospettiva, fortemente voluta da M9 – Museo del ’900 per la visione che offre sul nostro contemporaneo, dedicata ai quarant’anni di carriera del grande artista canadese Edward Burtynsky, il cui lavoro si concentra sull’impatto ambientale del sistema industriale sul nostro Pianeta. Curata da Marc Mayer, già direttore della National Gallery of Canada e del Musée d’Art Contemporain di Montréal, con progetto allestitivo di Alvisi Kirimoto, la mostra BURTYNSKY Extraction/Abstraction propone oltre 80 fotografie di grande formato, 10 murales ad altissima definizione, un’experience di realtà aumentata e un’inedita sezione, chiamata Process Archive, che mostra gli strumenti e le fotocamere usate negli anni da Burtynsky nel corso della sua instancabile navigazione intorno al mondo, inclusi quei droni che gli hanno permesso di allargare ulteriormente l’obiettivo delle sue fotocamere. Le sue grandi fotografie si presentano a un primo sguardo come affascinanti e indecifrabili campiture di colori e di forme astratte, che lasciano il pubblico sospeso di fronte a oggetti naturali o antropici spesso non immediatamente intellegibili, eppure in grado di attrarlo nel cuore delle opere di cui sono elementi connotanti. Abbiamo avuto il privilegio di visitare la mostra con Edward Burtynsky, facendoci da lui guidare dentro le sue spettacolari e monumentali fotografie.
È l’industria oggi, quindi, l’elemento dominante del nostro vivere, forza usurpatrice sulla natura stessa.
Le sue immagini sono un pugno nello stomaco e un lampo di bellezza assoluta. Un dualismo molto netto. Da dove è partito e quale l’esito ultimo della sua ricerca?
Più che bella in sé, per me l’opera deve risultare innanzitutto coinvolgente e deve saper toccare temi universali. Sin dall’inizio della mia carriera sono sempre andato alla ricerca di insediamenti industriali di enormi dimensioni in giro per il mondo: le più grandi miniere, le più grandi fabbriche, le più grandi cave… Lavorare su siti di così ampie dimensioni richiede un grande lavoro di ricerca. Dato il punto di partenza, è un processo che può richiedere mesi, a volte anni, prima di trovare le risposte, le soluzioni giuste. Bisogna capire cosa possa essere visivamente davvero persuasivo e come poter riuscire a raccontare una storia coinvolgente usando una macchina fotografica. Il mio obiettivo è rivelare, non accusare. Mostro posti che la maggior parte delle persone non avrà mai l’occasione di visitare di persona e che sono fondamentali per mantenere il nostro stile di vita moderno.

Le sue fotografie fissano in modo lucidissimo gli effetti dell’agire umano, ma gli uomini compaiono raramente o sono troppo piccoli per essere notati. Un’assenza che diventa immanenza. Quale pensiero sottende questa sua scelta?
Raramente ho restituito ritratti coi miei scatti. Nelle occasioni in cui appaiono persone queste sono lì per dare il senso delle proporzioni del soggetto principale della fotografia. È una specie di inversione del principio del sublime di Turner, ove la Natura era considerata la forza maggiore di tutte. Oggi è l’industria a schiacciare, a sovrastare gli uomini grazie a delle dimensioni gigantesche dagli uomini stessi definite e sviluppate. È l’industria oggi, quindi, l’elemento dominante del nostro vivere, forza usurpatrice sulla natura stessa. La mia vicinanza al mondo naturale è al contempo profondissima sin da quando ero ragazzo, per cui anch’essa, la Natura, non può che ricoprire un ruolo centrale nelle mie immagini assieme a queste incursioni umane/industriali, relegando in una collocazione visiva residuale l’uomo. Penso che questo punto di vista ci aiuti a fermarci e a pensare a cosa abbiamo davvero davanti agli occhi e a che cosa stiamo davvero facendo. Per me queste immagini vogliono essere degli spunti di riflessione per un dibattito più approfondito sull’impatto che collettivamente produciamo sul mondo naturale.
Le sue “incursioni industriali su larga scala” le hanno permesso di affrontare un viaggio straordinario e al contempo drammatico attraverso l’inesorabile e lento declino del nostro Pianeta. Cosa l’ha impressionata di più? È ancora possibile un cambiamento di rotta?
Tra i luoghi che più di altri hanno lasciato un profondo segno nella mia interiorità e nel mio segno artistico i siti di smantellamento delle navi in Bangladesh occupano una posizione di prima rilevanza. Al loro cospetto, non potrò mai dimenticare quella livida sensazione di aver viaggiato indietro nel tempo e di aver visto qualcosa che solo Charles Dickens avrebbe potuto magistralmente restituire due secoli dopo: il senso di pericolo, la durezza, il caldo, il tetro, la sconsolante precarietà dell’abitare simili contesti. Il tutto accompagnato dalla difficoltà di ammettere, di accettare che quei posti erano nient’altro che il risultato di un’attività umana. Un altro sito che mi ha lasciato interdetto per opposti motivi è stato il complesso delle antiche foreste nell’isola di Vancouver, in Canada. È altrettanto incredibile pensare che quei luoghi facciano parte del nostro mondo: la loro bellezza è al di là della comprensione umana per la forza, la varietà, la maestosità che sprigionano con disarmante naturalezza. Sono luoghi come questo, luoghi che ancora non sono stati macchiati dal progresso umano, che mi danno la speranza che siamo ancora in tempo per cambiare rotta. C’è ancora così tanta natura da proteggere!
Ho sempre cercato di evitare il termine “estetica del disastro” perché la maggior parte delle cose che fotografo non sono “disastri” in sé, ma il normale modo di procedere dell’attività umana.
Siamo stati affascinati dal dittico Salt Encrustations #2 & #3, Lake Magadi, Kenya, 2017, tanto che una parte di esso è stata scelta per la copertina del numero di giugno di Venews. Che cosa rappresenta per lei l’elemento acqua e l’azzurro come colore che ricorre enfatizzato nell’ambiente e in alcuni particolari di oggetti naturali o artificiali fotografati?
L’acqua è sicuramente sempre stata un elemento centrale del mio lavoro. L’acqua rappresenta insieme vita e distruzione, bellezza e devastazione. Nel dittico Salt Encrustations #2 & #3, Lake Magadi, Kenya, 2017 l’acqua è ritratta in questa dualità: sia come forza di vita che come elemento foriero di trasformazioni ambientali. L’eccezionale paesaggio del lago Magadi, con quelle sue incredibili formazioni di sale, racconta di cambiamenti geologici ed ecologici formatisi grazie all’azione di quello che è elemento più di ogni altro essenziale per la vita terrestre, segnatamente qui attraverso la sua evaporazione. Non so se sia un’attrazione conscia, ma il colore blu è certamente protagonista centrale nel mio lavoro. È più di un elemento visivo: simbolizza il delicato equilibrio tra la bellezza naturale e le conseguenze dell’attività umana. Blu è il colore che vediamo quando guardiamo oceani e cieli aperti; dà un senso di tranquillità, purezza, vitalità. Eppure nel mio lavoro il blu serve anche a ricordarci della fragilità degli specchi d’acqua. Le sfumature di blu che si trovano in oggetti naturali o artificiali sottolineano l’interconnessione esistente tra industria e ambiente. Ci ricordano che ciò che facciamo ha delle conseguenze sulla natura, spesso preoccupanti, talvolta bellissime. Spero che queste immagini facciano riflettere su quella che è oggi la nostra relazione con l’elemento acqueo. L’acqua è una risorsa essenziale per la vita e il nostro impatto su di essa è sempre più invasivo grazie allo sviluppo incontrollato delle nostre attività industriali.

Nelle sue fotografie anche ciò che è brutto e dannoso per l’ambiente sembra a dir poco affascinante, generando un effetto straniante di stupore in chi guarda. Non teme che una ricerca “alterata” della verità delle immagini, seppur solo da un punto di vista estetico, possa comunque indurre a relativizzare il problema ambientale in virtù di una predominanza della solennità della pura visione?
Ho sempre cercato di evitare il termine “estetica del disastro” perché la maggior parte delle cose che fotografo non sono “disastri” in sé, ma il normale modo di procedere dell’attività umana. Tantomeno considero le mie fotografie come una ricerca “adulterata” della verità. Questi paesaggi sono stati fotografati in modo identico a come li si vede ad occhio nudo e benché sicuramente io cerchi di creare opere che abbiano una loro estetica e che siano pure belle, non penso che questo sia assolutamente in contrasto con lo stimolare l’attenzione e l’empatia del pubblico. Sono le qualità estetiche a rendere attraente l’arte, ciò che ci fa fermare e godere in questo caso di una fotografia; è in questi momenti di osservazione empatica che finalmente capiamo più in profondità cosa sta succedendo al Pianeta.
Quando riguarda le sue foto stampate ad alta definizione, anche a distanza di tempo, le è mai capitato di trovare nuove ispirazioni o di vedere i soggetti o gli oggetti fotografati e studiati precedentemente allo scatto, grazie all’ausilio di nuove tecnologie, in una nuova luce, trovando nuovi significati a cui prima non aveva pensato?
Non so se ho mai trovato nuovi significati in vecchie immagini dopo esserci tornato sopra ad anni di distanza. Sicuramente è successo più volte, anche nelle prime settimane di lavoro all’atto di rivedere il ripreso e di guardare i provini, che abbia notato alcuni dettagli che in un primo momento non avevo del tutto compreso o anche solo colto, specialmente nei casi di fotografia aerea. Questo è uno dei processi elaborativi che più mi attraggono della gigantografia: voglio che tutte queste immagini siano viste nelle dimensioni che sono loro proprie, così come le vediamo in M9 – Museo del ’900. In mostra c’è proprio un esempio di questi momenti di sorpresa: in Salt Ponds #3, Near Tikat Banguel, Senegal, 2019 quei motivi grigio scuri a forma di piuma che accerchiano lo stagno sono in realtà migliaia e migliaia di orme di piedi lasciate al momento della raccolta del sale. Un dettaglio che si può cogliere solo attraverso una visione ravvicinata dell gigantografia.