
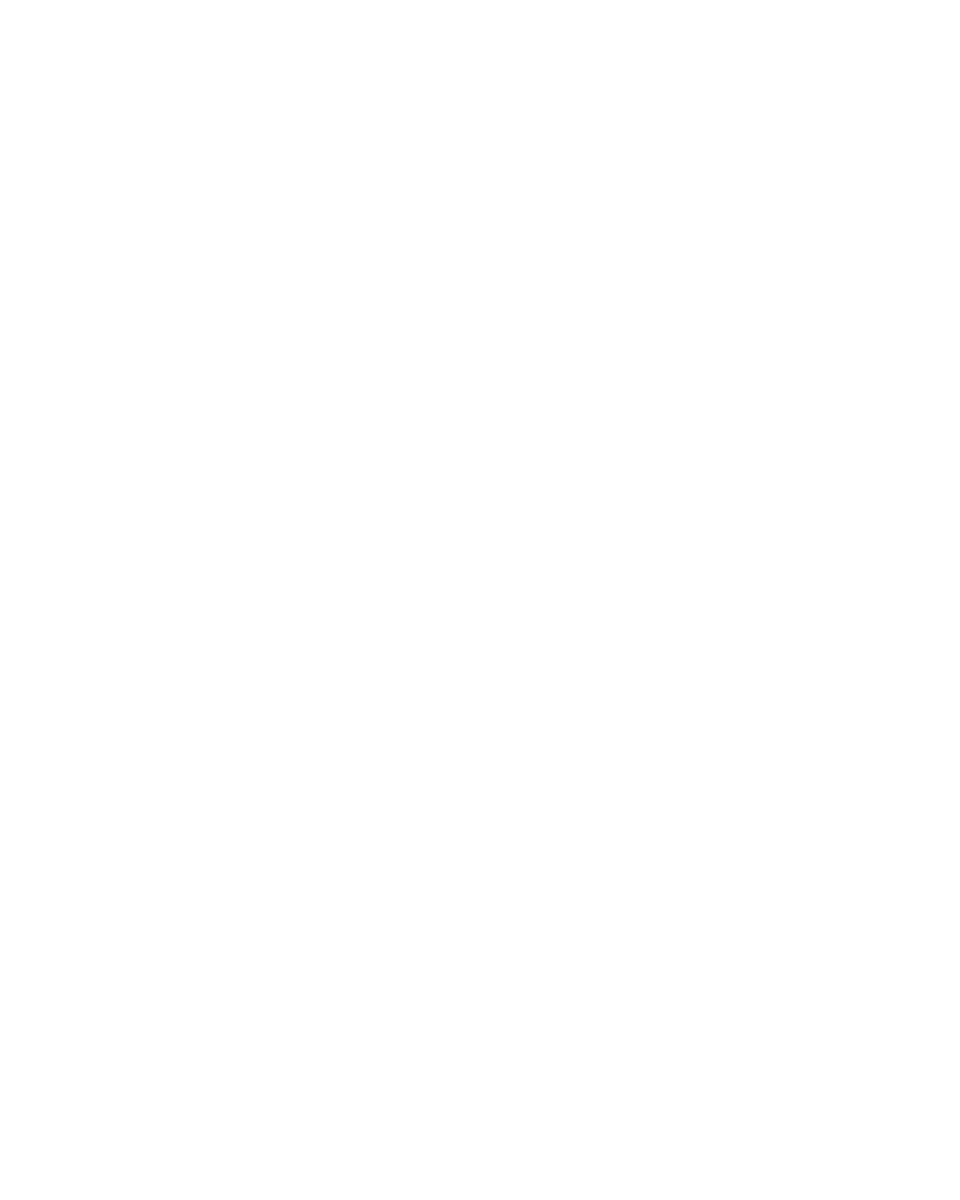
Dopo un anno di meditato, lieve “inserimento” nel segno dell’osservazione e dello studio, Pietrangelo Buttafuoco incomincia a segnare a suo modo il nuovo percorso della Biennale da lui presieduta. Ce ne parla in questa intervista.
Ciò che mi ha sorpreso e colpito è stato in realtà quello che io speravo ci fosse e che ho pienamente trovato: una vera “bottega”, nel senso rinascimentale del termine
Dopo un anno di meditato, lieve “inserimento” nel segno dell’osservazione e dello studio, Pietrangelo Buttafuoco incomincia a segnare a suo modo il nuovo percorso della Biennale da lui presieduta. Lo fa innanzitutto all’insegna della parola, del verbo, utilizzati con un respiro intensamente filosofico al fine di restituire il senso profondo delle scelte curatoriali e dei contenuti che nei diversi suoi settori questa sua Biennale sta costruendo nei mesi a venire. Non ci troviamo di fronte a un canonico manager della cultura chiamato a scegliere e a coordinare una squadra di curatori, collaboratori, tecnici con la testa innanzitutto alla gestione, ai numeri, che rimangono naturalmente nodali in una grande macchina della cultura quale è questa straordinaria Istituzione, unica nel suo genere per la molteplicità dei linguaggi artistici che è chiamata ad esprimere. No. Certo, si occuperà lui e chi per lui anche di questo, naturalmente, ci mancherebbe. Ma Buttafuoco a prima pelle sembra innanzitutto impegnato nel riuscire a farsi interprete della profondità, della densità culturale che connota questo complesso marchingegno della contemporaneità, preoccupandosene a tal punto in positivo da farsi, per così dire, quasi curatore aggiunto delle varie mostre e festival che la Biennale propone. Naturalmente in forma laterale, niente affatto invasiva, costruendo un suo personalissimo valore aggiunto a ciascuno dei vari segmenti culturali che nel loro insieme compongono il mosaico composito della Biennale, tessendo un sottile filo tra le varie discipline artistiche dei distinti settori. In questa direzione ci pare, nel poco tempo che ha sin qui consumato nella sua veste di Presidente, aver interpretato e fatto sua in maniera assai originale la vocazione fondativa della Biennale, ossia quella di leggere e rielaborare i mille fermenti che le arti seminano nella contemporaneità.
Alla vigilia dell’apertura dell’attesissima 19. Biennale Architettura l’abbiamo raggiunto a Ca’ Giustinian per una breve ma intensa chiacchierata, cercando di fare un punto su quanto sin qui svolto e cercando al contempo di intuire le effettive, rinnovate direzioni che durante il suo mandato intenderà percorrere.
È passato poco più di un anno dal suo insediamento nelle vesti di Presidente della più importante istituzione culturale italiana e non solo. Quale è il primissimo bilancio che si sente di stilare sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista personale, umano?
Il primissimo bilancio dal punto di vista del lavoro svolto non mi sento ancora pienamente in grado di farlo, nel senso che sono più che altro in una posizione di attesa, o meglio, di responsabile attesa. Credo quindi sia molto più giusto che siano gli altri a stilarlo, eventualmente, questo primo bilancio sul breve percorso fin qui intrapreso.
Dal punto di vista umano, invece, sono non solo assolutamente soddisfatto, ma direi proprio rapito da questa meravigliosa esperienza, perché ho avuto l’occasione unica di confrontarmi con dei colleghi che mi hanno accompagnato ad un livello ulteriore di formazione, di conoscenza, di apprendimento. Questo mi ha infuso un grande, autentico entusiasmo.
Quale è il tratto che più l’ha colpita, sorpresa, di questa macchina culturale eclettica, poliedrica come nessun’altra, e quali conferme invece l’hanno più rassicurata rispetto alle aspettative che aveva maturato dal momento in cui ha ricevuto questo altissimo incarico?
Ciò che mi ha sorpreso e colpito è stato in realtà quello che io speravo ci fosse e che ho pienamente trovato: una vera e propria “bottega”, nel senso rinascimentale del termine, compiutamente coerente con l’orizzonte contemporaneo. Una bottega intesa come luogo dove la multiforme costruzione delle varie discipline va in un’unica direzione, che è quella di offrire a noi, al nostro tempo, una prospettiva per decifrare, interpretare, indirizzare l’evolversi del contesto in cui viviamo e operiamo.
Ciò che mi attendevo, invece, era innanzitutto di avere a disposizione un giacimento di materiali di memoria che potessero essere utili per riconnettere, per riprendere il filo di un discorso molto spesso affidato a specialismi, e che è invece materia viva potenzialmente per chiunque abbia il piacere di immergersi nel caleidoscopico mondo della cultura. In questo gioca un ruolo fondamentale una città quale è Venezia, che, a differenza di tanti altri meravigliosi centri urbani del mondo, nella sua unicità ha saputo accuratamente evitare di diventare un ircocervo a metà tra l’essere un museo o l’essere una Disneyland e l’ha saputo fare anche e soprattutto attraverso le sue istituzioni culturali. Una città che, grazie alla sua straordinaria vivacità culturale, rimane a tutt’oggi coerente con il proprio genius loci.
È un continuo centro studi a disposizione degli altri. Anche la massa, la gran massa di turisti che quotidianamente qui arriva, ha la possibilità spontanea di trasformarsi in un insieme curioso di visitatori e quindi di poter usufruire di tutte le ricchezze di questa città. È come un impollinare, come una primavera continua: si viene qui e ci si interroga sul perché di questa bellezza e sul come questa comunità nel tempo abbia saputo sfidare la natura e costruire questa eccezione.
Chi arriva e si ritrova sotto la pioggia, accanto alla persona amata, si bacia. Chi arriva, davanti ad un bellissimo tramonto si lascia attraversare da un verso, da una poesia; chi arriva e si stordisce o si perde nella sua urbana trama labirintica, trova innanzitutto sé stesso e poi, basta innescare la curiosità, la città è lì a offrirsi.

Ogni presidente ha naturalmente un suo stile, un suo approccio nell’affrontare il proprio lavoro, nel raccontare e restituire il percorso complesso e concentrico che un’istituzione come la Biennale necessariamente, e costitutivamente direi, disegna giorno dopo giorno con i suoi festival, le sue mostre, le sue versatili attività. Come vede, come inquadra lei l’attività, il ruolo di una figura così delicata e complessa quale è quella di Presidente della Biennale di Venezia?
Spugna, mi sento spugna, perché mi piace assorbire e quindi contenere tutto ciò che mi ritrovo ad assorbire, per poi a poco a poco rilasciare l’essenza, o meglio, la quintessenza di un agire, di un costruire espressione di un’armonia obbligata col territorio, con la storia di questa città, con le sue sensibilità e con il suo sfacciato vantaggio. Faccio i conti con una realtà quale è Venezia che inevitabilmente in punto di fascino, in punto di carisma, in punto di magnete quale essa è, attrae intorno a sé le suggestioni e le sfumature di un racconto tutto da costruire.
Non so se vi sia o meno uno stile attraverso il quale raccontare questa istituzione. So che si racconta da sé, perché se vado a ripercorrere i 130 anni della storia de La Biennale è affascinante già di per sé il suo solo principiare. Nasce per una precisa esigenza, ossia quella di far confrontare questa città, dove tutto il mondo si dà appuntamento, con la praticità del consumo dell’arte, quindi con la necessità di mettere insieme domanda e offerta tra chi ama l’arte, chi la sa produrre, chi la sa contenere, chi sa dare cornice ad essa. E quindi in questi 130 anni di storia attraversare con lucidità e passione i capitoli di questo romanzo in perenne divenire, averne consapevolezza, credo sia compito dell’istituzione più che del suo presidente.
Sapete qual è la cosa che mi affascina particolarmente? Si tratta di uno dei primi aspetti attorno ai quali mi sono confrontato con i colleghi, che nel frattempo, se posso permettermi, sono diventati amici: l’interrogarsi sul perché, avendo tutti noi avuto esperienze altrove, qui si mantiene sempre questo entusiasmo nell’etimo della parola proprio, quindi questa capacità di uscire fuori, di venirne fuori e di posizionarsi fuori, rielaborando interiormente quello che intorno si crea. Vi è un aspetto immateriale e magico nella parola stessa “biennale”, che come la settimana enigmistica è foriera di un’infinità di imitazioni e che però a volerla studiare, a volerla architettare, è impossibile da immaginare.
Una cosa che di tanto in tanto sento il bisogno di fare è quella di ritrovarci tutti quanti, tutti noi che lavoriamo qui, nella Sala delle Colonne; mi sento di farlo man mano che in cantiere si incubano delle idee nuove, anticipandole, e quindi condividendole, con chi qui lavora, nel segno dell’ascolto reciproco, del confronto vivo. È veramente bello il transitare all’interno di queste stanze, l’incontrarsi, e siccome io sono spugna cerco sempre di catturare attimi, spunti, opinioni.
In questi mesi è apparsa chiara la sua disposizione a costruire in prima persona nuovi contenuti culturali. Ne è un esempio altissimo ed eloquente a riguardo la riuscita messa in scena del Commento al Vangelo di Giovanni di Johannes Eckhart al Portego delle Colonne della Scuola Grande di San Marco. Uno spettacolo trasversale, non ascrivibile pienamente ed esclusivamente a uno dei sei linguaggi espressivi della contemporaneità di cui la Biennale si occupa, attraversandone più di uno di essi insieme, quasi a disegnare, per come è stato concepito e proposto in quanto sintesi di più registri espressivi tra musica, teatro, narrazione, speculazione mistica e filosofica, una nuova, ulteriore direzione possibile da percorre da qui in poi nel già ramificato delta espressivo della Biennale. Qualcuno addirittura ipotizza la creazione di un nuovo settore in cui incasellare progetti come questo, una sorta di Biennale della Parola. Cosa ci può dire a riguardo? Come intende assecondare e consolidare questo nuovo percorso appena avviato?
Partiamo da un fatto concreto, l’ASAC. Il nostro archivio è un assoluto gioiello, non fosse altro per il fatto di essere giacimento di memoria di materiali, di documentazione. È un vero e proprio centro studi attivo a disposizione del pubblico, a disposizione degli artisti, a disposizione di chi ha visione, per sperimentare nuovi territori. E la parola è un canone, un ben preciso tassello, su cui siamo chiamati tutti a interrogarci. L’esperimento dell’Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem è stato un capitolo ancora una volta entusiasmante partorito da questo straordinario laboratorio culturale che è la Biennale. Posizionandoci fuori da noi stessi, abbiamo verificato come questo tentativo di catturare un capolavoro della grande letteratura teologica tedesca in lingua latina sia stato in grado di arrivare diritto al pubblico in maniera spontanea, senza le farraginose macchinazioni degli eruditi, divenendo un fatto d’arte davvero a disposizione di tutti.
Indubbiamente è un’ulteriore direzione, questa, che Biennale segue, cerca, esplora. Una ricerca incessante di nuove modalità espressive che rappresenta poi la vera bellezza dell’Istituzione: non essere vincolati a schemi rigidi, ma essere sempre come dei sensori alla scoperta di territori inesplorati. Un processo, un percorso, che attraverso l’operazione di Eckhart ci ha rafforzato in questa direzione, dandoci ulteriore consapevolezza della necessità costitutiva nel nostro agire di indagare nuovi orizzonti espressivi ai confini delle arti. E la Biennale della Parola, se così vogliamo chiamarla, con questo progetto rappresenta un nuovo, vitale tassello di questo caleidoscopico epicentro della contemporaneità. In questo incessante processo di rielaborazione e creazione espressiva la parola è importante naturalmente anche per documentare, per restituire su carta la teoria amplissima di riflessioni, di studi che stanno alla base della produzione artistica contemporanea, perché il pubblico della Biennale non è solo fatto di visitatori, ma anche di appassionati ed attenti lettori. Da qui, allora, la decisione di ridare vita alla storica rivista della Biennale di Venezia dopo 53 anni dalla sua ultima uscita, progetto di cui siamo profondamente orgogliosi.

In una città che è immersa nella storia, nel suo immenso e meraviglioso passato, il vostro ruolo è quello di produrre nuova storia per il futuro, all’altezza di quanto Venezia ha saputo costruire nei secoli. Come intende tenere attivo e vivo il rapporto con la storia di un’istituzione costitutivamente vocata al domani? C’è un vostro progetto, o più estesamente una vostra disposizione che restituisce questa relazione in termini vivi?
Credo che questa complessa e però affascinante relazione tra la cifra contemporanea del nostro lavoro e la grande storia che ci circonda e ci assorbe in ogni attimo del nostro esistere qui possa essere espressa in maniera intrigante ed eloquente da un importante anniversario storico appena consumatosi, vale a dire i 700 anni di Marco Polo. Una ricorrenza di rara valenza storica che non abbiamo in alcun modo lasciato galleggiare alla deriva del calendario passato, trasformandola viceversa in un seme in grado di generare progetti futuri, ripercorrendo le tappe del viaggiatore veneziano attraverso lo schema di lettura dell’arte contemporanea, che consente all’Istituzione di uscire fuori dai propri confini e di incontrare il futuro, il mondo. Nelle ore in cui la storia si è rimessa tumultuosamente in cammino, attraverso la rielaborazione di questa grande epopea storica Venezia e La Biennale sono presenti in quella immensa distesa accanto a noi, in quel continente Euroasiatico che racconta la giovinezza, le risorse energetiche, le prospettive di futuro, l’evoluzione, la tecnologia, laddove viceversa, in un’altra parte di mondo, tutto ciò sembra ritrarsi. Essere connessi con questi orizzonti pulsanti rappresenta un vantaggio certamente per l’arte, ma anche, e non suoni questo come una bestemmia, un effettivo vantaggio per l’economia e il commercio, perché sappiamo perfettamente che laddove si muove l’istinto dell’arte, lì c’è il senso stesso di un cambiamento, della capacità di appropriarsi di un passaggio storico ben definito. Quando si parla di Rinascimento, esso va sempre inteso in un senso circolare: quindi arte, ma anche scambi economici, trasformazione del lavoro; insomma, ancora una volta botteghe, sì, magari digitali, ma sempre botteghe del fare, dell’elaborare nuove idee, mestieri, prodotti.
La Biennale Architettura si annuncia come un’edizione che supera gli steccati della disciplina per confrontarsi sui terreni più attuali delle nuove emergenze, attraverso una visione allargata alle diverse discipline scientifiche ed elaborata attraverso i nuovi linguaggi della contemporaneità, digitali, virtuali. Sembra che Carlo Ratti con la sua Biennale voglia cogliere l’opportunità per ridefinire e riconsolidare la dimensione aperta e concentrica che fa dell’architettura tra tutte le discipline progettuali quella più intersecata con le altre forme espressive del pensare e dell’agire umano. E al contempo voglia indagare e consolidare il ruolo della Biennale stessa nel contesto di un aperto dibattito internazionale. Essendo stata la sua prima selezione curatoriale questa di Carlo Ratti, che ha compiuto all’alba di questo suo percorso presidenziale in condivisione col suo predecessore Roberto Cicutto, ci può brevemente illustrare quali sono state le ragioni fondanti alla base di questa scelta?
Con Roberto Cicutto abbiamo deciso insieme di investire di questo importante ruolo Carlo Ratti perché lui, con la sua formazione, la sua professionalità e anche la versatilità con cui riesce a dialogare con le altre discipline, va incontro a un’esigenza che è quella propria della scienza, orizzonte verso il quale l’architettura, e con essa l’idea dell’organizzazione urbanistica, non ha stranamente sviluppato appieno sino ad ora la propria sperimentazione.
Io ho avuto modo di verificare, per esempio, i suoi lavori sull’aerospazio. Bene, mi sono sembrati davvero un disegnare, nel loro insieme, un ulteriore passo in avanti di una disciplina così aperta e porosa quale necessariamente deve essere l’architettura. E mai come oggi vi è bisogno di un’architettura capace di dialogare con le nuove scienze, i nuovi linguaggi, digitali e non, che stanno rivoluzionando il nostro esistere quotidiano.
La sua definizione di Intelligens.
Le api sono intelligenti e credo che dal punto di vista dell’intelligenza naturale, artificiale, collettiva rappresentino un insieme direi proprio urbanistico, e compiuto, da studiare. L’urbanistica delle api, così come i loro moduli abitativi, rappresentano l’assoluta intelligenza. E qui siamo dentro un contesto che è quello della organizzazione razionale degli spazi. La stessa cosa si può dire dei castori, i quali sono dotati di un’abilità unica nel fabbricare delle inespugnabili dighe. Quello che, e qui entra in campo il mio punto di vista privato, personale, differenzia noi umani da loro è innanzitutto la nostra capacità di determinare catastrofi, errori, così come di fronteggiare questioni molto più grandi di noi e, quindi, apparentemente insormontabili. Vi faccio un esempio: se solo avessimo modo di visionare filmati nel momento in cui si consuma un sisma, non nelle città, ma nella natura, subiremmo un effetto perfino tranquillizzante, perché vedremmo gli alberi scuotersi, agitarsi, le acque incresparsi, diventare onda e infine, a poco a poco, il tutto resettarsi in una placida consapevolezza dell’atto che fu e di ciò che da esso ne è derivato. Ma noi non siamo solo intelligenza, siamo anche spirito, errore, ricerca. E nel passaggio che abbiamo compiuto nella storia dell’umanità dal riparo all’edificio, alla domus, abbiamo messo in discussione tutto il nostro sforzo di consegnare parte dell’intelligenza ad esigenze ulteriori, che sono quelle perfino di prosopopea decorativa, ma nell’essenza – e la filosofia contemporanea ci aiuta tantissimo da questo punto di vista – ridotta alla tripartizione obbligata di “Costruire Abitare Pensare” (Martin Heidegger).
La mia definizione di intelligenza, dunque, è soltanto quella di un primo stadio necessitante, che si distingue dalla sola razionalità e include “spirito” e “errore”.

DMT ha appena presentato i tre attesissimi festival del 2025 che vedono l’esordio di ben due nuovi direttori, la star hollywoodiana Willem Dafoe per Biennale Teatro e la giovanissima Caterina Barbieri per Biennale Musica, e un terzo invece confermato, Wayne McGregor per Biennale Danza. Tre festival tutti in qualche modo, e a modo proprio, impregnati della tensione dei tempi in cui ci troviamo a vivere, decisi a interrogarci, a coinvolgere anime e corpi, in scena e in platea, scandagliando ogni angolo, anche il più recondito, del fare arte, dell’esprimere azioni e idee nella convinzione che solo liberando le menti si possa davvero arricchire di senso vivo, di umanità fuori da ogni scorciatoia consolatoria e banale il nostro presente. Programmi ricchissimi e a dir poco caleidoscopici. Cosa si attende di nuovo quest’anno da questi tre fronti interconnessi del fare arte e che cosa si auspica che il pubblico possa ricevere e dare, osmoticamente, a queste svariate proposte in scena?
Per quanto riguarda Wayne McGregor, Sir Wayne McGregor, io rispondo sulla base dell’esperienza dello scorso anno. Sapete cosa ho notato? Pubblico giovane, giovanissimo, ma soprattutto, di volta in volta, dopo ogni spettacolo cui ho assistito me ne sono uscito fuori con una precisa idea, o per meglio dire, con una precisa sensazione: quella di avere assistito a qualcosa che rappresentava un privilegio, una fortuna, che ha indistintamente accomunato tutti coloro i quali hanno potuto vedere, direi di più, partecipare a quella straordinaria edizione del Festival di Danza 2024 di Wayne McGregor. Meraviglioso, perché in scena si andavano a definire espressioni che nessuno riesce anche solo a immaginare. So che Sir Wayne McGregor è quella cosa lì, l’ho visto, l’ho sperimentato, quindi quest’anno sarà ancora più intrigante assorbirne le idee nella loro corporea rivelazione.
Mi sono confrontato attivamente con tutti e tre i direttori; non vi nascondo che è, questo, il mio vero punto debole, perché la mia vera natura è quella di essere doppio: da un lato libraio, dall’altro capocomico. Quello che chiedo a tutti e tre è di fare bottega, di essere un laboratorio continuo. Non è nicchia, non deve essere e tutto sarà tranne che nicchia: sarà un moltiplicare questo effetto di privilegio. Non saranno spettacoli per pochi eletti conoscitori delle discipline, assolutamente no. Quindi sarà un privilegio, ve lo posso sin d’ora garantire, per il pubblico assicurarsi il biglietto, acquistarlo, sedersi, godersi degli spettacoli che resteranno nell’immaginario, nella storia.
Bisogna davvero uscire dalla dimensione autoreferenziale, e direi tribale, delle nicchie elettive. Guardo ad esempio sempre con trasporto e ammirazione questa locandina de Il Mercante di Venezia di William Shakespeare, andato in scena nel 1934 per il Primo Convegno Internazionale di Teatro nell’ambito della 19. Biennale di Venezia. Io vengo dal mestiere, ma quando leggo tra gli interpreti Carlo Ninchi, Guido Riva, Marta Abba, Andreina Pagnani, Luigi (Gigino) Almirante, Renzo Ricci, Amedeo Nazzari, con la regia di Max Reinhardt e le musiche di Victor De Sabata, penso che davvero questa è e deve essere ancora oggi Venezia, la Biennale. Vedete come tornano sempre, come se fossero asola e bottoni, la sua storia e il suo futuro.
C’è un’altra cosa sottaciuta che mi affascina tantissimo, vale a dire che sia Dafoe che Caterina Barbieri, che tutta la cerchia che intorno si è creata nel mettere insieme queste discipline hanno, me compreso, un comune denominatore segreto, affettuosamente segreto, poeticamente presente: Franco Battiato. Il tramite tra me e Willem è stato proprio Franco, è lui che ci ha fatto conoscere. Caterina è troppo giovane per averne avuto una conoscenza diretta, il tramite con lei è stato ovviamente una certa idea di musica e di ricerca comune. E in questa direzione vi è un altro artista ancora che ci lega, Giovanni Lindo Ferretti.
Inutile dire che ogni anno è febbrile l’attesa per le novità, per i film provenienti da un po’ tutto il mondo che la Mostra del Cinema è come sempre in grado di proporre. Un festival dalla storia immensa che tutti conosciamo, capace di crescere progressivamente di anno in anno in più direzioni, non solo in quella delle mere proposte filmiche. Ci sono ulteriori novità anche proprio in termini strutturali quest’anno, vedi su tutti i nuovi ingressi alla Sala Darsena. Ha in mente anche qui qualche mossa smarcante?
La risposta è già nella domanda. Nuovi tasselli ci saranno, non facciamo altro che cercare nuovi tasselli. Poi qualcosa è già uscito, ci sarà un nuovo rito, nel senso che le cerimonie avranno un respiro diverso. Può essere che mi ritroverò a dover dismettere per un attimo l’abito di presidente per… Ma non anticipiamo nulla di più, è tutto in fase di vitale costruzione.
Non potevamo non finire con Venezia, città bellissima ma, come un diamante, dalle mille sfaccettature non tutte della stessa luminosità. Quale è stata la sua percezione iniziale di questo piccolo-grande villaggio globale?
Di liberazione. Mi sono liberato dalla dimensione di Luciano Bianciardi ne La vita agra.
Io vivo, e ne sono consapevole, l’assoluto privilegio di stare a Venezia, affacciato sul Canal Grande e, quando torno a casa, mi ritrovo nella valle di Proserpina in Sicilia. Qui c’è l’acqua e lì la terra, dove l’unico mare è di grano. Percepisco la mia vita come polarizzata, vivo questa dicotomia. Quindi tra questi due poli di assoluta bellezza, tutto quello che sta in mezzo mi sembra superfluo, non lo considero.