
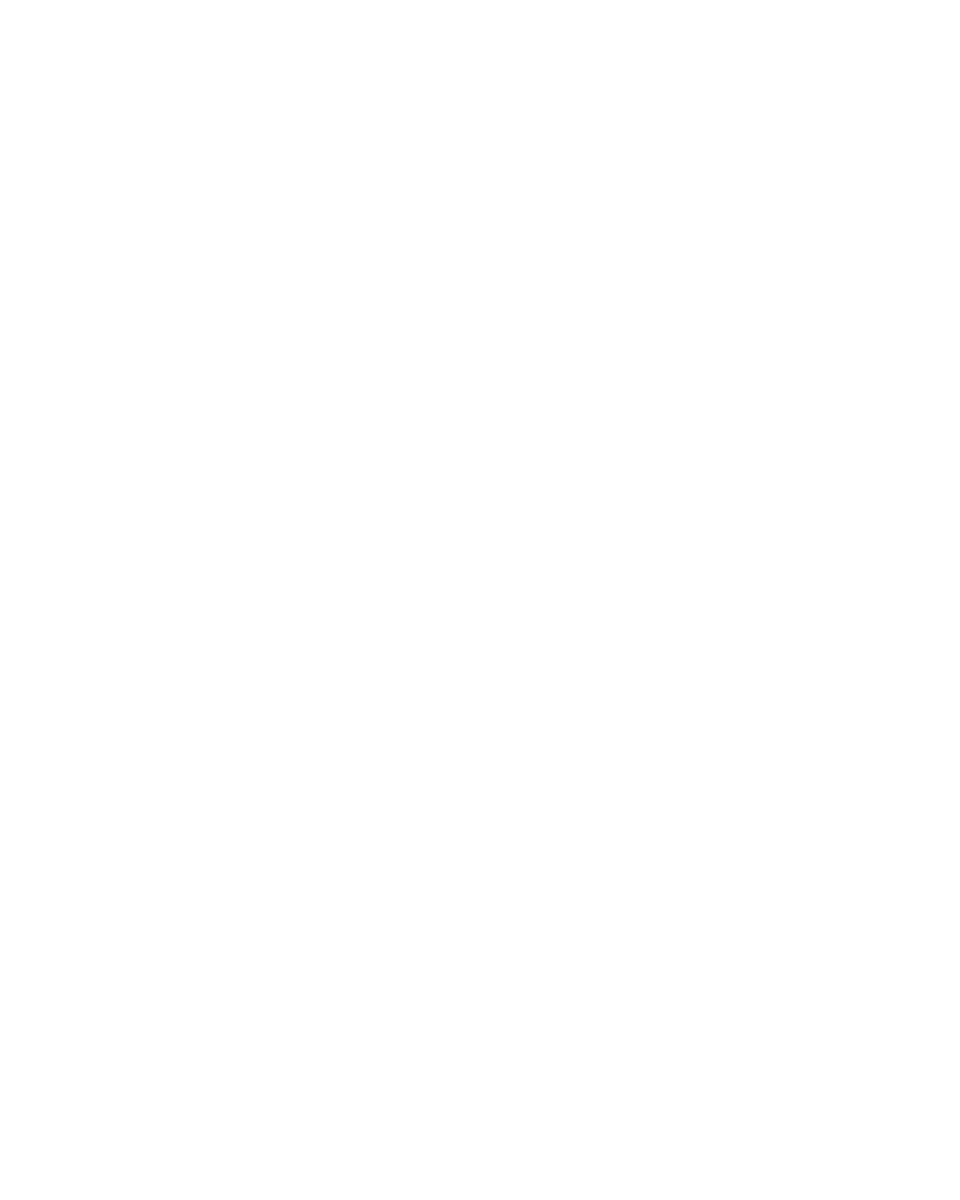
«In un momento storico, come questo, in cui la tecnologia ci permette di vedere quello che succede dall’altra parte del mondo in tempo reale e in modo dettagliato, dobbiamo chiederci, come mai prima, dove stia l’umanità e come possiamo accedervi in una più profonda connessione con il nostro corpo». Wayne McGregor racconta la sua Biennale Danza.
Lo spettacolo dal vivo si fonde con le tecnologie emergenti più innovative e la danza non fa eccezione. Fenomeno non nuovo, ricordiamo Merce Cunningham con il suo Biped (1999), realizzato con la tecnologia della motion capture, ove fece interagire danzatori e ologrammi. Ultimamente ha fatto molto parlare Rothko del regista Twarkowski. Proiezioni multimediali che dialogano con i personaggi in scena in un labirintico gioco ad incastri. A Venezia nessuno meglio di Wayne McGregor, alla guida di Biennale Danza, poteva governare la sfida di questo incontro tra linguaggi. Con Random Dance (oggi Wayne McGregor Company), la sua compagnia fondata nel 1992, è senza dubbio alcuno tra i più acclamati coreografi di tutto il mondo. Random Dance è anche il titolo di un suo libro uscito nel 2014 sottotitolato La grammatica del corpo: un incontro tra danza, tecnologia e architettura. Professore di coreografia al Trinity Laban Conservatoire a Londra, è pure noto per aver creato i movimenti dei film di Harry Potter e de La Leggenda di Tarzan. Da Nam June Paik in poi di strada ne è stata fatta, ma i suoi principi mi pare permangano: la ricerca per fornire nuovi modelli per le arti che riducano la distanza con lo spettatore, o lo rendano partecipe in prima persona, e l’utilizzo della tecnologia anche nella comunicazione artistica e interpersonale. Wayne McGregor, con questa edizione intitolata We Humans, fa un passo avanti, studiando come corpo e mente sappiano interagire e influenzarsi reciprocamente e come si possa uscire da questa relazione, creando quindi movimenti non abitudinari. Siamo ora in fremente attesa del suo prossimo libro, Thinking with the Body.
Questo è il suo ultimo anno del mandato quadriennale come direttore di Biennale Danza. Quali obiettivi può considerare raggiunti con successo e, se ve ne sono, quali ancora da raggiungere?
Dunque, volendo cominciare dai successi, direi l’aver portato la Biennale Danza a rivestire un ruolo attivo nella commissione di nuove creazioni: oggi, attraverso bandi nazionali e internazionali, non ci limitiamo più a portare ‘semplicemente’ gli artisti a Venezia, ma finanziamo concretamente il loro lavoro. Cerchiamo di investire a tutti i livelli di questa professione, che si tratti di avere a che fare con giovani emergenti o piuttosto con artisti di grande esperienza internazionale. In questo senso la Biennale è co-commissaria. Così facendo abbiamo veramente cambiato il modo in cui gli artisti si rapportano con la Biennale Danza; ho avuto modo di confrontarmi e di scoprire idee molto interessanti tra le persone che vogliono parteciparvi. Allo stesso tempo, per noi è di fondamentale importanza riuscire a produrre spettacoli che altrimenti non si potrebbero in alcun modo realizzare. Anche questo è un obiettivo raggiunto, così come lo è Biennale College. Una delle cose più belle del College è vedere cosa succede a questi giovani artisti dopo che hanno concluso l’esperienza qui con noi. Li possiamo guardare partire equipaggiati di una nuova sicurezza nelle loro capacità di fare grandi cose guardando alla vita futura. Ci teniamo in contatto con tutti gli ex allievi e parliamo di cosa stanno facendo, andiamo a vedere i loro spettacoli, alla fine diventano parte della tua comunità che continua ad estendersi ed espandersi: c’è uno scambio continuo, ciascuno segue e partecipa al lavoro dell’altro. Due degli ex allievi del College sono ora parte della mia Compagnia e sono convinto che questa ‘palestra’, questo metodo così intenso di coltivare talenti, che solo la Biennale ha saputo individuare e realizzare, sia davvero straordinario. Parlando di obiettivi non proprio raggiunti, invece, penso a come possiamo ampliare il modello College per coltivare e aver cura dei talenti su un orizzonte temporale più lungo, coinvolgendo artisti professionisti. Cosa si potrebbe fare con più risorse? Magari un laboratorio di coreografia in funzione tutto l’anno? E come possiamo lavorare con gli artisti in modo che non restino qui da noi solo tre settimane in estate per il Festival, rimanendo invece in residenza più a lungo per lavorare ad un progetto più complesso ed articolato, capace di produrre un’influenza critica, essenziale e positiva non solo nel mondo della danza italiano? Molti giovani produttori hanno bisogno di concreto sostegno, dal momento che oggi come oggi non ricevono risorse e aiuto necessari per creare e sostenere una compagnia di proiezione internazionale, in modo da avere trazione nel lungo periodo. Come espandere questa bolla? Come avere più portata? Questa nostra aspirazione, più che un insuccesso, la ritengo una cosa che sarebbe semplicemente bellissimo poter realizzare.

Forse è vero in parte, forse no, ma sto scrivendo un libro sugli ultimi dieci anni della Biennale Danza. Un capitolo comincerà con «Wayne McGregor Direttore della Biennale Danza di Venezia». Come potrei continuare?
È sempre una sfida quando si chiede a un artista di ricoprire il ruolo di direttore di un festival, perché subito ci si immagina che la persona coinvolta includa nei vari programmi annualmente elaborati solo lavori che in qualche modo hanno a che fare col proprio mondo, con il proprio circuito. Una cosa che ho provato nel mio specifico a fare è di considerare il mio lavoro personale al minimo nella mia esperienza qui in Biennale. Ho cercato al contrario di mantenere una visione aperta a 360 gradi e di pensare ai miei valori in relazione a una comprensione filosofica della danza, o a un’estensione della nozione di ciò che la danza può essere o dell’impatto che la danza ha sul mondo. Tutto ciò, però, visto attraverso la lente del lavoro artistico di qualcun altro. Ho continuato a lavorare per portare a Venezia persone che non ci si sarebbe mai aspettati di vedere qui. Stiamo facendo crescere la Biennale a partire dal cuore. Un altro aspetto forse meno visibile ma altrettanto importante è il rapporto che si viene a creare con gli artisti, avere l’opportunità di conoscerli e di farsi conoscere da loro. Il mio punto di partenza era un po’ diverso: non era espressione, derivazione di un incarico meramente professionale, ma piuttosto della curiosità assoluta per le creazioni degli altri un po’ in tutto il mondo, di un modo di infondere coraggio ad altri artisti. Non dobbiamo sentirci in competizione gli uni con gli altri; anzi, ognuno può sostenere l’altro. Ognuno ha un modo diverso di lavorare e possiamo sempre rispettare le ragioni altrui. Il valore e l’importanza di ciascun lavoro si rifrange se messo accanto ad altre opere interessanti. Per concludere, spero che il dialogo tra le diverse opere che ho scelto aiuti il pubblico a ridefinire cosa sia possibile fare con la danza e far loro capire che la danza si evolve e si espande sempre. Questo è quanto spero. Ma sarai tu a scriverlo, quindi la visione sarà la tua.
Spero che il dialogo tra le diverse opere che ho scelto aiuti il pubblico a ridefinire cosa sia possibile fare con la danza e far loro capire che la danza si evolve e si espande sempre
Cristina Caprioli, Leone d’Oro alla carriera di questa edizione, nel 2012 organizzò il simposio Weaving Politics sul rapporto tra coreografia, diritti umani e violenza, che ebbe una risonanza internazionale e scosse il mondo della danza. È un’attività questa praticabile e percorribile ordinariamente per la Biennale Danza a Venezia?
Sì, certo. Cristina ha tenuto in piedi la sua compagnia qualunque cosa accadesse e si è interfacciata con la politica sia ad alti che a bassi livelli. Il suo è un lavoro molto riflessivo e non sempre di intrattenimento. Non le interessa questo secondo aspetto e io rispetto la sua scelta. Penso che la dimensione politica e l’incisività e la capacità di riunire, di connettere che ha saputo esprimere con così peculiare forza sia davvero un risultato meraviglioso. Ne parleremo, parleremo di cosa possiamo fare per lei qui a Venezia, di cosa succederà in quel mondo. È una grande intellettuale e una grande provocatrice Cristina Caprioli, sì.
Mi ha sorpreso un commento di Cristina Caprioli stessa: diceva che i coreografi ormai devono produrre i loro spettacoli in base a quanto il pubblico vuole vedere. Bisogna stare sul mercato, certo, ma non l’avevo mai inteso in questo modo. È pericoloso?
La situazione sta peggiorando per gli artisti, perché le risorse sono poche e molti committenti chiedono alle compagnie di restare su spettacoli di provato successo, oppure inevitabilmente si interrogano su cosa piacerà alla gente. Non si possono proporre creazioni troppo intellettuali o troppo rigorose. In qualche modo, insomma, una certa censura culturale esiste già a livello di commissione e questo rappresenta oggi decisamente un problema. Penso che Cristina intenda dire che il nostro lavoro non è quello di intrattenere il pubblico, quindi non dobbiamo pensare al pubblico in questo perimetrale senso. Quando dietro a un lavoro vi sono un rigore e uno scopo che vanno ben oltre il dato del puro intrattenimento la sfida è molto più grande e penso che a lei sia capitato nella sua carriera che quella tenacia e quel rigore siano stati trascurati a favore di qualche progetto più ‘sicuro’. Quindi sì, credo anch’io che esista il pericolo che tutto ciò che si va producendo corra il rischio di rimanere ingabbiato nella logica artisticamente asfittica di un mero e luccicante intrattenimento e che il rigore della danza, il processo di profondo scavo elaborativo che dovrebbe informare le sue produzioni, vengano messi in secondo piano da progettualità che è più facile far piacere. Vale per tutti. È anche responsabilità dei critici assicurarsi di valorizzare con il giusto e congruo peso progetti talvolta veramente belli di puro intrattenimento e di grande successo – va benissimo e piacciono anche a me – in rapporto allo spazio di ampio e profondo respiro che richiederebbe la lettura e l’interpretazione dei lavori di quegli artisti che cambiano sul serio i paradigmi di questo linguaggio espressivo, perché è solo cambiando i paradigmi che l’arte evolve. Il nostro lavoro con la danza deve evolvere, così come il nostro modo di pensare. Se non saremo in grado di farlo rimarremo bloccati in una comfort zone che non farà il bene di nessuno, perché intrattenere attraverso la rassicurazione del già fatto, prodotto e visto equivale a rimanere fermi volgendo le spalle al futuro…
La situazione sta peggiorando per gli artisti, perché le risorse sono poche e molti committenti chiedono alle compagnie di restare su spettacoli di provato successo, oppure inevitabilmente si interrogano su cosa piacerà alla gente. Non si possono proporre creazioni troppo intellettuali o troppo rigorose. In qualche modo, insomma, una certa censura culturale esiste già a livello di commissione e questo rappresenta oggi decisamente un problema. Penso che Cristina intenda dire che il nostro lavoro non è quello di intrattenere il pubblico, quindi non dobbiamo pensare al pubblico in questo perimetrale senso. Quando dietro a un lavoro vi sono un rigore e uno scopo che vanno ben oltre il dato del puro intrattenimento la sfida è molto più grande e penso che a lei sia capitato nella sua carriera che quella tenacia e quel rigore siano stati trascurati a favore di qualche progetto più ‘sicuro’. Quindi sì, credo anch’io che esista il pericolo che tutto ciò che si va producendo corra il rischio di rimanere ingabbiato nella logica artisticamente asfittica di un mero e luccicante intrattenimento e che il rigore della danza, il processo di profondo scavo elaborativo che dovrebbe informare le sue produzioni, vengano messi in secondo piano da progettualità che è più facile far piacere. Vale per tutti. È anche responsabilità dei critici assicurarsi di valorizzare con il giusto e congruo peso progetti talvolta veramente belli di puro intrattenimento e di grande successo – va benissimo e piacciono anche a me – in rapporto allo spazio di ampio e profondo respiro che richiederebbe la lettura e l’interpretazione dei lavori di quegli artisti che cambiano sul serio i paradigmi di questo linguaggio espressivo, perché è solo cambiando i paradigmi che l’arte evolve. Il nostro lavoro con la danza deve evolvere, così come il nostro modo di pensare. Se non saremo in grado di farlo rimarremo bloccati in una comfort zone che non farà il bene di nessuno, perché intrattenere attraverso la rassicurazione del già fatto, prodotto e visto equivale a rimanere fermi volgendo le spalle al futuro…

Per una mia personale curiosità sto contando quanti spettacoli su Maria Callas sono stati prodotti quest’anno. Sono almeno undici soltanto in Italia. Con la continua riproduzione di opere d’arte l’aura, l’immaginazione si perdono. Penso che con la danza ciò non possa avvenire perché ogni rappresentazione è diversa e che è per questo, quindi, che forse questo linguaggio espressivo può piacere più di altre forme d’arte. Qual è il suo parere a riguardo?
Penso sia molto difficile fingere nella danza. Può capitarti di leggere o sentire fake news, ma quando sei in un teatro e hai qualcuno davanti a te che deve eseguire un pezzo in tempo reale la trasmissione è qualcosa di assolutamente diretto. Mi piace l’idea che nella danza questo non si possa sostituire. L’altra cosa che mi ha colpito è la tua domanda sulla diversità di ogni rappresentazione grazie alla spontaneità dei danzatori nel decidere come esprimersi in tempo reale: ma come riusciamo a percepire, a decifrare ciò? Questa sarà la domanda identificativa per il futuro. Come percepiamo Cristina Caprioli oggi? Come una creatrice che prende decisioni in tempo reale, non è un video quello che stiamo guardando. Ma come fa? Credo che la tecnologia giochi un ruolo molto interessante nel riuscire a catturare l’essenza di una persona. Potrebbe farlo attraverso un sistema di intelligenza artificiale che va oltre la forma, ma cos’altro succede nel momento in cui qualcuno danza o recita e questo qualcosa li rende te? Quel loro essere te, il tuo stesso essere te: cos’è mai tutto questo? Penso sia una domanda molto interessante. Quando andiamo a vedere dei danzatori bravissimi, e anche quando li conosciamo bene, stiamo sempre guardando una versione rifratta di loro. Non vediamo mai la stessa versione; proprio come nella vita, anche col nostro compagno o i nostri migliori amici non vediamo mai la stessa versione di loro. Certo, alcune abitudini e altre disposizioni rimangono simili, ma la trasmissione tra individui non è mai la stessa e a un qualche livello lo percepiamo, vi reagiamo, e lo facciamo perché è così che la verità arriva. È molto difficile da nascondere. Ma non è un dato che interessa però solo la danza; penso, per fare un esempio su tutti che tutti ci coinvolge mediaticamente ogni giorno, che anche nella dimensione politica ci sia una grande differenza tra essere nella stessa stanza con un’altra persona o parlare in videoconferenza o, ancora, mandarsi una mail. La presenza dal vivo, che sia in forma mediata o che sia teatro dal vivo, ma potrebbe essere anche nella sanità, per dire, è davvero fondamentale perché vi è così tanta alterità attorno a te che solo rapportandovisi tangibilmente puoi trasmettere una tua verità, la tua essenza in sostanza. La presenza è l’unico modo per generare empatia con qualcuno. Quando si genera empatia si riesce a raggiungere un livello mentale superiore. È questo il potere della danza, che è poi il potere di ogni forma di comunicazione corporale.
La presenza è l’unico modo per generare empatia con qualcuno. Quando si genera empatia si riesce a raggiungere un livello mentale superiore. È questo il potere della danza, che è poi il potere di ogni forma di comunicazione corporale
Stiamo assistendo a nuove modalità di cultura visuale: Berger, Freedberg, Perconte e Pierre Huyghe ora a Punta della Dogana. Come hanno influenzato questi studi il mondo della danza e dove ritroviamo queste riflessioni nel programma 2024? L’interazione tra danza e tecnologia può generare nuove forme di espressione?
Sì, anche qui ci sono diversi insiemi di conoscenza che si intersecano. E in queste intersezioni nascono nuove idee. Cloud Gate, come anche Nicole Seiler, quest’anno mettono in scena intelligenza artificiale e performance dal vivo. Per fare un altro esempio, grazie a Véréna Paravel e Lucien Castaing-Taylor con l’epico documentario De Humani Corporis Fabrica ci ritroviamo seduti all’interno di un’installazione video con sette schermi che ci permettono di guardare l’interno di altre persone: non possiamo non commuoverci davanti alla materialità del nostro corpo, alla sua fragilità, vedendo gli organi che abbiamo dentro; un corpo che appartiene a tutti noi. La condivisione è un valore assoluto. Un altro aspetto da considerare della tecnologia, in questo senso, è che può mettere in luce parti del corpo che altrimenti non avremmo mai visto, spostando così la nostra immaginazione su un nuovo piano. La creatività in realtà è molto tecnologica. Mi stimola e mi incuriosisce interfacciarmi con la tecnologia in quanto strumento a servizio della creatività; non quindi in quanto elemento che vada a sostituire il tocco umano nelle nostre creazioni, ma piuttosto in quanto agente dinamico in grado di amplificarlo o di accrescerlo, forse anche di sfidarlo. Ho scelto determinati artisti e spettacoli per questa Biennale che mi auguro siano in grado di condurci verso una qualche verità, combattendo con ogni arma appropriata il falso, anche se riconoscere il falso è sempre impresa improba. Anni fa ho prodotto uno spettacolo a Londra con gli ABBA in forma di avatar. Non erano reali, non erano veramente gli ABBA, il pubblico ballava con una creazione puramente digitale, però si comportava come se stesse ballando con loro. Sentivano una connessione empatica con la tecnologia, quella stessa tecnologia che in tanti dicevano non poter essere capace di generare empatia. Esiste un mondo in cui possiamo lavorare con la tecnologia per creare un fenomeno essenzialmente umano. Non parlo di generare musica o generare danza, non è questo il punto. È un’altra cosa e ha a che fare con l’essere speciali.