
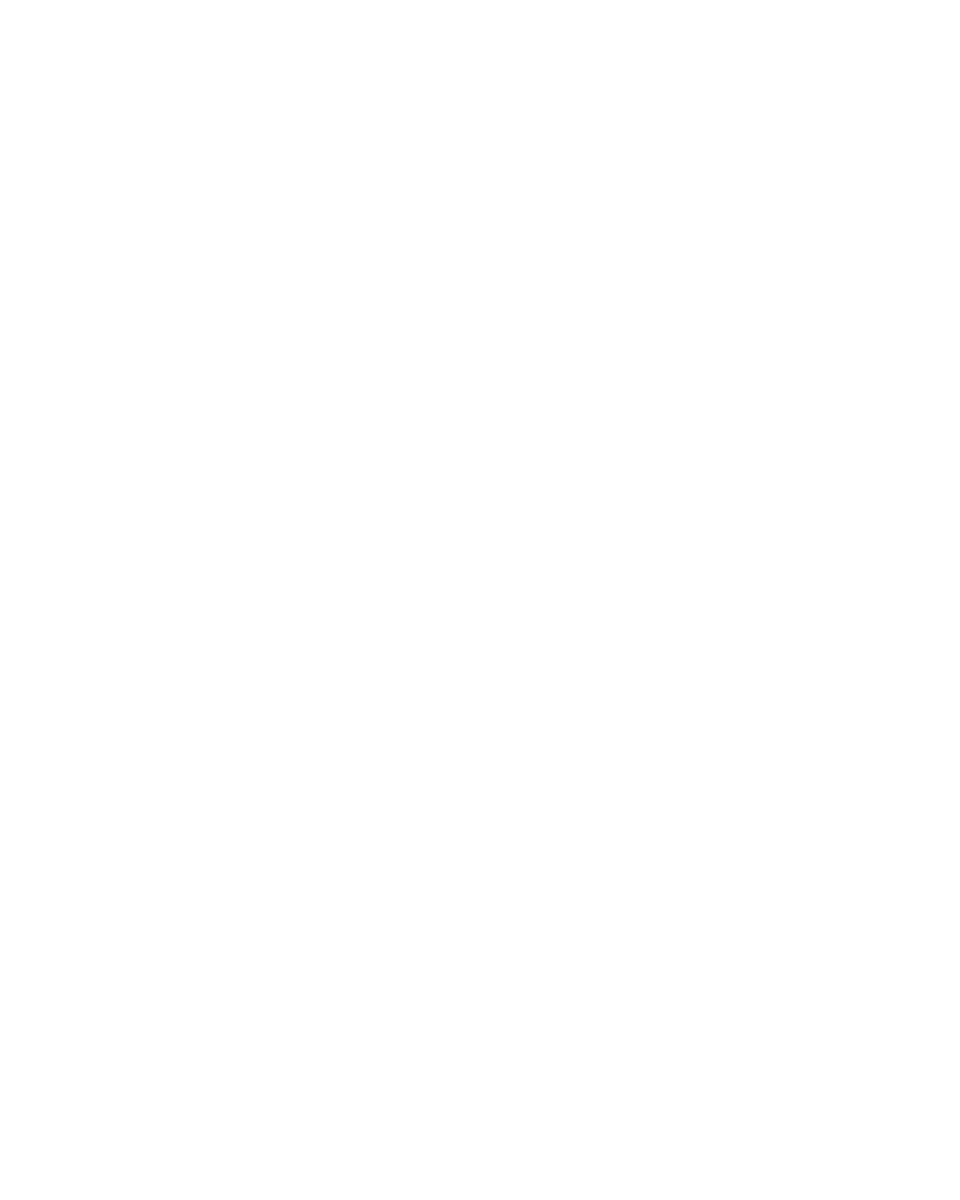
A Venezia con lo spettacolo Creation (Pictures for Dorian) e con l’installazione Elephants in Rooms a Forte Marghera, il collettivo – o meglio “la gang” – si racconta in questa intervista. Il 16 giugno a Ca’ Giustinian ricevono il Leone d’Argento.
Quando interagiamo con pubblico e passanti… li solleviamo e li presentiamo come le vere star dell’evento, come dei preziosi objets trouvés
Gob Squad, Leone d’Argento della 52. Biennale Teatro. La motivazione scritta dai direttori Stefano Ricci e Gianni Forte è senza mediazioni: «per essere tra i più profondi, poetici, politici, innovativi artisti del linguaggio teatrale nel mondo». Un collettivo, anzi una “gang”, si definiscono così i sette membri fondatori del gruppo nel lontano 1994 a Nottingham, poi stabilitisi a Berlino. Il loro teatro non vive solo in palcoscenico, ma in qualunque luogo della vita quotidiana ed è caratterizzato da una ricerca incessante dell’incontro con l’Altro. Un’importante critica tedesca Barbara Behrendt così scrive a riguardo: «dietro la cortina delle banalità si nascondono verità filosofiche… una scuola di empatia che fa del suo meglio per capire la vita di un’altra persona». L’occasione era la loro performance Is Anybody Home, ove una persona banalmente incontrata veniva invitata a salire sul palco su un grande letto, mentre alcuni attori esploravano il suo appartamento cercando dettagli della sua vita o talvolta di immedesimarsi nei suoi pensieri attraverso gli oggetti trovati. In ogni loro spettacolo il contatto con il pubblico, per quanto faticoso, è ricercato incessantemente. Nel loro testo programmatico, Joined Forces Audience Participation in Theatre Performing Urgencies, dichiarano esplicitamente: «Il diciannovesimo secolo è stato il secolo degli attori, il ventesimo fu il secolo dei registi, il ventunesimo è quello degli spettatori».
A Venezia vedremo Creation, tratto da The Picture of Dorian Gray, una riflessione sul passare del tempo, sulla morale e la morte, sulla bellezza come moneta, valore che si vorrebbe preservare, che invece «è come un fiore e non si può conservare se non congelandolo, cioè facendolo morire». L’altro allestimento, Elephants in Rooms, visibile tutti i giorni del Festival a Forte Marghera, è un percorso attraverso quattordici stanze di artisti provenienti da ogni parte del mondo girato durante la pandemia e nella conseguente reclusione in casa, ove la finestra restava l’unico sguardo sul mondo esterno. Con simpatia ed empatia li intervistiamo.

Quest’anno tagliate il traguardo dei trent’anni di attività insieme, davvero molti. Quale la molla che vi spinge a continuare la ricerca, il contatto sicuramente faticoso con il pubblico, mettendo in atto in qualche modo una continua provocazione al fine di riflettere profondamente sullo stato del mondo?
La risposta più semplice è che dobbiamo farlo. Il mondo è un posto confuso, pauroso, emozionante e magico. Fare arte è il modo migliore per processare il modo in cui reagiamo al suo cospetto, il modo per dire al nostro pubblico «noi la pensiamo così e ci sentiamo così, e voi?». L’altra cosa che ci permette di andare avanti è che siamo una squadra, un collettivo. Ci diamo man forte e siamo presenti l’uno per l’altro quando serve. Possiamo condividere tutto, il bello e il brutto, l’allegro e il triste, provando a restituire questo nostro vissuto al nostro pubblico creando situazioni il cui scopo è innanzitutto condividere emozioni. Mostriamo che non siamo soli.
L’opera non è completa senza spettatore. Per questo assegniamo al nostro pubblico una parte attiva nelle nostre produzioni; sono liberi di entrare nell’immagine loro stessi se vogliono.
Abbiamo letto con molto interesse il vostro testo del 2016 e siamo in attesa di sentire/vedere Creation (Picture for Dorian). Continuate a ritenere vera l’affermazione che il nostro sarà il secolo non più degli attori e dei registi, bensì degli spettatori?
Nella prima parte di Creation (liberamente ispirato dal personaggio per eccellenza di Oscar Wilde, Dorian Gray) abbiamo impostato una relazione triangolare tra artista, opera d’arte e spettatore. Un artista può creare l’opera più profonda in assoluto, ma ha bisogno che qualcuno la guardi perché possa avere un qualche impatto o significato nel mondo. L’opera non è completa senza spettatore. Per questo assegniamo al nostro pubblico una parte attiva nelle nostre produzioni; sono liberi di entrare nell’immagine loro stessi se vogliono. Le nostre opere devono essere accessibili, non chiuse. È per questo che le portiamo lì dove c’è la gente: per strada, in stazione, nei negozi… Coi nostri lavori più recenti abbiamo prestato grande attenzione a chi sedeva tra il pubblico, a chi insomma guardava il nostro lavoro. Chi, invece, ha scelto di non venire? E come possiamo cambiare le cose? Una possibile risposta è uscire dalla nostra bolla e cercare di portare queste persone sul palcoscenico e creare insieme a loro, accompagnandole nel cuore del progetto, permettere loro di raccontare le proprie storie con parole loro.

Guardando i vostri lavori viene naturale pensare al Living Theater o, che so, a Andy Warhol. Ma forse è un’associazione superficiale… Nel corso di questi anni quali sono stati i punti e gli spunti di riflessione che avete ricavato da altri autori?
Andy Warhol è stato certamente una nostra fonte di ispirazione, sì. Abbiamo scritto interi pezzi sui suoi primi film, quelli della serie su attività di vita quotidiana come Eat, Haircut, Kiss, Sleep, Kitchen, Screen Tests… Li abbiamo rifatti come spettacolo dal vivo: Gob Squad’s Kitchen (You’ve never had it so good). In questo “film dal vivo” ci sostituiamo gradatamente a membri del pubblico, che a loro volta ci sostituiscono sulla scena. È un film che ha bisogno di pubblico per esistere. Ci piaceva molto la definizione, la creazione, da parte di Warhol, del termine “superstar”, che poteva applicarsi a chiunque frequentasse la Factory all’epoca. Non erano per forza persone con un qualche talento o formazione specifici, ma semplicemente individui dotati di una certa allure che a Warhol piaceva mostrare davanti alla cinepresa. A noi di Gob Squad piace innalzare il concetto, la dimensione del banale e del quotidiano. Questo desiderio ha sempre informato i nostri lavori, sin dall’inizio. Quando interagiamo con pubblico e passanti proviamo a rielaborare a modo nostro esattamente quanto si faceva alla Factory: li solleviamo e li presentiamo come le vere star dell’evento, come dei preziosi objets trouvés. Oltre a Warhol, siamo stati ispirati da molti altri scrittori, film, video pop e artisti nel corso degli anni, tra cui:
Maggie Nelson, On Freedom e The Argonauts a proposito di libertà, cura, giustizia e identità.
Emma Kay, Worldview, sullo scrivere di storia.
Naomi Klein, This Changes Everything, No Logo, a proposito di ecofemminismo e su come salvare il futuro.
Sheila Heti, How should a person be, Motherhood, sulle contaminazioni tra memoria, finzione e filosofia.
Ian McEwan, Saturday, Machines Like Us, sul progresso tecnologico, l’intelligenza artificiale e i problemi morali che sollevano.
David Byrne, True Stories (film, 1986) e Stop Making Sense dei Talking Heads.
Victor Fleming, The Wizard of Oz (film, 1939).
A noi di Gob Squad piace innalzare il concetto, la dimensione del banale e del quotidiano.
La finestra è un simbolo che ricorre nelle creazioni di grandi poeti e scrittori, dalla Tabacaria di Pessoa al Betrachtung di Kafka. In Elephants in Rooms che ruolo le assegnate?
Sia finestre che dipinti hanno una cornice, un rettangolo che definisce i confini di quanto può essere visto. Gli spettatori di Elephants in Rooms vedono le persone sui quattordici schermi come i personaggi di un dipinto. Le persone nel video, tuttavia, stanno lì a guardare fuori dalla finestra. Quindi gli spettatori vedono, incorniciate, persone che guardano fuori da un’altra cornice. Le finestre sono membrane tra pubblico e privato, tra ciò che si sceglie di mostrare e ciò che rimane nascosto, inaccessibile alla vista.
Non vi definite compagnia teatrale, ma piuttosto “gang”. Quali sono stati i rituali di iniziazione e di accoglimento nel gruppo?
Se decidiamo di accogliere un nuovo attore cerchiamo di metterlo a suo agio. Gli diciamo «sei qui per recitare te stesso, non un ruolo immaginario, quindi non puoi sbagliare: basta essere te stesso». Abbiamo anche una versione tutta nostra, estrema, di darci il cinque che rasenta il pericoloso. La cosa più importante per i nuovi membri è sentirsi parte del gruppo, farsi una risata insieme, andare d’accordo. Prima diventiamo amici, poi colleghi.
Ogni gruppo che si rispetti ha un totem, qual è il vostro?
C’è un vestito in paillettes dorate che abbiamo usato in molti spettacoli negli ultimi trent’anni. Non ne vuole sapere di rovinarsi e dà a chi lo indossa il potere magico di creare connessioni con pubblico e passanti. Questo vestito significa eccentricità e divertimento ed è un invito a risplendere.