
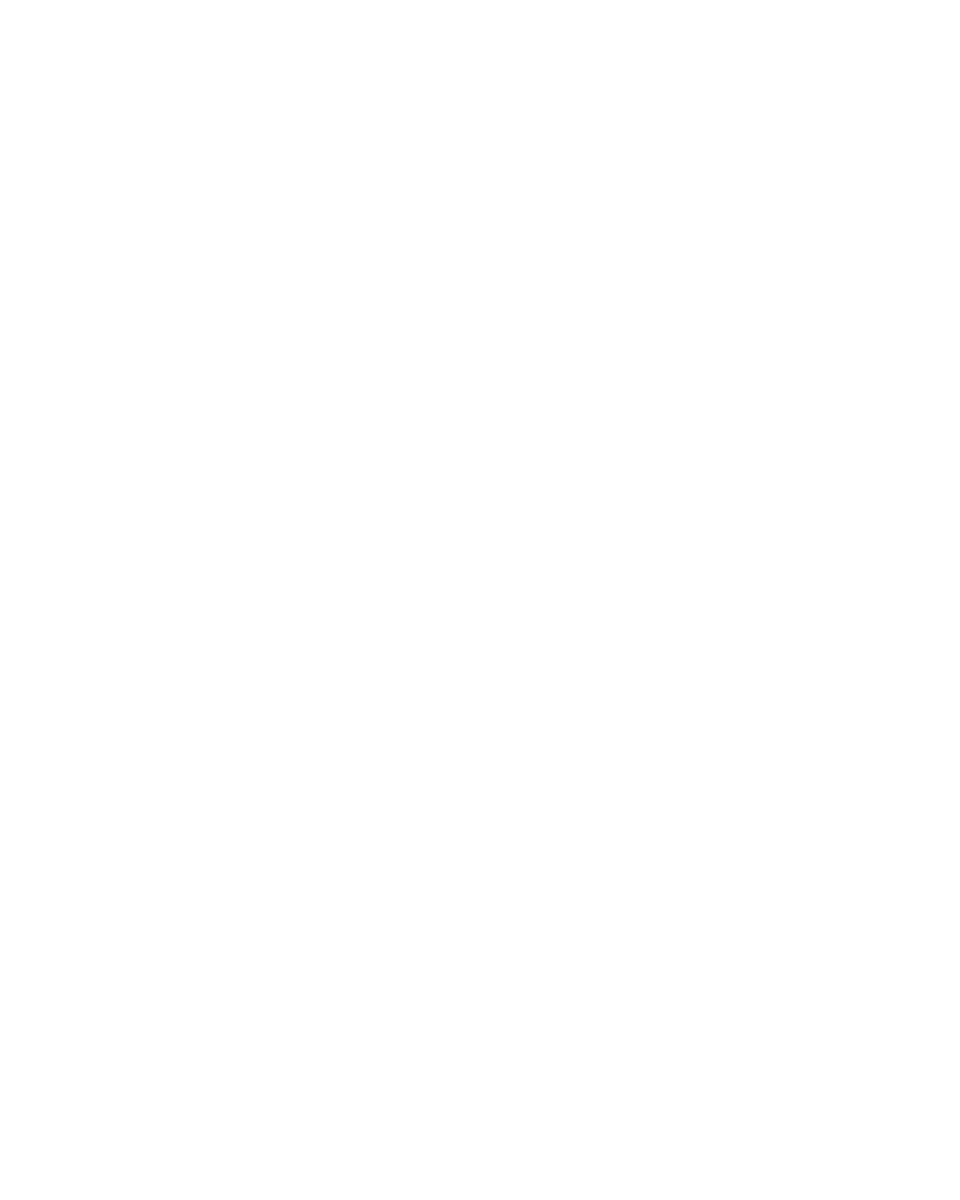
“There Was Still Time” è il titolo dello, spettacolo vincitori del bando per una nuova coreografia della 18. Biennale Danza, che Chiara de’ Nobili e Alexander Miller presentano a Venezia il 30 e 31 luglio. Preciso il richiamo ad “Aspettando Godot” per uno sguardo a futuri possibili o alla loro assenza.
Racconto danzato, così come annunciato dalla precisa scelta di campo della Compagnia, che unisce elementi di danza (urbana, contemporanea e breakdance) alla recitazione. «Le mie creazioni le immagino come dipinti che cambiano costantemente, come elementi di un puzzle» ebbe a dichiarare Chiara de’ Nobili. Inizia a ballare a quattro anni a Napoli, prima danza classica, poi danza contemporanea alla DanceHaus di Milano. Ma l’Italia le sta stretta e decide allora di trasferirsi in Israele, dove inizia a sperimentare nella coreografia. Va poi a Madrid, Montpellier, Baden e alla Palucca Hochschule di Dresda, fondata da Gret Palucca, compagna di avventura della grande Mary Wigman.
Chiara l’abbiamo incontrata e ammirata a Venezia nel 2020 con Wrad, madrina Marie Chouinard, ma già l’anno prima aveva completato il suo percorso di coreografa con Biennale College. Non rinuncia a ballare, ma il suo amore è la coreografia. Sogna una barca in mezzo all’oceano. Nelle sue pièce è notevole l’attenzione alle mani e ai piedi, anche se noi abbiamo amato il suo sorriso e la sua naturale empatia. Durante la pandemia ha stretto un sodalizio con Alexander Miller, coreografo, tra i fondatori del gruppo The Saxonz nel 2013, forse il collettivo più importante di breakdance, invitato alle imminenti Olimpiadi 2024. Dalla sua fondazione Miller De Nobili ha già dato vita a molte opere: Momento, PACK, Don’t you dare, Labyrinth. Mi piace che in ogni loro presentazione indichino sempre “in collaboration with the dancers…”. Sentiamoli.
Lo spettacolo che presentate a Venezia, There Was Still Time, viene collegato ad Aspettando Godot di Beckett. Nella pièce del grande autore irlandese i gesti degli attori si susseguono essenziali e ripetitivi. Non così nella vostra produzione. Quale dunque il collegamento? Cosa si deve aspettare il pubblico?
Beckett ci ispira per i tratti, le modalità con cui affronta i temi dell’esistenzialismo combinati al dark humour. Questi aspetti esistenziali alterano le nostre credenze: le persone non si aggrappano più all’idea di un salvatore o si considerano invincibili. Sono acutamente consci dei propri limiti nel vivere in un mondo che ricorda costantemente quanto siano costitutive queste restrizioni nel nostro abitare il tempo che ci è dato.
Il pubblico può attendersi emozioni di tutti i generi. I nostri personaggi colgono ogni occasione per giocare, battersi, amare e stuzzicarsi; tutto ciò per intrattenersi, ammazzare il tempo e combattere la solitudine data da un mondo troppo complicato. Queste idee riflettono anche le battaglie moderne contro la depressione, l’alienazione, la frammentazione – tutti temi che hanno grande risonanza in una società ossessionata dall’automiglioramento iper-accelerato e da un eccesso di individualismo.
Noi uniamo questi temi con influenze delle moderne discipline di danza-teatro e tecniche di recitazione, creando quindi un linguaggio del movimento che combina accoppiamenti dinamici tra i gesti di ogni giorno e i movimenti astratti e virtuosistici della cultura hip-hop. La nostra produzione rispecchia allo stesso modo la bellezza e la difficoltà della vita moderna, che oscilla tra momenti di frenetica attività e altri di quiete, occasioni, quest’ultimi, per prendersi una salutare pausa in cui poter meglio riflettere.
La nostra produzione rispecchia allo stesso modo la bellezza e la difficoltà della vita moderna, che oscilla tra momenti di frenetica attività e altri di quiete, occasioni, quest’ultimi, per prendersi una salutare pausa in cui poter meglio riflettere
Ricordo un incontro ai Giardini della Biennale nel 2019 dove Chiara parlava di portare in scena le azioni di ogni giorno ma esplorando i limiti tra logico e illogico, tra realtà e irrealtà. Permane questa ricerca nella produzione attuale?
La tradizione del Teatro dell’Assurdo mi ha sempre ispirato dal momento in cui co-dirigo ogni spettacolo col mio socio Alexander Miller. Il prodotto su cui lavoriamo evolve costantemente e assume forme sempre nuove, quindi la nostra esplorazione di questi temi si è nel tempo approfondita. Oggi, così come peraltro in passato, continuiamo a giocare con personaggi che esistono al limite tra reale e surreale. Questi personaggi abitano realtà inventate e le loro emozioni sono molto più intense delle nostre, eppure sono veramente umani e vulnerabili. Lasciare più spazio a questa vulnerabilità è forse l’evoluzione più importante del nostro lavoro. Il nostro obiettivo, oggi, è creare arte che rifletta la vita stessa. A entrambi piace l’assurdo e l’illogico e usare l’esagerazione come strumento per esplorare questi temi. L’azione in scena spesso sembra irrazionale, i dialoghi sono volutamente insensati e l’ordine degli eventi può sembrare arbitrario, con il nostro dark humour ad amplificare questi effetti. Però, benché il nostro interesse per l’assurdo non cambi, col tempo abbiamo capito meglio come collegare assurdità e umanità al fine di creare un’esperienza in cui il nostro pubblico possa effettivamente rispecchiarsi, riconoscersi, anziché rimanere in una posizione di puro ascolto e di pura visione per quanto aperti, ironici, ma senza un concreto coinvolgimento.

Negli ultimi tre anni è impressionante la quantità di coreografie da voi realizzate. Trovano tutte una adeguata collocazione sul mercato? Quali sono le difficoltà per una compagnia di danza oggi e quali le differenze, se vi sono, di attenzione che avete avuto modo di riscontrare nei diversi Paesi europei in cui vi siete esibiti? La campagna di crowdfunding per la nuova produzione, Labyrinth, lanciata a febbraio scorso ha dato i risultati sperati?
Il mercato della danza è saturato dal fatto che la domanda da parte del pubblico è molto inferiore alla gran quantità di lavori prodotti. Va da sé, quindi, che solo una parte di quanto viene creato ha modo poi di essere adeguatamente presentato. Come giovane compagnia è molto difficile andare in tour coi nostri lavori dopo il debutto. È anche sempre più difficile entrare in strutture e reti già esistenti. Di conseguenza, cerchiamo occasioni e format diversi per creare nuovi lavori. Concentrarci sui concorsi di coreografia ci ha aiutato a guadagnare riconoscimento a livello internazionale, soprattutto agli inizi. Andando avanti abbiamo capito meglio quali sono le vere sfide da affrontare nel lavorare in festival e teatri e abbiamo cercato di adattare a tal fine il nostro processo creativo. Il nostro ultimo lavoro There Was Still Time, ad esempio, ha una scenografia semplice, così che sia più facile portarlo in tournée. I finanziamenti sono un altro grosso problema. Ci sono pochi finanziamenti pubblici, e il fatto che nella nostra regione e altrove in Europa i governi virino verso il centrodestra rende difficile produrre i nostri lavori nelle dimensioni che desideriamo. Questa tendenza determina anche tagli a finanziamenti già esistenti e più controlli sui teatri. La danza, come tutte le arti, è vista come un lusso invece che una necessità, il che la rende particolarmente vulnerabile a queste mutazioni di visione delle politiche culturali.
Nonostante tutti questi problemi siamo stati capaci di produrre molte cose negli ultimi tre anni grazie alla nostra ambizione, al tempo speso e alla nostra rete di finanziatori qui in Sassonia. Vorremmo fare tournée più ampie, ma intanto affiniamo i nostri metodi di distribuzione. Gestire la compagnia è un lavoro a tempo pieno.
Lavorare con varie istituzioni in diversi paesi è stata un’esperienza unica. Ogni paese ci fa sentire a casa, ciascuno a suo modo, e la differenza più notevole la fa senz’altro il pubblico. È bellissimo confrontarsi con pubblici diversi, che arricchiscono il nostro lavoro con punti di vista che vengono da culture, tradizioni e strati sociali i più vari.
Il finanziamento collettivo per Labyrinth è nato in risposta alla diminuzione di finanziamenti da altre fonti. Nonostante fosse la prima volta che ci cimentavamo in un’esperienza di questo tipo, la campagna è stata un successo e abbiamo raggiunto gli obiettivi finanziari che ci eravamo posti. È stato molto stancante condurre questa attività di ricerca fondi tra una prova e l’altra, ma il tutto è stato ampiamente ripagato da una risposta a dir poco sorprendente. E rinfrancante aggiungerei. Tra i vari finanziatori vi erano sia nostri fan che persone completamente al di fuori del mondo della danza, che hanno visto il nostro lavoro e che si sono sentite così ispirate da decidere di offrirci un proprio concreto contributo. Siamo davvero molto grati di tutto questo speciale supporto.

Per PACK Maria Chiara ha lavorato con un gruppo di performer maschili in una struttura molto chiusa, unica donna a dirigere o coordinare sei uomini. Nel mondo della danza esistono ancora differenze di ruoli che interessano il genere?
Prima di tutto vorrei precisare che PACK non è ciò che sembra a prima vista. L’idea di PACK è nata ancora prima che io e Alexander cominciassimo a lavorare insieme. All’inizio, ancora quando stavamo cercando finanziamenti, Alexander voleva mettere in discussione gli stereotipi esistenti sugli uomini nel mondo della breakdance. Quando mi sono unita al progetto ci siamo concentrati sulla sensibilità, vulnerabilità, amore, giocosità, violenza, il tutto assieme ai danzatori con cui abbiamo lavorato. In definitiva intendevamo decostruire l’immagine, ancora preminente, dell’uomo come “sesso forte” per colmare almeno un po’ del divario che esiste tra i due sessi.
Nel mondo della danza, così come in molti altri ambienti, c’è ancora molto da fare per ottenere una vera, piena equità tra tutti i generi, binari e non-binari. In Germania, ad esempio, moltissimi teatri statali sono ancora prevalentemente diretti da uomini. Nel mondo indipendente tutto questo sta cambiando in modo assai più rapido. Nella struttura della nostra piccola compagnia io e Alexander condividiamo le stesse responsabilità e facciamo fronte comune sempre. All’inizio della nostra collaborazione era difficile, da fuori, riconoscere che le nostre posizioni erano effettivamente paritarie; ancora si fatica ad accettare che possano esistere collaborazioni alla pari e non gerarchiche. Tuttavia più andiamo avanti col nostro lavoro più le persone capiscono e rispettano il nostro modo di operare e i problemi in questa direzione vanno quindi progressivamente a diminuire.
Vogliamo collegare il collettivo e l’individuale, a volte passando per la durezza del mondo, altre volte offrendo un punto di vista di speranza, in modo da provare un po’ di conforto
Le guerre ci circondano, le violenze sono perlomeno sempre più visibili. Teatro e cinema restituiscono questa realtà drammatica senza mezzi termini. La danza segue la stessa direzione o c’è una tendenza a preservarsi quale “isola felice”? Una vostra riflessione in proposito.
Difficile ignorare il mondo anche nel circoscritto ambiente della danza. Tutte le nostre esperienze si riflettono in ciò che facciamo, a volte sottilmente, a volte in modo più audace. Non ogni creazione mostra un chiaro messaggio politico, ma tutte dovrebbero trasmettere qualcosa di significativo.
La nostra ultima produzione Labyrinth, ad esempio, è un lavoro sull’idea che i nostri sogni siano corrotti dalla realtà in cui viviamo, che li trasforma in incubi. In questo contesto affrontiamo problemi come la repressione politica, la devastazione della guerra e l’incapacità dei governi di difendere i diritti umani. Ma vogliamo anche mostrare sentimenti più intimi: amicizia, amore, dolore, paura. Vogliamo collegare il collettivo e l’individuale, a volte passando per la durezza del mondo, altre volte offrendo un punto di vista di speranza, in modo da provare un po’ di conforto.
Consideriamo un grande privilegio poter fare dell’arte una carriera e con questo privilegio viene la responsabilità di condividere dei contenuti importanti. Il nostro obiettivo è presentare opere che siano sia belle che interessanti, coinvolgenti, che rispecchino la complessità del mondo e incoraggino il pubblico a riflettere sulle proprie esperienze e su un contesto sociale più ampio.