
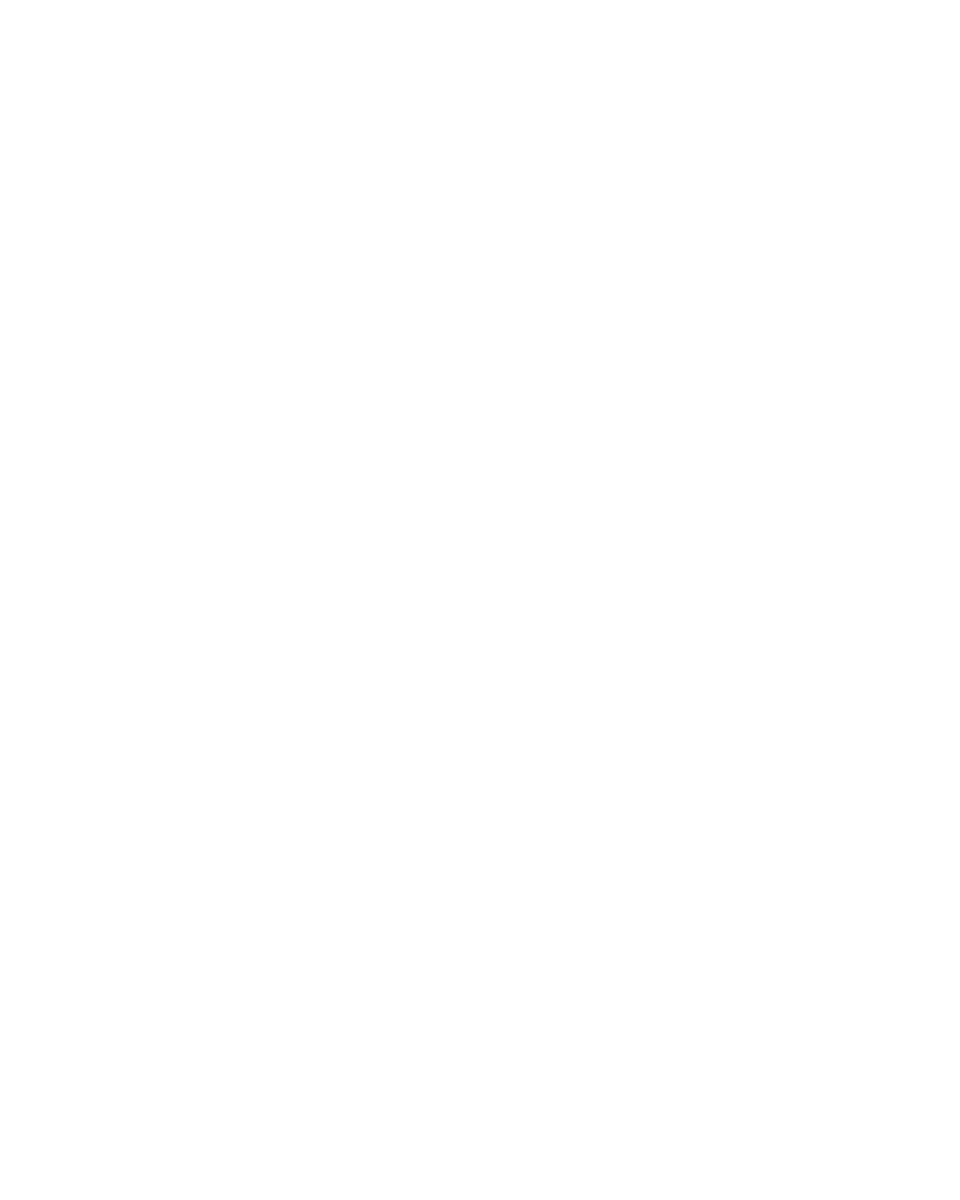
90 anni di Mostra del Cinema raccontata, perché anche di un irresistibile, avvincente racconto si tratta, dal massimo storico italiano del cinema.
Un’impresa tra l’enciclopedico e la dimensione da saga, connotata da un profondo lavoro documentale, archivistico e da una emozionante, personale ricognizione della memoria. Gian Piero Brunetta ci ha consegnato un corposissimo volume necessario, emozionante, potente. Come potente e unica è la straordinaria epopea del primo festival della storia del cinema. Abbiamo voluto ripercorrere questo lungo, quasi secolare viaggio proprio a fianco di chi questa rotta eccitante l’ha disegnata con visionario acume e puntuale definizione.
C’è un’immagine molto bella in cui lei accosta l’approccio adottato nell’affrontare questo lavoro enciclopedico come critico della storia del cinema a quello che ha caratterizzato il lavoro per la realizzazione degli imponenti teleri ciclici dei grandi maestri del Rinascimento veneziano. Come va letta questa intrigante connessione, questa ispirazione?
È un’immagine che ad alcuni potrà sembrare forse eccessiva, ma che esprime al meglio lo stato d’animo che mi ha accompagnato nella stesura del libro. Nelle fasi iniziali del lavoro, quando persisteva un piacevole stato confusionale su come raccontare questa storia, immaginavo una narrazione compatta capace di tenere conto dei diversi elementi individuali, del loro continuo movimento, in uno scenario in cui ogni singola traccia avesse una vita propria, autonoma e allo stesso tempo funzionale a quella degli altri elementi in gioco. In questo flusso di pensieri si è inserito l’amato Tintoretto e il suo modo impareggiabile di raccontare, nella Scuola Grande di San Rocco così come a Palazzo Ducale, queste grandi storie in cui il dialogo tra particolare e collettivo è costante e fondamentale, con centinaia di personaggi e colori magistralmente connessi. Non è del resto un caso che il Tintoretto sia stato più volte definito il primo regista cinematografico della storia… Da veneziano mi sono insomma lasciato andare a questo parallelismo; magari forse un po’ eccessivo, ripeto, ma germinale per me.
In questo lungo viaggio attraverso quasi un secolo di “cinema in festival” storia e cronaca si intrecciano felicemente integrandosi. Ogni capitolo è un’avventura attraverso le tematiche aperte e le particolarità stringenti di ogni singola edizione. Seguendo questo registro la Mostra viene vista come luogo in cui la storia del Paese, quella di Venezia come comunità, quella del cinema e quella, più peculiarmente, della Biennale si intersecano in maniera fitta e continua in un reticolo restituito in maniera felicemente narrativa.
Ha centrato in pieno lo spirito e la particolarità di quello che volevo comunicare attraverso questo lavoro. La difficoltà era proprio questa: legare e snodare i grandi temi della cultura contemporanea nella sua declinazione visiva, filmica, con la storia del Paese a fare ovviamente da sostrato costante, senza che il risultato fosse pesante o che si perdesse in una sorta di squilibrio narrativo. Ho cercato di fare in modo che ogni ricognizione su ogni singola edizione fosse leggibile e comprensibile come racconto in sé. Una sorta de “Le 1.300 notti della Mostra di Venezia”, ecco.
All’inizio mi sono accostato al lavoro come storico, visto che gli anni ’30 li conosco bene in questa veste, ma poi mi è stato fatto notare che avrei dovuto mettere dentro un po’ più di “me”. Ho iniziato quindi ad entrare nel corpo della narrazione con una disposizione più personale, in maniera leggera ma costante, raccontando i film rivolgendomi in primo luogo a chi non li avesse ancora visti o non ne conoscesse le trame, documentando come li avessero percepiti critica e pubblico del tempo, misurando il loro impatto, insomma.
Ho inventato così questo racconto partendo dalla convinzione che alcune tracce dovessero rimanere ‘ferme’, nozioni legate ad informazioni pure e semplici, ma che la loro distribuzione dovesse essere equilibrata con elementi che non rendessero il corpus del testo noioso. Ogni capitolo doveva avere la propria peculiare e irripetibile specificità in un continuo dialogo tra singola edizione e storia collettiva.

Un intento, il suo, portato a termine nel migliore dei modi, con capitoli che presentano una struttura schematica capace di ripetersi efficacemente lungo tutto l’arco dell’opera: un’iniziale panoramica sulla storia del Paese, il passaggio poi ai problemi specifici di quel determinato anno e chiusura con la critica dei singoli film.
In quest’ultimo passaggio ho cercato di farmi guidare dai critici che più ho amato e che più mi hanno formato. Anche loro inseriti a pieno titolo nel meccanismo narrativo, per renderlo più completo e comprensibile.
La Mostra nasce nel 1932 come “Esposizione Internazionale d’arte cinematografica alla 18. Biennale”. Da questa affermazione ricaviamo due concetti fondamentali: il cinema è un’arte; la Mostra del Cinema è un’emanazione diretta della Biennale. Due concetti che Venezia ha sempre dovuto difendere sul campo e che sono stati ricorrentemente problematici, pensiamo al rapporto tra cinema d’autore e cinema commerciale o a quello che lei descrive come il tentativo dell’autorità centrale di togliere la Mostra a Venezia e alla Biennale per portarla altrove e trasformarla in struttura di governo, soprattutto negli anni delle direzioni di Zorzi e Petrucci. Quanto questi tratti originari hanno contribuito a definire l’identità profonda del festival?
Si tratta di due concetti in qualche modo identitari, legati indissolubilmente all’idea fondativa stessa della Mostra del Cinema di Venezia. Due tratti che la distinguono fin dalla sua nascita e che la distingueranno nei decenni successivi da tutti gli altri festival nati dopo, che ne seguiranno inevitabilmente il modello.
La Mostra ha da sempre rivendicato il ruolo cruciale dell’arte nell’esposizione dei film, stella polare nella ricerca di un qualcosa che le consentisse di essere assimilata proprio alla Biennale Arte. Si tratta di un elemento che nessun’altro festival al mondo può vantare nel proprio pedigree, punto di forza che ne ha garantito la sopravvivenza nei momenti più difficili, come vedremo non sporadici, del suo lungo cammino.
Alle spalle della Mostra c’è sempre stata la Biennale, quindi, c’è sempre stata Venezia. Nella Mostra, di riflesso, c’è sempre stata la voglia e l’orgoglio di rivendicare questa ricerca di cifra artistica anche quando è stato necessario fare compromessi con il cinema popolare, anche quando non era possibile scegliere i film perché questi venivano imposti dalle singole nazioni e allora si cercava ‘almeno’ di avere i nomi dei grandi registi, degli autori alti.
La visione del Conte Giuseppe Volpi di Misurata di realizzare la Mostra del Cinema di Venezia al Lido, quasi a volerla rendere riflesso di un’altra visione, quella industriale legata a Porto Marghera. Come secondo lei deve essere collocata sul piano storico questa visione, soprattutto se relazionata alla nascita successiva di Cannes, formalmente nel 1939, poi spostata nel 1946 per lo scoppio del conflitto mondiale, e di altri importanti festival nati anch’essi nel dopoguerra?
Deve essere collocata all’interno di un’altra grande visione che la contiene, ossia quella che Volpi aveva di una “Grande Venezia”, città che non vive di ricordi e non muore mai, proiettandosi verso un futuro che la doveva vedere eterna Regina dell’Adriatico. In quest’ottica, perciò, il Lido andava sviluppato e valorizzato al meglio. Negli anni ’20 vi si svolgevano già diverse manifestazioni che richiamavano l’attenzione della grande élite turistica mondiale; Volpi accoglie questa idea di inserire il cinema nel circuito della Biennale proprio perché convinto che il Lido abbia le potenzialità per farsi fulcro di questa nuova, ambiziosa avventura. Il fatto, poi, che l’Hotel Excelsior fosse stato scelto da questa stessa élite turistica come meta delle proprie vacanze costituiva di sicuro un elemento che spingeva ulteriormente verso questa direzione. Cannes vorrebbe nascere nel ’39 come alternativa ad una Mostra del Cinema che già nel ’38 si era molto politicizzata, ma la cosa non va in porto proprio per l’entrata in guerra della Francia in quegli stessi mesi, che costringerà gli organizzatori ovviamente ad attendere
la fine del secondo conflitto mondiale costringendoli, giocoforza, ad una partenza lenta, che permetterà a Venezia di rimettersi in piedi e ricominciare a camminare trattando con maggior voce in capitolo le condizioni della spartizione del mercato cinematografico dell’epoca. Nasceranno poi altre manifestazioni con cui Venezia si interfaccerà, senza mai vedere ridimensionata quell’aura di sacralità laica che assume con naturalezza sin dalla sua prima edizione.
Insomma, ci si accorgerà presto come al Lido stia nascendo qualcosa che prima non c’era, legittimando anche e soprattutto l’importanza del mezzo cinematografico nella vita sociale italiana e nella diplomazia culturale del Novecento a livello internazionale.
Come viene già dai suoi primi passi, in modo più o meno consapevole, espressa la doppia matrice che ancora oggi caratterizza la Mostra, ossia la necessità di mettere in risalto la cifra eminentemente artistica del cinema e la tensione ad evidenziare la sua veste puramente glam, cruciale per farne una vetrina internazionale dal fascino cosmopolita?
Si tratta di due grandi poli che vengono alimentati fin dalla nascita della Mostra, anche se nel ’32 non si riesce ad avere in presenza le grandi dive d’oltreoceano per ragioni dettate dagli elevati costi e dai tempi degli spostamenti. Si trattava di una manifestazione che doveva ancora guadagnarsi una vera e propria auctoritas, che farà propria però prepotentemente sin dalla sua seconda edizione, già percepita dagli addetti ai lavori come appuntamento al quale non dover mancare. Ai produttori viene infatti chiesto di far arrivare in laguna oltre alle pellicole, anche gli interpreti delle stesse, così da accendere di conseguenza la mobilitazione della città affinché queste nuove divinità laiche venissero accolte nel modo più sfarzoso ed eclatante possibile. Saranno ovviamente gli americani a spadroneggiare in questa direzione, ma anche gli europei non si sottrassero, anzi! Tra le decine e decine di vari episodi, di aneddoti per così dire mediatici di quelle primissime edizioni, come non ricordare a riguardo l’austriaca Hedy Lamarr, protagonista del topless scandaloso in Estasi di Gustav Machatý, capace di esaltare il lato più mondano della kermesse lidense destinato già da allora a diventare elemento fortemente connotante del festival.
Dall’altro lato poi la creazione del Concorso contribuirà in maniera decisiva ad elevare l’attenzione verso la qualità delle pellicole da selezionare. Un Concorso i cui premi saranno immediatamente ambitissimi internazionalmente, il che attirerà l’attenzione del Fascismo sulle strabilianti potenzialità del mezzo cinematografico, facendolo immediatamente smanioso di condividere e, soprattutto, di controllare questa sfavillante ribalta.
Nella prefazione al volume lei sintetizza il cammino della Mostra prendendo in prestito l’immortale verso di Battisti e Mogol «le discese ardite e le risalite» di Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi. Condivide il pensiero secondo cui la storia della Mostra del Cinema sia la più travagliata tra tutte quelle dei festival europei e mondiali di fascia alta?
Assolutamente sì. Una storia senza alcun dubbio caratterizzata da tanti momenti difficili che la stragrande maggioranza degli altri festival non hanno attraversato perché più piccoli e, Cannes a parte, non così sotto la lente d’ingrandimento della ribalta planetaria.
Sono convinto che molte delle vicissitudini vissute dalla Mostra siano riflesso conseguente e speculare delle peripezie che hanno attraversato la storia del nostro Paese, secondo l’intreccio cui abbiamo fatto riferimento sin dall’inizio delle nostre riflessioni. Aspetto, questo, che dal ’68 in poi credo si faccia platealmente palese.
Nel ventennio precedente al ’68 le trasformazioni della società e le sue contraddizioni si ripercuotono fortemente sulla Mostra, la quale riesce tuttavia a ritagliarsi uno spazio di autonomia e ricerca che le consente anche nei momenti cinematograficamente non gloriosissimi di cogliere lo sviluppo della settima arte e di aprirsi alle diverse cinematografie.
Il decennio successivo al ’68 appare viceversa particolarmente difficile per l’avvento di un nuovo Statuto che avrebbe voluto farsi molto meno vincolante di quello elaborato trent’anni prima, ma che in realtà di vincoli ne riserverà addirittura di più sotto certi aspetti, con l’attività dei Direttori dei diversi settori della Biennale strettamente dipendente dal parere di 19 membri del gruppo direttivo dell’ente culturale, aventi voce in capitolo e potere di influenza molto forti sull’operato curatoriale dei Direttori stessi.
I governi che si sono poi succeduti negli anni a seguire non hanno guardato con simpatia costante alla Mostra, traducendo questo atteggiamento ambiguo in un flusso irregolare di sovvenzioni che non hanno permesso una programmazione a lungo termine. Una disposizione che condizionerà fortemente per almeno un altro ventennio le sorti della Mostra, fino agli anni ’80-’90, con direttori capaci di allestire edizioni che avranno, detto davvero senza esagerazioni, del miracoloso se rapportate ai fondi a disposizione.
A questo scenario aggiungiamo poi i tentativi reiterati di scorporare la Mostra stessa dalla Biennale e trasferire il tutto in città concorrenti che si sarebbero volentieri accaparrate un simile evento, Roma in primis. Insomma, nel complesso un percorso a dir poco ad ostacoli senza quasi soluzione di continuità.
Nel suo libro ricorre più volte il concetto di “macerie”, con un accento particolare su due momenti storici a dir poco cruciali: il 1969, quando il Direttore di allora Ernesto Guido Laura dovette fare i conti con la caduta a picco del festival derivata dalla contestazione dell’anno precedente, allorché l’obbiettivo diverrà la pura e semplice sopravvivenza; le macerie non solo cinematografiche del dopoguerra, quando in qualità di Direttore ad interim fu designato Elio Zorzi. Che parallelo potremmo delineare tra questi due scenari? Ci sono state altre occasioni in cui la Biennale ha dovuto fare i conti con il concetto di “maceria”?
Se ne potrebbero individuare certamente altre. Penso ad esempio al ’74, altra annata in cui la Mostra deve lottare per la sopravvivenza. Ritornando indietro di decenni, va detto che il dopoguerra veneziano vive l’inevitabile, profonda criticità del momento, ma tuttavia esprime al contempo una voglia di ripresa della vita culturale davvero eccezionale che non emerge in egual misura in altre città italiane.
In questa occasione si registra anche e soprattutto un dialogo fitto e fruttuoso tra forze politiche diverse e concorrenti, con forti personalità che si interessano al mondo del cinema e fanno in modo di rendere molto vivace la scena culturale veneziana. A questo proposito ho cercato di restituire a Zorzi quello che secondo me gli spetta, ossia il merito di essersi messo duramente al lavoro in una situazione estremamente complessa, un contesto in cui le forze politiche e militari erano fermamente convinte che ci fossero cose ben più importanti da assolvere piuttosto che impegnarsi a far ripartire la Mostra del Cinema di Venezia. Zorzi sente intimamente questa chiamata a difesa della Biennale, per la quale ha già lavorato per decenni in precedenza; capisce di doversi attivare per non farsi eliminare, o per meglio dire superare, dalla Francia, vogliosa in quanto nazione vincitrice della guerra di soppiantare il nostro Paese anche sul piano culturale. Ho cercato quindi di raccontare gli autentici capolavori diplomatici portati avanti in quegli anni da Zorzi, il quale riuscirà non solo a tenere in piedi la rassegna e a farla ripartire, ma anche e soprattutto a non farle perdere terreno sul piano dell’appetibilità e della legittimità in quanto modello del fare-festival nel mondo.

Lei definisce l’edizione del ’47 da lui guidata come una delle più alte in assoluto, “memorabile”, rafforzando tale qualifica con il giudizio datole da Callisto Cosulich, il quale si spingerà a definirla “mitologica” («Quando i ricordi coincidono con la storia, si arriva alle soglie del mito»). In quell’anno la Mostra era ‘assediata’ da Cannes, nasceva la rassegna di Bruxelles con il supporto degli americani e c’era sovrapposizione di calendario con Locarno, ma nonostante tutto Zorzi riuscì nell’impresa di confezionare un’edizione straordinaria. L’anno dopo negozierà con Cannes il calendario, cosa assolutamente non di poco conto.
Un fatto, quest’ultimo, che si rivelerà assolutamente cruciale per i destini futuri della Mostra. Altro aspetto in un nessun modo secondario, anzi!, per lo straordinario successo di quell’edizione la decisione di far svolgere le serate a Palazzo Ducale, nello scenario ineguagliabile che sappiamo e nel cuore vivo della città. Un’edizione in cui il clima intellettuale che vi si respirava fu davvero irripetibile, con la critica che partecipò in maniera unica e straordinaria a tutti gli eventi collaterali in programmazione. Forte nell’occasione fu l’impronta di Pasinetti, figura che si rivelerà di nodale importanza per il nostro cinema e che già allora da giovanissimo appassionato sente forte il bisogno di dire la sua, sinceramente voglioso di dare
un suo concreto contributo a migliorare il festival. Pasinetti, primo laureato italiano con una tesi d’argomento cinematografico nel 1933, ha un ruolo da protagonista fin dal 1932, quando comincia a scrivere per vari giornali. Arriva in quell’anno l’archivio della Cinémathèque française, si realizza un’esposizione sulla storia della tecnica, tutte iniziative che messe assieme consegnano alla storia del cinema e della cultura un’edizione da tramandare davvero ai posteri.
Le macerie con cui si trova ad avere a che fare il Direttore Laura nel ’69 sono molto più profonde per certi aspetti, perché legate ad una totale mancanza di fiducia nei confronti del festival, criticato per i suoi premi e la sua mondanità, per una sua scarsa apertura alla città, di cui è considerato corpo estraneo. Laura deve quindi concentrarsi sui temi di cui trattano i film, temi forti, dalle radici sociali e politiche.
Un articolo dell’epoca definisce la Mostra come “Festival di seconda scelta, inferiore non solo a Cannes, ma persino a San Sebastian, Bergamo e Pesaro”. Esatto. Il che restituisce bene il sentimento dell’epoca nei confronti della manifestazione, sentire diffuso tanto a livello nazionale che internazionale. La stampa francese ovviamente spinge molto su questa percezione, cerca in ogni modo e in ogni occasione di ribadire la superiorità di Cannes rispetto a Venezia e da questo punto di vista infierisce volentieri sulla malconcia “collega”, senza troppi giri di parole. Anche Cannes ovviamente vive e attraversa il ’68, trasformandolo però in arma vincente, allestendo nuove sezioni, su tutte la Quinzaine naturalmente, aggiudicandosi così in quel momento la leadership mondiale nella costellazione festivaliera.
Saranno dieci anni davvero difficilissimi per la Mostra, di faticosa sopravvivenza. Nel ’72 nascono le Giornate del Cinema Italiano, organizzate in prevalenza in Campo Santa Margherita in contrasto con la Mostra che si teneva al Lido in quegli stessi giorni di inizio settembre, che di sicuro non contribuiscono a tenere in serie A il festival. Nel ’71 tuttavia Rondi, all’esordio come Direttore artistico, era riuscito a riportare in laguna grandi nomi e grandi scandali, come il controverso I diavoli di Ken Russel con Vanessa Redgrave e Oliver Reed. Rondi cavalca bene e con grande intelligenza la complessità del momento e soprattutto le forze che erano riuscite a smantellare quasi completamente la resistenza del direttore Chiarini. Anche lui deve di certo sgomitare, senza rinunciare per questo ad andare in cerca di guai con il film di Russel, tanto da essere costretto a ricucire lo scandalo innescato dalla pellicola con accorate lettere ad un rappresentante del Vaticano e ad Andreotti, suo mentore e punto di riferimento.
Come considera il periodo caratterizzato dalle direzioni, per l’appunto, di Rondi e poi di Lizzani, Biraghi, Pontecorvo e, arrivando alle soglie del 2000, di Laudadio? Lo definirebbe come un periodo di riavvicinamento alla Mostra d’antan?
Lo considero un tentativo in tal senso, sì, con risorse sempre più ridotte a disposizione. Uno sforzo dettato dall’orgoglio di personalità interne alla Mostra e che trova in Lizzani la figura che più di ogni altra si dimostrerà capace di guidare la ripresa, lenta ma presente e costante, che permetterà piano piano alla Mostra di risalire le posizioni nel ranking di settore. Lizzani riesce nell’impresa grazie alle sue indiscusse capacità individuali e grazie anche al fatto di essere stato capace di costruirsi intorno una squadra di collaboratori giovani e culturalmente assai agguerriti, in grado mentalmente di aprirsi a tutte le forme cinematografiche, ma soprattutto forti di un’idea di spettacolo legata a pubblici nuovi, quelli, per intendersi, che apprezzavano i film di una rassegna come Massenzio, nata a Roma nel 1977 e capace di introdurre esperienze innovative come le “maratone cinematografiche”, che potevano concludersi all’alba, o le proiezioni simultanee di film su vari schermi, in piena rottura con le tradizionali forme di fruizione. Si cerca, in quegli anni di grandi tumulti e di nuove energie, il contatto con un pubblico giovane, non in smoking e farfallino; un pubblico profondamente innamorato del cinema e coinvolto in un nuovo rito allargato che rinnova la sacralità del momento della visione del film, non interessato all’aspetto mondano che circonda la proiezione, vorace invece di immagini, stimoli intellettuali, emozioni. Spazio allora a studenti di cinema curiosi ed appassionati, saccopelisti che prendono pacificamente possesso della Mostra e dei suoi spazi in nome di un fermento culturale tanto tangibile quanto foriero di aria fresca, nuova.
Lizzani è il primo a incoraggiare questo cambiamento nelle edizioni da lui dirette tra il ’79 e l’82, preparando il terreno per il ventennio successivo, che vedrà la Biennale diventare Fondazione ed acquisire così finalmente una sua autonomia effettiva, entrando in un capitolo davvero nuovo della propria storia. Un ventennio anch’esso di una certa complessità, seppur assai meno oscillante dal punto di vista delle cadute che avevano caratterizzato la storia recente della Mostra. Un lungo periodo di ripresa continua caratterizzato da direttori profondamente coinvolti nel progetto, affiancati da collaboratori che non lasciano al comandante in capo il ruolo di protagonista assoluto, con soddisfazione di tutti. Nell’ambito della direzione di Pontecorvo questo aspetto sarà particolarmente connotante; con lui diventa palese che senza la presenza di alcuni cosiddetti “Direttori-ombra” il programma non avrebbe mai avuto le caratteristiche di ricerca che faranno la fortuna delle edizioni di quegli anni. Felice Laudadio, a capo delle edizioni ’97 e ’98, rappresenta il prototipo di quella nuova generazione di operatori culturali che sanno come si guida e si può ideare un festival, cosa che non si poteva magari dire allo stesso modo di Lizzani, accolto come un corpo estraneo perché mai prima di allora alle prese con la gestione e l’organizzazione di manifestazioni culturali, anzi, considerato regista sul viale del tramonto che viveva di rendita come autore post-neorealista. Il quale Lizzani, invece, a dispetto di tutto e di tutti seppe ritagliarsi una seconda vita, regalandola di riflesso anche a Venezia, che ne aveva un disperato bisogno.
Il percorso di Rondi invece è profondamente diverso, proprio altro. La sua è una carriera costruita negli anni con costanza per così dire strutturale all’interno della Mostra: la ama come ama la Biennale tutta. Dal ’48 in poi è sempre coinvolto nei meccanismi interni del festival. Nelle diverse vesti di consulente o di membro della giuria, il suo cursus honorum in seno alla Mostra non troverà praticamente eguali per tutto il Novecento, con la Presidenza a fare da logico coronamento.
Chiarini è stato un protagonista su cui tutte le forze avverse alla Mostra potevano scagliarsi, a partire dalla stampa fascista che gli rinfacciava una doppia personalità. Ha voluto fortemente diventare Master & Commander della Mostra del Cinema. Era circondato da un gruppo di esperti con cui si consultava, ma il potere decisionale era tutto saldamente nelle sue mani, questo è fuor di dubbio. Sue le decisioni circa i film da invitare e sua la volontà di andare anche in contrasto con le forze alberghiere o con gli stessi eredi di Volpi, con un caso eclatante che lo vide scontrarsi con il figlio del Conte per aver spostato una statua del padre, caso poi risolto con una buona dose di diplomazia.
In Rondi si percepisce ben definita la tenace, lucida visione secondo la quale la cifra artistica della proposta cinematografica debba saper fondersi al meglio con quella mondana, coniugando l’eccellenza dei grandi registi con le esposizioni in città, che accolgono questi stessi registi ed attori in una cornice glamour ai massimi livelli culturali. Rondi non ha mai voluto rinunciare all’aspetto mondano, mai. Elemento che invece per diversi altri direttori è stato spesso considerato fardello da cui doversi liberare, elemento di distrazione rispetto a quella che consideravano la vera vocazione della Mostra, ossia quella artistica. Lo stesso Chiarini vivrà pienamente questa disposizione.
Chiarini che viene da lei descritto come una “diva”, personalità cioè capace di attrarre registi e altre figure più dei grandi attori stessi.
Considero la figura di Chiarini particolarmente interessante anche per motivi strettamente biografici, visto che iniziai a seguire la Mostra negli anni immediatamente precedenti al suo mandato. Grazie a lui ho potuto vedere e capire una gran quantità di film importanti; ho imparato ad amare il cinema anche grazie alla sua capacità di portare a Venezia i grandi protagonisti di questa nuova arte e in particolar modo partecipando alle memorabili retrospettive da lui ideate e promosse.
Anche Chiarini, come del resto moltissimi altri straordinari protagonisti della cultura di quei travagliati anni, vive un percorso esistenziale e professionale a tinte contrastanti, che si dipana in una sorta di doppio binario: da una parte si dimostra un diligente funzionario fascista militante, compiuto, dall’altra esprime una straordinaria capacità di dare vita a grandi eventi e a grandi istituzioni culturali.
Ha ideato e diretto durante il Ventennio, tanto per dirne due a dir poco rilevanti, il Centro Sperimentale di Cinematografia e la rivista «Bianco e Nero», ha tenuto assieme i maggiori docenti della scuola di cinema italiana, è diventato regista. Insomma, un percorso di qualità altissima. C’è poi da rilevare che ha saputo infine non seguire il fascismo perlomeno nel suo ultimo crepuscolo sanguinario, iniziando una seconda vita avvicinandosi al Partito Socialista.
Dopo aver diretto film con modesto successo, ha iniziato ad insegnare Storia del cinema all’Università. Quando lo hanno chiamato a dirigere la Mostra ha voluto compiere questa missione da protagonista, in un periodo storico come gli anni ’60 in cui capitava spesso di imbattersi in direttori impegnati a mimetizzarsi con la Mostra stessa, cercando di non salire in nessun modo alla ribalta. Nel ’68 Chiarini venne ferocemente attaccato in particolare dalla stampa di sinistra, oltre che dagli stessi registi che aveva in passato favorito, formato e portato alla ribalta, dichiarandosi in un’intervista a Lietta Tornabuoni “smarrito, incapace di capire cosa voglia davvero questa gente”. L’elemento a cui si appigliano più di frequente le critiche è lo Statuto della Mostra, etichettato tout court come “fascista” e quindi da abbattere e scardinare a tutti i costi. Il nemico non viene considerato quindi Chiarini in sé, anche se è poi il Direttore a farne le spese ovviamente.
Ho cercato di raccontare questo clima e mi sono molto divertito a farlo, anche perché ero presente e la narrazione ha potuto arricchirsi del mio vissuto. Pur condividendo alcune ragioni alla base delle critiche che gli venivano mosse, mi considero dalla parte di Chiarini anche grazie a questo suo spirito da cavaliere medievale nel rivendicare le ragioni dell’istituzione contro il caos imperante di quell’epoca, con la creazione di associazioni che raccoglievano consensi per la strada trasformandosi poi in soggetti dal futuro davvero improbabile, o comunque destinati a non lasciare traccia alcuna nella storia. Chiarini esce dal mio racconto come ripulito da tutte le eventuali colpe del suo passato.

Quando poi Gregoretti, assieme a Pasolini e Zavattini, si ritrova in un albergo di lusso che era la sede dei contestatori, la sua narrazione raggiunge livelli di umorismo davvero assoluto…
Definendosi appunto “contestatori sì, ma di lusso”. Devo ammettere di essermi particolarmente divertito a raccontare quell’episodio. Esiste un documentario di Antonello Sarno del 2008, intitolato Venezia ’68, in cui intervistando Tullio Kezich, Liliana Cavani o lo stesso Gregoretti costruisce un’autocritica molto divertente di quei tempi attraverso aneddoti spesso esilaranti, concludendosi con una scena in cui questi stessi registi sono impegnati a giocare a calcio con una lattina di birra.
Parlando dell’edizione del ’60 lei descrive un cambiamento radicale nell’approccio da parte della popolazione lidense verso la Mostra, una collettività che non vuole essere più parte del decoro ma soggetto attivo dell’evento. In particolare parla di un gruppo di giovani studenti amanti del cinema “non ancora affetti da virus cinefiliaci monopolizzanti”, definizione che trovo semplicemente impareggiabile. Tra questi ragazzi c’era anche lei?
Sì, c’ero anch’io. Avevo 18 anni ed ero tra i fondatori di una rivista chiamata «Lido Nuovo». Non ero ancora autorizzato a portare avanti in maniera autonoma la critica cinematografica, per questo c’era un ragazzo un po’ più grande di noi che aveva l’accredito ad hoc, mentre noi dovevamo arrangiarci nei modi più disparati. Riuscivamo però ad andare in sala ogni giorno, cosa non da poco, anche se dovranno passare tre, quattro anni prima che mi venga riconosciuto l’accredito ufficiale grazie alla collaborazione con una rivista chiamata «Cinemasud», iniziando poi a scrivere articoli su Bresson o Pasolini, o sulle retrospettive. In quella manciata di anni, importantissimi per me, faccio parte di questo gruppo di ragazzi che invoca una partecipazione attiva dei lidensi al festival. Eravamo fermamente convinti che la Mostra dovesse vivere più a lungo rispetto ai giorni previsti di programmazione, che i confini dell’evento si dovessero aprire accogliendo la più ampia fetta di popolazione possibile, coinvolgendola dal punto di vista pratico e culturale.
Nel suo lavoro lei dedica ampio spazio alla figura del critico, con estratti di articoli o altro. Lo fa con grande lucidità e con una sotterranea ma evidente ironia, sottolineando in maniera elegante alcuni strafalcioni relativi a film che sarebbero poi entrati nella storia del cinema.
In passato ho sempre affermato che mai mi sarei occupato di una storia della Mostra del Cinema, argomento a mio avviso troppo complicato da padroneggiare. Un progetto a cui ho invece sempre pensato era un’antologia delle peggiori critiche che hanno stroncato pellicole presentate al Lido negli anni. Ho voluto mostrare non tanto il “lato oscuro della critica”, quanto omaggiare le figure dei pionieri e le loro difficoltà, l’onestà e le ipocrisie con cui hanno dovuto sempre fare i conti queste figure, capaci a volte di salvarsi appellandosi all’estetica idealistica e parlando dei film anziché apertamente dei problemi politici al centro del dibattito.
Ho cercato poi di osservare le diverse generazioni di critici che si sono succedute, isolando i giovani, distinguendo tra quelli che mi sono sembrati tra tutti loro i più autorevoli, la cui storia si è accorpata a quella della Mostra e che ho amato, e quelli che invece magari non hanno mai amato il Lido o che hanno nutrito sempre e comunque dubbi sulla bontà della Mostra. Questo lato della storia del festival lidense è sempre stato centrale nella mia attenzione. Ho cercato di raccontarlo nelle sue molteplici trasformazioni, viaggiando tra i suoi alti e i suoi bassi, con onde continue spinte da correnti opposte. Ci sono momenti di forti ed intriganti contraddizioni nella storia della critica cinematografica, soprattutto in relazione ai diversi media, ai giornali che la andavano negli anni ad ospitare. Su tutti mi piace qui sottolineare quella rinnovata e aperta cinefilia degli anni ’80, che portò ad esiti curiosi, spesso brillanti ed intelligenti. Per esempio capitava di leggere ottime, forse le migliori, critiche dei film americani sulle pagine de «Il Manifesto», in un contesto come quello comunista, anche nelle sue punte più frondiste, caratterizzato sin dal primissimo dopoguerra da uno stentoreo anti-americanismo. Era quello un momento in cui le maglie si aprivano, nuove voci, nuove generazioni leggevano le trasformazioni, in questo caso cinematografiche, con meno spirito settario.
Cita a più riprese il critico francese dei «Cahiers du Cinema» e storica firma del «Positif» Michel Ciment, o anche alcuni corrispondenti storici di Corriere e Stampa, in particolare Sacchi e Gromo.
Il francese l’ho citato perché ha amato il Lido e Venezia davvero come pochi altri nel nostro mondo, oltre ad essere testimone di alcuni significativi momenti di ‘abbassamento’ della Mostra. Sacchi e Gromo invece non potevano in nessun modo essere qui ignorati, dal momento che sono stati i grandi decani della categoria in Italia. C’è poi Guglielmina Setti, prima donna in questo ambiente, che mi fa pensare all’immagine dei Pellegrini che per primi sbarcano su una nuova terra, sconosciuta ma allo stesso tempo affascinante, con la possibilità quindi di fondare, nel nostro caso, la critica cinematografica vera e propria grazie a Venezia. Una critica che nasceva in quegli anni, ma che godeva all’epoca di spazi ancora ridottissimi a livello mediatico.
Anni in cui la presenza dei giornalisti presenti in Mostra arriva a numeri vertiginosi, quasi 400, dove al critico dei Cahiers si affianca anche quello de La voce di Piacenza, che lei cita puntualmente. Dal libro traspare proprio questa enorme varietà di fonti, non solo bibliografiche ma anche documentali. Esiste un archivio del materiale che ha studiato?
No. Il mio archivio è la memoria, a cui ho fatto grandissimo ricorso anche e soprattutto durante il periodo di isolamento che purtroppo ci ha coinvolti tutti negli ultimi due anni. Negli anni ’60 compravo molti quotidiani e ne ritagliavo alcuni articoli, che ho ritrovato a volte con sincero stupore.
Un grosso aiuto è poi arrivato dalle diverse Cineteche, in particolare da quella di Bologna e da quella Lucana, che mi hanno prontamente spedito fotocopie di riviste straniere che mi mancavano e che non riuscivo in alcun modo a reperire. L’aiuto della Cineteca Lucana è risultato inoltre particolarmente importante, direi fondamentale, nell’affrontare la narrazione dedicata a Rondi, di cui la Cineteca conserva i preziosi archivi.
Ovviamente una grande fortuna è rappresentata dalla presenza in rete degli archivi dei diversi quotidiani, come «L’Avanti» o «L’Unità», di cui mi ricordavo di aver letto articoli recuperati poi digitalmente. Esistono poi alcuni libri fatti davvero molto bene. Quello realizzato per il cinquantenario della Mostra mi ha molto aiutato, come un altro che raccoglieva le recensioni dei film dei primi vent’anni di festival. Altri periodi li ho studiati personalmente, magari dedicandogli un corso universitario di un anno; penso, ad esempio, al periodo degli anni ’30. Ho messo in gioco tanti momenti della mia vita; memoria personale e archivi si sono parlati fittamente. Su alcuni documenti c’è poi stato il preziosissimo lavoro del mio ultimo dottorando, Riccardo Triolo (firma storica del nostro giornale ndr), che era stato da me instradato per essere lui stesso l’autore di questo libro, proposito poi mutato in corso d’opera per svariate ragioni.
Il libro, in fondo, credo di averlo sempre avuto dentro di me. Sempre ci pensavo e sempre ero convinto che non sarei mai riuscito a portare a termine un simile lavoro. Fortunatamente ho potuto constatare quanto gli archivi della Biennale funzionino benissimo, quanto perciò siano stati davvero cruciali per consentirmi di colmare dei vuoti. Gli esempi sarebbero moltissimi, basti qui ricordare su tutti l’ultimo, da poco noto ai più, ossia le cinque lettere del carteggio tra il distributore newyorkese Joseph Burstyn, il direttore della Mostra dell’epoca Antonio Petrucci ed un giovanissimo Stanley Kubrick, quando quest’ultimo sottopose all’attenzione della Mostra di Venezia il suo primo lungometraggio, Shape of Fear. Non esisteva traccia del passaggio del film a Venezia, ma grazie al buon funzionamento dell’archivio abbiamo potuto capire dove indirizzare la nostra ricerca e come poter così portare alla notorietà del pubblico la storia di questo film.

Questi ultimi vent’anni di inizio millennio sono stati quelli del consolidamento della Mostra, anche grazie alla Presidenza Baratta che, forte del nuovo Statuto, ha garantito finalmente la dovuta indipendenza, autonomia alla Biennale nel suo complesso, con ricadute positive su tutta la programmazione delle attività dei diversi settori. Un ventennio caratterizzato dal lavoro di due direttori che sono entrati a pieno diritto nella storia del festival: per otto anni Marco Müller, per 13 Alberto Barbera, che ora si appresta a dirigere la sua quattordicesima edizione. Due grandi direttori assai diversi l’uno dall’altro per estrazione, cultura, visione del mondo, ma entrambi fondamentali per il loro lavoro decisamente proiettato verso il futuro, con in testa il comune obiettivo di riportare Venezia ai piani più alti del ranking internazionale festivaliero. Quali tracce di continuità e quali scarti ha individuato tra questi due percorsi curatoriali?
Si tratta indubbiamente dei due direttori che hanno contribuito a traghettare la Mostra nel nuovo millennio, ricollocandola come meritava nel panorama internazionale e ridandole la potenza e la sacralità che stavano nel tempo sbiadendosi. Grazie a loro Venezia ha saputo guardare all’universo del cinema con rinnovata lucidità, cogliendo le dinamiche che in quegli anni stavano trasformando questo mondo e non solo.
Due direzioni diverse ma entrambe caratterizzate dall’idea di ridare a Venezia il suo dovuto ruolo di guida. Un’idea felicemente concretizzatasi anche grazie alla Presidenza Baratta, che riuscirà nel prioritario obiettivo di far approvare il nuovo, agognato Statuto, il quale trasformerà la Biennale in una Fondazione privata, veste che le consentirà di guadagnarsi finalmente una piena autonomia decisionale. Autonomia il cui primo, più importante effetto sarà quello di poter incominciare a programmare a lungo termine le attività di tutti i settori dell’istituzione, disegnando una strategia di insieme, sistemica, capace di tenere conto sia dei programmi culturali che delle istanze pragmatico-organizzative, con un grande impegno sul fronte logistico e dell’allargamento delle sedi per gli eventi e le attività. Tornando ai due ultimi condottieri di questa immaginifica, stagionata nave dei sogni, nel libro ho paragonato Müller a Marco Polo, data la sua vocazione innata all’esplorazione di nuovi mondi cinematografici, in primis quelli dell’Estremo Oriente, e Barbera alla figura del Capitàn da mar, per la “forza tranquilla” del suo procedere simile a quella che caratterizzava questa figura di comandante supremo della marina veneziana ai tempi della Serenissima. Con Müller assistiamo all’apertura totale dello sguardo con l’inclusione prepotente delle cinematografie orientali, senza ovviamente per questo escludere il dialogo con il cinema americano, anzi; con Barbera, grazie anche alla sua formativa esperienza alla direzione del Festival Cinema Giovani di Torino, si dispiega con progressione lucida e tenace una ricerca tesa ad intercettare le nuove figure, le personalità emergenti del cinema in trasformazione.
A Müller il merito di essersi concentrato su un Concorso di esclusive prime visioni mondiali, con una forte accelerazione nel ricoinvolgimento delle grandi star hollywoodiane che rianimeranno prepotentemente il red carpet, ora affollato di celebrità come mai si era visto prima. Un processo che poi Barberà proseguirà se è possibile con effetti ancora più eclatanti in termini di visibilità mediatica.
Entrambi si sono poi dovuti confrontare con grandi problemi di carattere organizzativo, in modo specifico per quel che riguarda le location, le sale, sempre storicamente un tallone d’Achille della Mostra in termini di numeri di posti a sedere e di qualità di alcune sale, proprio vetuste. Un problema eminentemente tecnico, ma poi anche di immagine. Da lì l’impulso della politica a risolvere il problema con la solita grande opera all’italiana, ossia il nuovo Palazzo del Cinema di fronte al Casinò, che naturalmente si rivelerà un fallimento catastrofico, con quel buco rimasto lì per anni, causa la scoperta di grandi quantità di amianto nel sottosuolo, a simboleggiare l’inettitudine della cosa pubblica a pensare in grande in modalità percorribili. Nel momento in cui la Biennale incomincia a dimostrare una capacità d’azione autonoma, rapida, il picco dell’abisso proprio da un punto di vista sistemico, strutturale. Un abisso da cui si rivelerà assai arduo riuscire a risalire.
Eppure proprio la sconfitta di un’idea gigantista davvero sproporzionata per il Lido permetterà alla Biennale, in piena indipendenza dalla politica a differenza da quanto era accaduto per il Palazzo che poi non si farà, di iniziare un’opera di recupero e di miglioramento delle strutture tradizionali della Mostra, a partire dallo storico Palazzo del Cinema, in linea con un’idea di costruzione dei grandi eventi più aderenti a una certa qualità quotidiana della vita, meno impattanti sull’ambiente, più sostenibili insomma. Alla fine non sempre i disastri vengono solo per nuocere.
Un miglioramento deciso delle strutture, e quindi dell’immagine complessiva della Mostra, che si accompagna in questo ultimo ventennio alla creazione di nuove sezioni. Pensiamo ad Orizzonti, su cui investiranno in termini di idee e di visioni enormemente sia Barbera che Müller, o alla recentissima apertura della Mostra alla realtà virtuale, o ancora all’apertura ai giovani con il riuscito progetto di Biennale College, trasversale a tutti i settori e che in ambito cinematografico è stato particolarmente fortunato e seguito, motivo di giustificato orgoglio di tutta l’istituzione Biennale. L’apertura poi alle piattaforme, ai film prodotti da Netflix in particolare, restituisce in pieno questa disposizione all’innovazione, a uno sguardo attento al mondo in movimento che caratterizza crescentemente, anno dopo anno, la lunga direzione Barbera.
Possiamo definire Müller e Barbera “direttori-pontefici”, grandi traghettatori della Mostra attraverso tempi caratterizzati da profondi cambiamenti, spesso anche repentini e radicali; naturalmente ciascuno con il proprio tratto peculiare, con la propria mentalità e la propria visione culturale. Il primo ha cercato di lavorare con la memoria, anche attraverso il ciclo delle cosiddette “storie segrete” del cinema italiano ed asiatico, cercando di riaprire lo sguardo e di soffiare sulle braci di una cinefilia che si stava pian piano spegnendo o trasformando in un’altra cosa. Unitamente alle retrospettive, di Müller va sicuramente ricordata l’idea del “film a sorpresa”, strumento efficace per fare in modo che al Lido potessero essere viste pellicole che la censura, attiva purtroppo ancora in molti paesi del mondo, altrimenti avrebbe di sicuro bloccato se annunciate anticipatamente. Il secondo, Barbera, pur attento al cinema indipendente, sempre presente nelle sue Mostre, ha saputo consolidare saldamente il ripristinato rapporto con Hollywood, che permetterà in questi ultimi dieci anni a moltissimi film in Concorso a Venezia di vincere una sequela di Oscar, praticamente ogni anno. Ciò ha fatto sì, di conseguenza, che a tutt’oggi i grandi produttori americani siano disposti a mettersi ordinatamente in fila pur di essere presenti alla Mostra del Cinema di Venezia. Cosa nient’affatto scontata.
Concludendo, direi che sia Müller che Barbera si sono messi totalmente al servizio di Venezia amando profondamente il luogo in cui lavoravano, godendo entrambi di grande autonomia elaborativa ed operativa rispetto ai loro predecessori. Un combinato disposto di grande forza ed efficacia.
I “capitoli che non ci sono”, il domani della Mostra. La forma- festival sta dimostrando una resilienza, termine abusato e quasi oramai inservibile ma in questo caso più che mai calzante, davvero attiva, vitale. Quale la sua idea sul futuro del fare-festival in questo panorama cinematografico come mai prima in perenne, quotidiana mutazione?
Ci ho pensato molto in questi due anni in cui la gente è sparita dalle sale e i festival hanno vissuto edizioni stravolte nelle modalità organizzative e nei tempi. È vero che in Italia i festival si sono moltiplicati e hanno cambiato pelle, ma è indubbio che la Mostra del Cinema di Venezia come forse nessun altro evento consimile sia stata in grado di mantenere intatta, e per certi versi di accrescere, una dimensione di sacralità dello spettacolo.
Vedo Venezia come punto di riferimento non tanto per il lancio commerciale di un film, quanto per la sua innata capacità di rivestire la pellicola di un’aura che si sta indubitabilmente perdendo in giro per il mondo, anche per la polverizzazione delle modalità di fruizione del prodotto filmico grazie all’esplosione e alla proliferazione delle piattaforme in streaming. Il fatto che Venezia abbia accolto e premiato lavori prodotti e distribuiti da Netflix è un segno della sua visione aperta al divenire, al domani. Un futuro che è già presente, se non addirittura passato prossimo, che magari potrà generare difficoltà negli anni a venire all’industria del cinema intesa con i canoni novecenteschi, di cui credo però la Mostra sarà l’ultima a soffrire paradossalmente proprio alla luce della sua veneranda età.
La crisi del cinema in sala è seria e preoccupa più di sempre; i suoi effetti si protrarranno per lungo tempo. Ormai, in particolare dopo il biennio pandemico, decine e decine, se non addirittura centinaia, di festival sono oggi fruibili in rete. La Mostra del Cinema di Venezia rappresenta però ancora un’isola in tutto e per tutto, storicamente, geograficamente, culturalmente: si porta dietro la forza straripante della città e della Biennale, una forza che in quei dieci giorni di indigestione filmica si percepisce tangibile nei luoghi occupati dal pubblico e dalla critica, da attori e registi. A dispetto di ogni possibile scenario distopico, questi sono gli elementi che mi fanno guardare al domani con discreto ottimismo qui al Lido.