
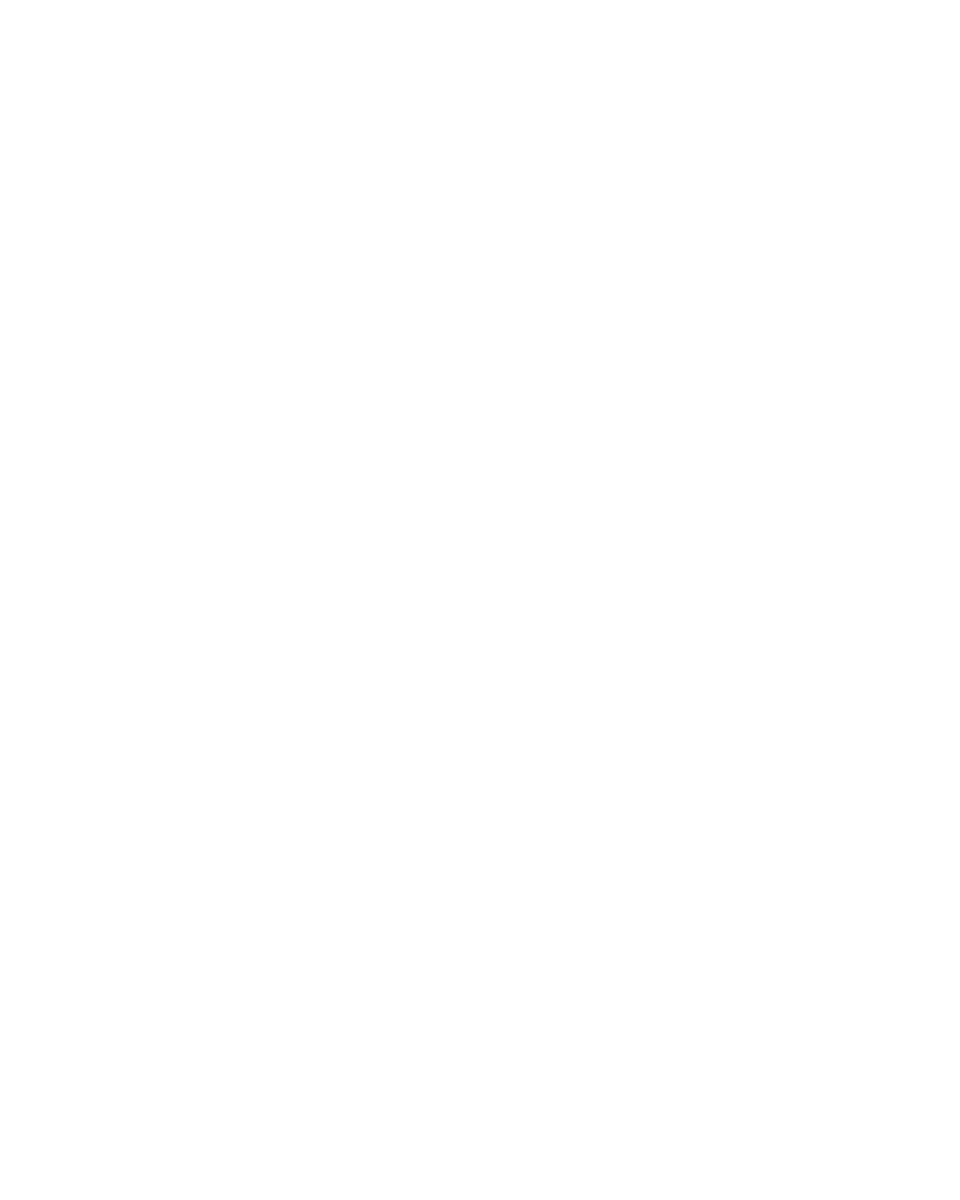
Giovane, travolgente, Andrea Peña fondatrice dell’Andrea Peña & Artists si è aggiudicata il bando per una nuova creazione della 17. Biennale Danza con Bogotà. Le abbiamo chiesto del suo nuovo spettacolo, della sua ricerca, della sua visione artistica. È stato un immenso piacere dialogare con lei.
Già Plinio il Vecchio nella storia di Butade Sicionio racconta come dal suo lavoro di artigiano di vasi d’argilla nacque la scultura con un atto d’amore per la figlia. Spesso si dimentica che la danza nasce anche come bisogno di compattare l’ordine sociale di una comunità, ed è qui che Andrea Peña si muove. Una rigorosa scelta di movimenti del corpo in uno spazio che diviene anch’esso protagonista, tra oggetti sempre significativi.
«Le cose hanno vita propria… si tratta soltanto di risvegliargli l’anima» raccontava lo zingaro Melquíades a José Arcadio Buendìa in Cent’anni di solitudine.
Andrea Peña è giovane, colombiana di origine, ma immigrata presto in Canada. Ha lavorato con le prestigiose Ballet BC e Ballet Jazz di Montréal, ha conseguito un master in Industrial Design, e nel 2014 ha fondato la propria compagnia multidisciplinare AP&A (Andrea Peña & Artists).
Ha vinto il bando internazionale lanciato da Biennale Danza per una nuova creazione con il progetto, ora spettacolo, Bogotà, che vedremo in prima mondiale dal 13 al 15 luglio in Arsenale alle Tese dei Soppalchi.
Giustamente lei ha affermato che la tecnologia è da sempre stata usata nella danza e nell’arte. Ricordo nel 1980 lo scalpore suscitato da Stelarc nella sua performance artistica; tutti i manager già in quegli anni studiavano body language e Watzlawick. Cosa vi è di veramente nuovo che la tecnologia può oggi offrire al mondo della danza?
Per me la tecnologia non è un mezzo che offre solo possibilità estetiche, ma un’intelligenza, ed è qui che trovo lo spazio per giocare ed elaborare quello che faccio. Penso alla tecnologia in termini di tékhnē, la cui radice filosofica è nel fare, nella pratica come forma di conoscenza, come forma di saper fare. In questa direzione tékhnē indica un tipo di intelligenza, una tecnica, una tecnologia presente nella nostra modalità di fare le cose; è questa definizione fluida e ibrida che informa il mio rapporto con la tecnologia: per ristrutturare non l’apparato tecnologico ma il saper-come-fare di una tecnologia, cioè la sua intelligenza. Per questo mi incuriosisce usare la tecnologia nella danza come modo di rivelare l’intelligenza presente all’interno di un sistema.
Riconoscere che la tecnologia è per lo più occulta nella nostra società, riconoscere il modo in cui la danza e l’arte possono usare la tecnologia per squarciare il velo che la cela, mostrare le possibilità e la complessità interna di un apparato o di un sistema tecnologico è, in un certo senso, come smascherare la tecnologia per allontanarsi dalla semplice-bellezza. La semplice-bellezza è un’alterazione artificiale della bellezza che consumiamo nella società moderna e che ci impedisce di interagire con la complessità. Penso che la tecnologia possa offrire alla danza modi nuovi di pensare piuttosto che nuovi modi di rappresentare o di abbellire.

La sua ricerca Performing Digital Intimacies ci ha molto coinvolto e incuriosito. Ci può raccontare come si è svolto il progetto e come ha utilizzato questa ricerca nei suoi lavori?
Questo lavoro rappresenta uno di quei momenti preziosi che ci sono rivelati durante le restrizioni dovute alla pandemia. Sono stata invitata al PHI Center in collaborazione con Shared Studios per sviluppare un progetto di portali digitali dislocati in 24 città del mondo, in particolare a Montreal, Berlino, Ede, e Città del Messico. Questi portali per me rappresentano opportunità digitali di connessione attraverso il corpo. In un momento in cui molti coreografi lavoravano sul tradurre coreografie in film, io ero curiosa di usare questa tecnologia di streaming digitale come strumento per incontri umani e corporali. Mi interessava creare intimità in un momento in cui l’intimità fisica, i nuovi incontri e le connessioni umane erano limitate. Il «New York Times» ha pubblicato un articolo dal titolo 36 Questions that Lead to Love, una guida per due persone che vogliono avvicinarsi l’una all’altra usando la tecnologia e la programmazione. Ho impostato un sistema che genera un estratto dalle 36 domande e le sottopone a uno dei due partecipanti, ciascuno in una città. I partecipanti devono poi rispondere in modo verbale o attraverso il movimento a uno sconosciuto dall’altra parte dello schermo. Stiamo parlando di schermi a grandezza umana che mostrano un’immagine a figura intera, nonché il suono dell’altra persona all’altro capo del mondo. Rispondere a queste domande intime, sia verbalmente che fisicamente, guidati dalle richieste di una voce algoritmica, ha permesso a due sconosciuti di conoscersi in un contesto di gioco digitale. Si è venuta a creare una connessione fisica ed emotiva tra gli artisti dell’AP&A a Montreal e gli sconosciuti di altre tre città. I partecipanti sono stati molto coinvolti in questa esperienza, dalla durata di trenta minuti: hanno giocato, riso, pianto e ballato insieme mostrando tratti della loro intimità a qualcuno che non conoscevano dall’altra parte del mondo. Per me questa ricerca è stata fondamentale nella sperimentazione di sistemi coreografici, in questo caso guidati da un algoritmo, che hanno dato partecipazione e spazio all’interpretazione individuale. È stato il mio modo di usare la tecnologia come intelligenza e di creare spazio per connessioni umane piuttosto che estetiche.
La semplice-bellezza è un’alterazione artificiale della bellezza che consumiamo nella società moderna e che ci impedisce di interagire con la complessità.
Nel suo monito a «Returning, individually and collectively, to our essence as humans» sembra implicito un punto di svolta: siamo veramente mai stati umani in un significato positivo o la violenza è da sempre connaturata nel genere umano? L’artista coreografo, il creatore di performance, la danza in generale come possono intervenire e contribuire a questo ritorno?
Come esseri umani siamo fatti di opposti e sono questi opposti che ci permettono di capire la profondità e la risonanza di ciascuno di essi. Tuttavia, ci dimentichiamo di ritornare alla vasta gamma all’interno di questi opposti, poiché è proprio quello a renderci umani. Siamo costantemente avvolti in un artifizio e dimentichiamo le nostre vulnerabilità, umiltà, fragilità, purezza e insicurezze in quanto fondamentali elementi complessi che definiscono l’essere umano. Per me è qui che la pratica coreografica ancora mantiene un potenziale per rivelare che cosa ci rende umani. Gli artisti che si impegnano nel fare qualcosa permettono agli spettatori di vederli come veicoli di fragilità e vulnerabilità loro proprie e dell’umanità in generale. La pratica coreografica si risolve dunque nel tempo, nello spazio e nel movimento, per permettere al sacro e al profano presenti nell’umanità di coesistere nell’individuale e nel collettivo, sia dei danzatori che della comunità che si crea tra gli spettatori di questa forma di spettacolo.
Mi piace molto il termine “pluriverso” ideato dal filosofo Félix Guattari, che indica la pluriversalità come un distacco dal nostro costruire un uni-verso e che ci porta ad una comprensione della coesistenza attraverso la pluralità. Laddove uni-verso indica un obiettivo unico verso la comunità, il pluriverso indica la capacità di più universi di coesistere. È qui che trovo lo spazio per nuova coreografia, lì dove il ruolo del coreografo può essere messo in discussione e dove questi lavori trovano spazio per esprimere la complessità piuttosto che la singolarità, dove uno spettacolo può essere visto come veicolo per un’esperienza di pluriverso che contiene armonia e molteplicità nella differenza tra gli stessi interpreti.
Nelle mie opere cerco di investigare non solo le emozioni, ma piuttosto i sentimenti come atteggiamenti verso le emozioni; “luoghi” in cui non è contenuta un’unica emozione come la malinconia, la gioia o il desiderio, dove anche lo stato fisico è il vissuto di queste emozioni come esperienze viscerali e stratificate fatte di più emozioni unite insieme. Uno stato pluriversale di sensazioni e prospettive condivise nelle diverse prospettive di ciascun interprete.
Oltre che danzatrice e coreografa lei è anche designer industriale. In che modo danza e design possono vicendevolmente beneficiare della loro possibile interazione?
Ho cominciato a considerarmi una designer del movimento. Cercando di definire quello che faccio, mi sono resa conto che l’ibridazione e la congiunzione di coreografia e design è l’asse su cui lavora AP&P. Per molti anni ho cercato di bilanciare queste due pratiche e provato a capire come potesse esserci una sorta di conversione, ma è stato dopo aver preso un master in design che ho cominciato a usare la scrittura per capire la relazione tra le due discipline, quindi il modo in cui possono beneficiare l’una dell’altra.
La coreografia trae grande beneficio da questa immersione nel mondo del design poiché non aspira più, almeno per me, a un’ideale coreografico in chiara definizione rispetto al corpo. Vedo me stessa come coreografa o, direi, designer di strutture di movimento che guidano un interprete nella sua propria espressione coreografica. Il design mi ha offerto la capacità di vedere sistemi invece che forme fisse, interrelazioni piuttosto che rappresentazioni, e di processare il tutto in un laboratorio interattivo con strumenti per pensare al lavoro così come può essere riversato in media differenti. Il design ha permesso alla mia pratica coreografica di diventare una pratica di facilitazione dell’armonia tra più tecniche.
D’altro canto, penso che il design possa anch’esso imparare molto dalla coreografia. Il mio master studia i movimenti coreografici che sono imposti sui nostri corpi attraverso l’ambiente costruito che abitiamo. Esso guarda al designer industriale come a un coreografo che non progetta sul corpo, ma utilizzando parametri coreografici compresi nella forma, nella funzione e nell’uso di un oggetto. Penso che il design abbia molto da imparare dalla storia delle pratiche incorporate e somatiche, che hanno studiato non solo il rapporto del corpo con il tempo e lo spazio, ma anche la singolare espressione del corpo visto come organizzazione di movimenti. È qui che il design mostra i suoi limiti: ci siamo dimenticati di osservare, mettere in discussione e risolvere il problema di come il design possa alterare e limitare l’espressione del corpo.

Nata in Colombia e trapiantata in Canada, lei è un’artista necessariamente di frontiera. Secondo lei ha ancora senso oggi nel mondo della danza parlare di identità culturale connessa alla radice territoriale nativa o quest’ultima è stata fagocitata dalla multiculturalità?
Viviamo in tempi post-coloniali, uno spazio che è stato ricavato per rivedere la storia e interagire con nuovi futuri immaginari. Penso che anche il nostro ideale di cultura e i modi in cui ci relazioniamo ad essa stiano cambiando. Per quanto riguarda l’arte post-coloniale sono molto interessata alle pratiche di costruzione del futuro che artisti di culture marginalizzate usano per reimmaginare i loro passati personali e ancestrali e per creare nuovi futuri. Penso a pratiche come futurismo indigeno, afrofuturismo, chicanofuturismo e altre ancora. Queste pratiche deformano il tempo e lo spazio tra l’ancestrale e il futuro per dare senso alla modernità. Penso che se interagiamo con un po’ di umiltà con più culture allargheremo la nostra capacità di interagire con la complessità. Come artista biculturale di parziale estrazione colombiana, che vive in Canada e lavora all’estero, sono colpita e ispirata dalla nozione di ibridazione. Come può l’ibridazione fare spazio a tutto ciò che sta nel mezzo? In realtà l’ibridazione può essere una nuova forma di umanità, dal momento che tutti noi abbiamo alle spalle lignaggi complessi, mutazioni che creano nuovi ibridi.
Fa parte del nostro ruolo imparare a interagire continuamente con l’ampia gamma di lavori artistici che appartengono alle culture dell’identità. Ci sono culture che vivono nella periferia e altre che vivono al centro: in che modo possiamo fonderle e metterne in discussione le divisioni? Dissolvere la polarità tra centro e periferia? Ci sono temi su cui lavoriamo molto con gli altri artisti alla AP&A: come trasformare la periferia in centro, come decentralizzare il centro stesso?
Il nostro obiettivo è affrontare l’ibridazione come luogo che lascia spazio alla possibilità di esplorare il ruolo della cultura all’interno di un’opera e le sue manifestazioni fisiche e materiali. Molte, molte domande… ci sono più domande che risposte!
Per me il Realismo magico è diventato uno strumento per esplorare il farsi futuro dell’ancestrale all’interno della moderna era post-industriale e post-umana
Bogotà. Lo spettacolo con cui ha vinto il bando internazionale per una nuova coreografia evoca il Realismo magico alla Marquez della sua terra d’origine, la Colombia. Come è nata e cosa racconta questa creazione che il direttore McGregor definisce “radicale e innovativa”?
Bogotà è un lavoro ispirato dalla complessa storia della Colombia. È un’opera che prende questa storia e la pone nella sensazione universale dell’oggi. È la prima volta che porto la mia storia personale come fonte creativa in un lavoro alla AP&A e per me è un dono avere la possibilità di rivisitare la conoscenza ancestrale della mia gente e mettere in discussione che posto abbia e che rappresentazione abbia nella società contemporanea. Per me il Realismo magico è diventato uno strumento per esplorare il farsi futuro dell’ancestrale all’interno della moderna era post-industriale e post-umana. Giochiamo con la spiritualità, l’immaginario, le storie, le tradizioni come pratiche e idee per creare e sviluppare nuovi universi che riflettono versioni alternative, critiche e più vulnerabili del nostro Realismo magico. In Bogotá il Realismo magico prende forma nella scenografia industriale abbandonata ricreata sul palco (ponteggi, rinfuse, lampade e altoparlanti ammucchiati) nei costumi e nello stile di ogni artista (ciascuno ispirato dalla fusione di leggende colombiane e creature di sottoculture contemporanee) e si integra nel sistema coreografico e nel simbolismo dei corpi dei danzatori (sirene, personaggi in stile barocco queer, figure precolombiane, figure tratte dal mondo dell’attivismo politico). Il tutto interrogato da una prospettiva queer, attraverso corpi queer. Quest’opera non è interpretata o creata da artisti colombiani, ma canadesi-libanesi, afroamericani, francesi, indigeni, asiatici, russi… Artisti che portano le loro ricche storie e individualità come luogo di incontro all’interno delle idee che informano l’opera stessa. Con questo lavoro gli interpreti si offrono umilmente come veicoli per far spazio alla possibile riconciliazione della popolazione colombiana e all’espressione delle forme ancestrali colombiane di oggi.