
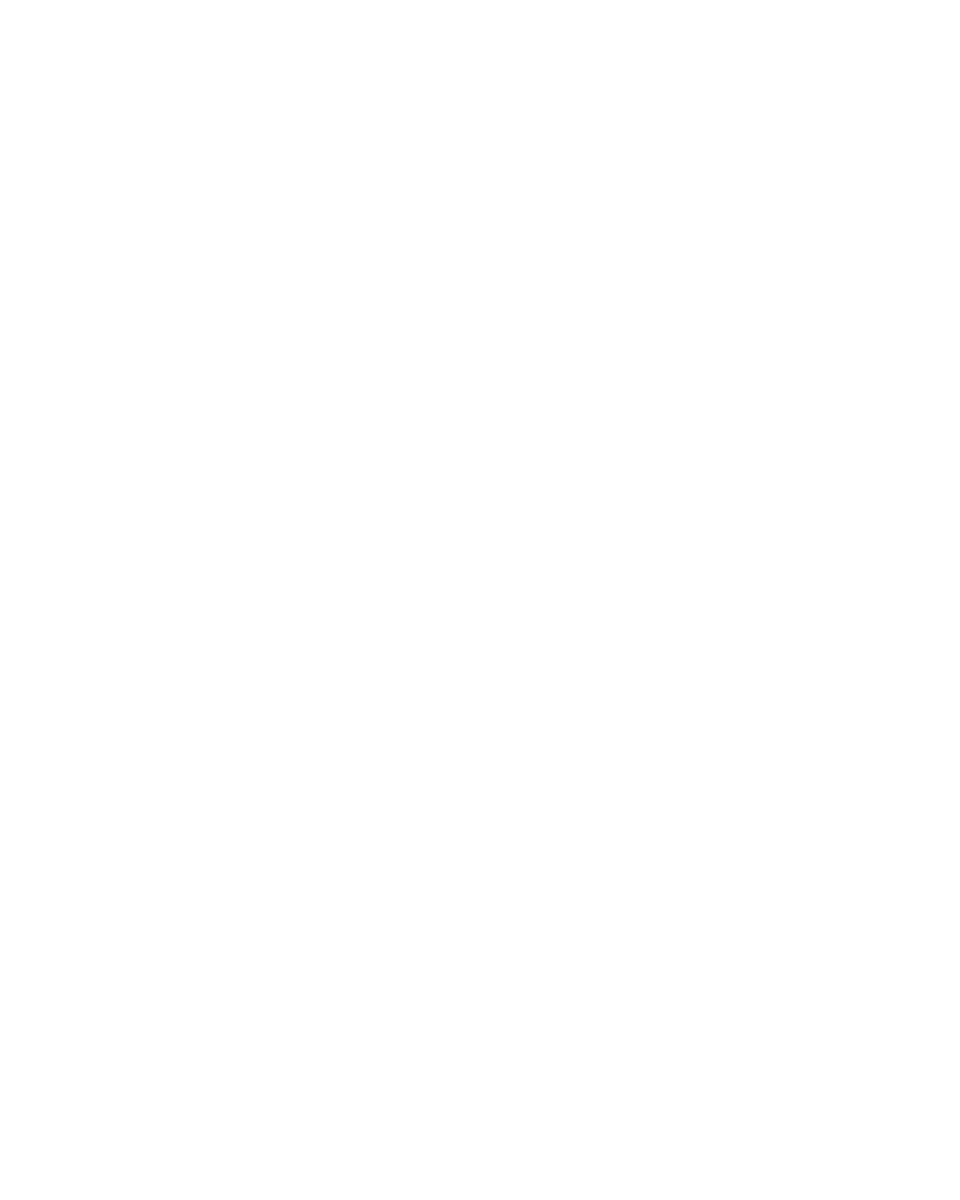
When I Came to Your Door di Antonio Paoletti vince il Venice Architecture Film Festival 2024 come miglior cortometraggio. La nostra intervista al regista…
L’edizione 2024 di Venice Architecture Film Festival, organizzato e promosso da ArchiTuned e svoltosi dal 13 al 15 novembre scorso al Cinema Rossini, ha dimostrato come i film siano sempre finestre di indagine privilegiata su città, comunità, territori. Sullo sfondo di storie drammatiche emergono sempre più in maniera evidente le problematiche della nostra contemporaneità e la disperata ricerca di adattamento – Adaptations è infatti il titolo e tema conduttore di questa edizione del Festival appena conclusasi – messa in atto da paesi, città, comunità, individui, che il linguaggio cinematografico restituisce in maniera vivida. È il caso di When I Came to Your Door di Antonio Paoletti (10 minuti, 32 secondi, 2024), vincitore del Venice Architecture Film Festival 2024 come miglior cortometraggio. Il regista racconta la storia della distruzione fisica e psicologica di un gruppo di persone di Addis Abeba che vengono sfrattate forzatamente dalle loro case. I temi dello sfratto e dello sradicamento urbano si inquadrano in un discorso più ampio sull’adattamento, sui suoi significati e le sue sfide, specialmente in contesti di rapido sviluppo urbano e diseguaglianza sociale. Paoletti cattura immagini reali di una delle più recenti demolizioni che hanno spostato le comunità a basso reddito per far posto a progetti urbani su larga scala in una città in rapida espansione. Attraverso la lettera d’amore di una donna, il film si sofferma su ciò che rimane dopo la demolizione – oggetti abbandonati, case vuote e porte dai colori vivaci –, caricando queste rovine di emozioni e nuovi significati metaforici. Lo sviluppo urbano è spesso visto come progresso, ma When I Came to Your Door rivela il carissimo prezzo che per esso pagano i cittadini più poveri. Focalizzandosi sulla distruzione di case e piccole comunità, il regista costruisce un ritratto ossessionante di una città in cui i ricordi e i legami sociali sono cancellati dall’incessante marcia dello sviluppo urbano, smascherando il suo impatto disumanizzante sui residenti più vulnerabili. Il film amplifica il senso emotivo di questi temi e mostra la resilienza delle persone. Più in generale, si interroga su come le città possano adattarsi alle sfide della modernità senza sacrificare vite e rapporti sociali esistenti. Abbiamo incontrato il regista.

Cosa l’ha ispirata per questo film? Ci sono stati un momento o un’esperienza particolari che l’hanno fatta rendere conto dell’importanza di documentare queste storie e temi?
In un certo senso, When I Came to Your Door è cominciato nel 2019, quando sono stato ad Addis Abeba per la prima volta. All’epoca ero solo uno studente di architettura e stavo scrivendo la mia tesi sull’edilizia popolare. L’oggetto della mia ricerca era un quartiere fatiscente del centro storico che stava per scomparire a causa della rapida crescita della città. Mi interessava, in particolare, osservare come le culture urbane esistenti possano sopravvivere, adattarsi o scomparire in momenti di rapida trasformazione urbana. Quale impatto hanno le grandi forze sociali e politiche sui cittadini e sulla loro vita? Ricordo di aver visitato una casa a Talian Sefer, uno dei quartieri storici della città. Fummo accolti da una coppia di anziani a casa loro e parlammo della storia del quartiere e di come la città fosse cambiata. A un certo punto la signora commentò: «Molte zone di Addis Abeba stanno crescendo in fretta, e va bene, ma Talian Sefer rimane sempre uguale». Subito dopo aver detto questo, notai come sembrasse intristita. «Il nostro quartiere dovrebbe essere conservato, non demolito. Dovrebbe restare così, come un museo vivente! Questa è storia, se costruiranno qualcosa di diverso ci dimenticheremo di ciò che è stato». Dopo altre conversazioni simili mi sono reso conto di quanto la modernità possa essere paradossale. Sembra inevitabile: un intero paese lotta per migliorare la propria qualità di vita, ma a causa della velocità di questo cambiamento le famiglie più povere sono sfrattate dalle loro case, demolite per far spazio a costruzioni che valgono di più. Non solo queste persone vengono rimosse, ma il loro capitale socio-economico collassa di conseguenza, perché la rete di supporto reciproco in piccola scala di cui erano parte era essenziale per la loro sopravvivenza. Non sto solo cercando di mostrare il paradosso del progresso, ma più estesamente di condurre il mio pubblico a farsi sempre più consapevole di queste stesse criticità al cui cospetto mi sono ritrovato.
In che modo il tema dell’adattamento si mostra in questo contesto e in che modo queste persone si adattano al fatto di aver perso la propria casa, e quindi di vedere stravolta la propria vita?
Quando visitai il quartiere oggetto del film, questo era già mezzo demolito. Molte famiglie ancora vivevano a casa loro, ma non erano più parte di un denso tessuto urbano. Rimanevano abitazioni sparse in un’area desolata piena di detriti. Arrivai con la telecamera in mano e qualcuno mi urlò contro: «Prima buttate giù tutte le nostre case e adesso venite qui a riprenderci?». Ovviamente c’era molta rabbia e frustrazione nell’aria. Ci vollero parecchie visite e l’aiuto impagabile dell’interprete, Bethlehem Ghidey Gebremedhin, per guadagnare la fiducia delle persone. A poco a poco questi iniziarono ad invitarci a casa loro per offrirci un caffè o un pasto durante i quali poter condividere con noi le loro storie. Ci rendemmo presto conto che molti di loro stavano ancora aspettando di essere risarciti. Era stato promesso loro un lotto di terra in periferia. Ci dissero che le loro case avevano più di settant’anni, Haile Selassie era ancora imperatore. Alcune donne ci spiegarono che si sostenevano proprio grazie al fatto che abitavano vicino alla facoltà di architettura. Lavavano i vestiti degli studenti, rifornivano la mensa, vendevano caffè per strada. Ricordo di una casa di fango, nel 2019 ancora in piedi, che ospitava una stamperia frequentata dagli studenti di architettura. Quando le case furono infine demolite completamente molte persone si trasferirono semplicemente nei quartieri adiacenti, insediandovisi informalmente. Di nuovo una soluzione temporanea che aspetta solo la prossima ondata di demolizione. Al di là della rabbia, si respirava una desolata rassegnazione e una muta accettazione attorno a uno stato di cose di fatto ineluttabile.

Il suo film mostra vivide immagini delle conseguenze disumanizzanti dello sviluppo urbano. Cosa pensa dello scontro tra sviluppo e rimozione? In che modo città e cittadini possono convivere con trasformazione e grandi progetti e insieme rispettare il passato?
Adattamento e resilienza sono valori perfettamente integrati nella cultura urbana di Addis Abeba. La loro origine risale alla storia del loro sviluppo. La città fu fondata nel 1887, inizialmente come raduno di campi militari mobili, localmente chiamati sefer. Con l’imperatore Menelik II molti dei suoi dignitari si stabilirono nelle alture della città con il loro seguito. I vari lavoranti e servitori di palazzo costruirono semplici abitazioni per le loro famiglie e questi insediamenti sono ciò che oggi chiamiamo quartieri, o sefer. I sefer di Addis Abeba sono il diretto risultato delle azioni dei suoi abitanti: le loro reti di vialetti presero forma dallo spazio, mai pianificato, lasciato libero dalle case di fango. La corte, dove i residenti stendevano i panni o mettevano le spezie a seccare, e gli edifici che crescevano nel tempo rispecchiano la crescita di ciascuna famiglia. Questa evoluzione spontanea, organica, dei quartieri della città mostra l’adattamento come un radicato valore culturale. In tempi difficili – povertà, guerra, carestia – i cittadini adottano metodi tradizionali, ancestrali di generare reddito grazie alle loro reti sociali e a una gestione spontanea dell’economia. Eppure oggi questa resilienza è messa a durissima prova dalla rapida urbanizzazione. Alla gente vengono dati solo pochi giorni di preavviso. L’acqua e la corrente vengono poi staccate e le case demolite. I grandi progetti di sviluppo, inclusi i grandi progetti immobiliari, parchi urbani, palazzi privati, autostrade, dominano la politica, che usa questi stessi progetti per dare di sé e del proprio Paese un’immagine di modernità, fatta di progresso e opportunità economiche, il tutto rivolto a investitori esteri ed élite locali. Queste vicende, però, queste repentine e profonde trasformazioni producono un altissimo costo sociale. La demolizione improvvisa di ambienti urbani così stratificati come i sefer è destabilizzante. La lettera che abbiamo trovato in loco mostra perfettamente questa sensazione: è la storia di una perdita non solo dello spazio fisico, ma della vita di persone care che un tempo vi hanno vissuto.
Quali sono i cambiamenti più importanti dell’ambiente costruito verso cui dovremmo sempre meglio prepararci? Che contributo darà il suo film alla discussione sullo sviluppo urbano?
L’aumento dell’ineguaglianza nelle nostre società, che abbiamo visto negli ultimi quarant’anni, può essere visto come un fattore chiave di disordine sociale. Nelle città che crescono più in fretta la disuguaglianza è sempre più evidente. Già nel 1890 il giornalista e pioniere di fotografia sociale danese-americano Jacob Riis scrisse: «Metà del mondo non ha idea di come viva l’altra metà». All’epoca documentava l’incredibile disuguaglianza della New York dell’Ottocento, dove le vite dei poveri erano per lo più ignorate dalle classi elevate e privilegiate. Realizzare documentari è uno strumento molto efficace per sensibilizzare il pubblico. Un documentario prende i fatti e li trasforma in storie comprensibili. Per quanto le demolizioni e l’abuso dei diritti umani ad Addis Abeba siano spesso riportati nei notiziari, questi rimangono nella percezione dei più dei fatti sostanzialmente alieni, venendo quindi facilmente dimenticati. Manca una connessione emotiva che ci induca a riflettere più a fondo a riguardo. Il mio film prova a riprodurre la mia esperienza attraverso la lettera d’amore trovata nel quartiere demolito, che esprime la mesta condizione di sentirsi persi… Ho cercato di restituire una sensazione di mistero e di confusione lungo tutto il film. Nella lettera si parla di un incontro di un amante, ma ciò che si vede è tutt’altra cosa. La dissonanza genera confusione e ci obbliga a cercare di dare un senso a quanto vediamo. All’inizio si può pensare che stiamo osservando le conseguenze di una catastrofe o di una guerra. Ho volutamente lasciato il momento della verità alla fine; è solo allora, infatti, che la causa della distruzione viene rivelata, così che questo momento finale rimane con noi inducendoci a riflettere profondamente su questo stato di cose. I documentari amplificano la voce delle persone, i cui problemi sono spesso invisibili al pubblico e creano una connessione che va al di là dei semplici fatti, quasi a replicare l’esperienza di incontrare persone ascoltando le loro storie.

Viste le sfide globali di migrazione, urbanizzazione e cambiamento climatico che ingaggiano sempre più drammaticamente il nostro Pianeta, quale pensa sia la condizione più urgente cui le città devono e dovranno sapersi adattare? In che modo l’architettura può trovare soluzioni bilanciate e lungimiranti in grado di saper rispettare e salvaguardare le strutture sociali?
Entro il 2050 due terzi delle persone al mondo vivranno in una città. Oggi l’80% degli etiopi vive ancora in zone rurali, ma il Paese si sta urbanizzando rapidamente, la sua capitale in particolare. La popolazione urbana sta crescendo del 4% annuo e alcuni studi indicano che Addis Abeba raddoppierà in popolazione in quindici anni. Camminando per la città si sente chiaramente questo desiderio di sviluppo e modernità e non si può fare a meno di notare quanti cantieri siano aperti. Il tasso di urbanizzazione è tale che si vuole fare tutto il più velocemente possibile, senza riservare alcun tempo per pensare a come realizzare al meglio questa stessa crescita urbana. Si vuole fare in fretta e in gran quantità. Arrivando in aereo si nota subito il risultato di questo modus operandi: distese di condomini tutti uguali ammassati alla periferia della città, replicati monotonamente uno dietro l’altro. Fanno parte di un grandissimo progetto di edilizia residenziale seriale, con infinite ripetizioni di pochi standard fissi, certo importante per creare nuove abitazioni, che però alla fine risultano essere troppo care per la gente comune. Queste strutture fanno poco per creare senso di comunità o per fornire mezzi di sostentamento ai residenti, che per lo più svolgono lavori informali. L’architettura ha un ruolo cruciale nell’affrontare la crisi globale dell’edilizia residenziale. Per affrontare questa sfida dovremo andare oltre a soluzioni standard che badino solo all’efficienza e focalizzarci sullo sviluppo di un’edilizia più varia, capace di soddisfare le esigenze di vita di uno spettro più ampio di classi sociali. Invece di fare affidamento su un singolo progetto che vada bene per tutti, le città dovrebbero saper leggere le aspettative, le necessità di vita delle persone che effettivamente abiteranno questi spazi. Iniziative di design partecipativo, ove i residenti contribuiscono attivamente a dar forma allo spazio in cui vivranno, sono essenziali per creare soluzioni abitative che siano funzionali e che rispondano alla complessità della vita urbana. Lavorando con le comunità residenti, architetti e pianificatori possono creare spazi che siano in grado di fornire ben più di un mero, anonimo luogo in cui semplicemente vivere, costruendo spazi urbani resilienti, inclusivi e connessi.