
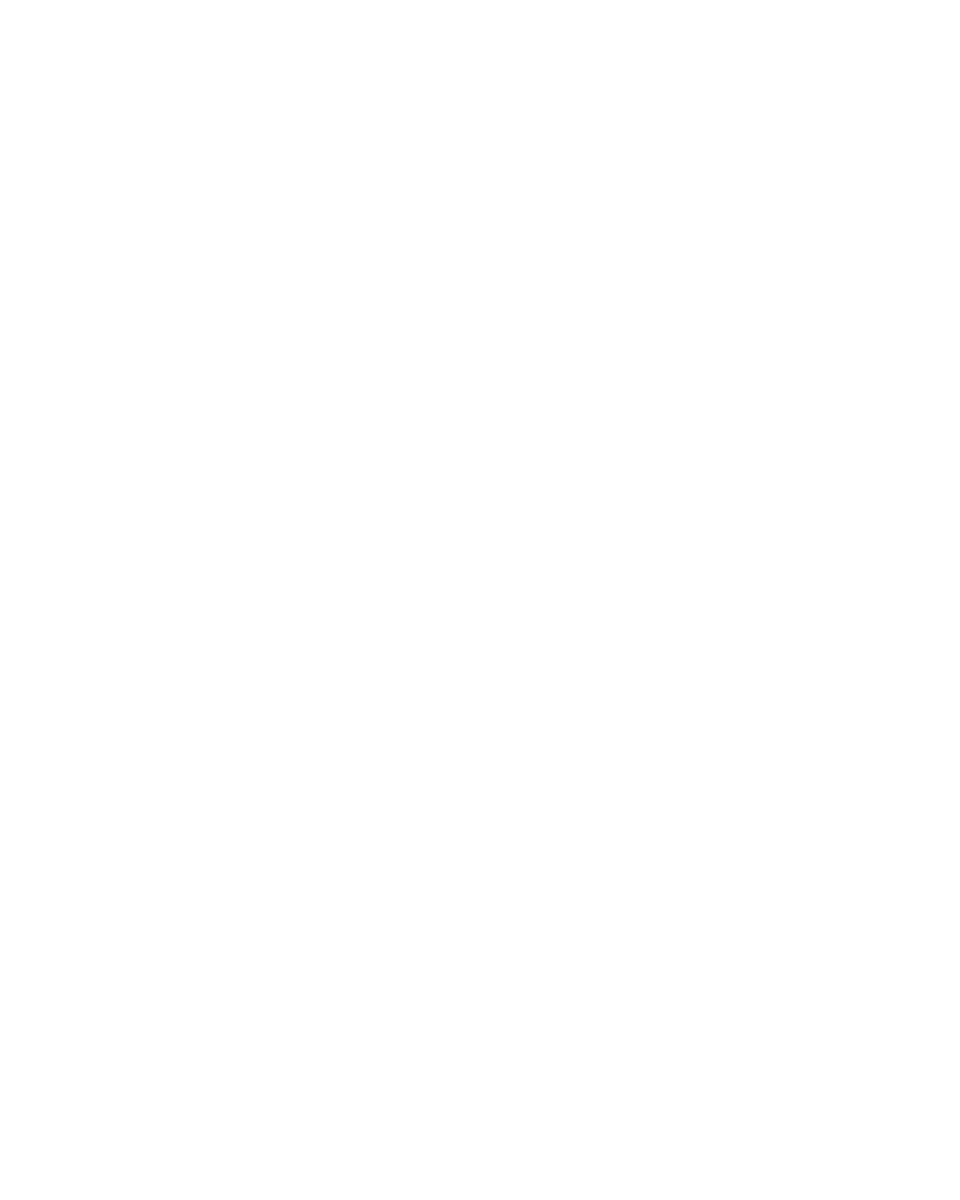
“L’esilio è un duro lavoro”. In questo verso del poeta turco Nâzim Hikmet è racchiusa l’essenza di Yalter, artista nomade, sperimentatrice di mezzi espressivi, pioniera della multimedialità e instancabile esploratrice delle possibilità dell’arte concettuale.
Ho pensato dunque che la naturale evoluzione del mio lavoro sulla tenda mi avrebbe portato a concentrarmi sulle abitazioni temporanee e ad approfondire la vita dei lavoratori immigrati
Riproporre opere iconiche come Topak Ev e L’esilio è un lavoro difficile alla Biennale d’Arte offre un’opportunità unica per riflettere sul suo percorso artistico. Quale è stata l’evoluzione di queste due opere dal loro concepimento ad oggi e che significato hanno per lei?
Ho lasciato Istanbul nel 1965 perché volevo imparare. Non c’era nulla a Istanbul – nessuna galleria, nessun museo e nessuna traccia di arte contemporanea. Ecco perché sono venuta a Parigi e mi sono stabilita qui. Per sette anni mi sono immersa in questo mondo. Ho visitato e ammirato le vere opere degli impressionisti, non più solo le piccole riproduzioni che potevo trovare nei libri; ho esplorato l’arte moderna dell’epoca, ho frequentato mostre di giovani artisti e ho potuto tenermi informata su quanto stava accadendo negli Stati Uniti attorno all’arte contemporanea. In particolare, visitavo spesso la famosa galleria di Ileana Sonnabend, dove ho avuto la possibilità di familiarizzare gradualmente anche con movimenti d’arte concettuale, minimale e pop. Poi, nel 1973, ho incontrato Suzanne Pagé, capo curatrice del Museo d’Arte Moderna di Parigi, e le ho presentato un progetto. Riguardava una tenda che i nomadi Bekdik dell’Anatolia usano come casa. Allora avevo realizzato solo dei disegni di questa yurta, ma Pagé li ha amati a tal punto da propormi una mostra personale entro la fine di quello stesso anno. A quel punto, indirizzata da un amico etnografo, ho fatto un viaggio alla ricerca dei nomadi in Anatolia e sono riuscita a trascorrere qualche giorno presso una delle loro tribù. Le giovani donne della tribù iniziano a costruire la propria tenda dall’età di quattordici anni e, quando si sposano, quella tenda diventa la loro casa. La costruiscono da sole usando pelli di animali, poiché le uniche risorse che hanno a disposizione sono montoni e pecore. Una volta sposate, sono loro che decidono quando il marito può entrare nella tenda. Al contrario, a loro non è permesso avventurarsi all’esterno; conducono una vita principalmente confinata nella yurta mentre il mondo esterno è considerato dominio degli uomini. Parlando con loro ho saputo che tutte avevano mariti, fratelli o figli che, per cercare lavoro nelle fabbriche, si erano stabiliti in grandi città come Istanbul e Ankara, dove erano costretti a vivere in baraccopoli. Altri ancora si trasferivano in Germania, Francia, Belgio e in altri Paesi europei in cerca di migliori opportunità. Il loro comune destino era comunque di vivere in alloggi temporanei e fatiscenti. Ho pensato dunque che la naturale evoluzione del mio lavoro sulla tenda mi avrebbe portato a concentrarmi sulle abitazioni temporanee e ad approfondire la vita dei lavoratori immigrati, in particolare in Francia. Così nel 1976 ho avviato un progetto con alcune comunità, soprattutto turche e portoghesi, a Parigi e dintorni. Ma tornando al progetto della tenda, dopo l’esposizione al Museo d’Arte Moderna la Topak Ev (casa mobile in turco, ndr] ha viaggiato in molti luoghi, poiché può essere facilmente smontata e rimontata. È stata esposta in importanti mostre in Europa e nel 2013 è approdata persino in Brasile. È stato proprio Adriano Pedrosa a chiamarmi, organizzando anche il trasporto della tenda da Istanbul a Rio de Janeiro in una grande cassa. Conosceva già bene il mio lavoro e la sua evoluzione negli anni. Insomma, è stato un processo lungo: dai disegni, alla tenda fino al lavoro che ha coinvolto i lavoratori immigrati.
Com’è stato lavorare a contatto con loro?
A dire il vero, non si bussa semplicemente alla porta dicendo «sono qui per farvi dei video e delle fotografie». Sarebbe come rubare immagini. Ho invece collaborato con sociologi, operatori sociali e reti di associazioni che prestano assistenza alle comunità di immigrati. Il lavoro preliminare è durato circa un anno, dopodiché ho presentato i risultati – disegni, fotografie e video – a Parigi nel 1977. Nei dieci anni successivi ho continuato a espandere il progetto coinvolgendo anche gruppi di lavoratori clandestini impiegati nel tessile, testimoniando le precarie condizioni in cui si trovavano a lavorare, piegati ore sulle macchine da cucire in spazi fatiscenti a respirare sostanze cancerogene. Anche questo nuovo corpus di lavori è stato poi esposto al Museo d’Arte Moderna di Parigi nel 1983.

L’esilio è un duro lavoro. Con questo verso Hikmet intendeva dire che espatriare non significa spostarsi in un posto per trarne semplicemente un qualche profitto, come alcuni potrebbero pensare quando vedono gli immigrati arrivare in Europa via mare. L’esilio è davvero un ‘lavoro’ molto duro.
Oggi sembra esserci un grande interesse per le problematiche degli immigrati, ma lei è stata decisamente una pioniera in questo senso…
Mi sono occupata di questi temi fin dagli anni ‘70, quando la questione dell’immigrazione non era al centro dell’attenzione del mondo dell’arte come lo è oggi. Anche se la popolazione immigrata è cambiata, i problemi sottostanti sono ancora gli stessi. Nel 2012, è nata l’idea di creare dei poster, da esporre nelle aree urbane, abbinando fotografie e disegni di immigrati ad una citazione del poeta turco Nâzim Hikmet, L’esilio è un duro lavoro. Con questo verso Hikmet intendeva dire che espatriare non significa spostarsi in un posto per trarne semplicemente un qualche profitto, come alcuni potrebbero pensare quando vedono gli immigrati arrivare in Europa via mare. L’esilio è davvero un ‘lavoro’ molto duro. Così, ho realizzato questi poster e li ho esposti per le strade in varie città di tutto il mondo – attualmente sono presenti in venti città – insieme alla citazione di Hikmet tradotta nella lingua madre di ciascun paese in cui sono affissi e nelle lingue parlate dalle persone esiliate che vi risiedono. Attualmente siamo anche impegnati nella produzione di un libro con la Biennale riguardante il lavoro sui manifesti. Il progetto, iniziato nel 1973 con i disegni della tenda presentati a Parigi, è dunque ancora oggi in continua evoluzione e spero possa proseguire a lungo anche quando non ci sarò più.
Come sono esposti i due lavori alla Biennale?
Esiste ovviamente una forte connessione tra la tenda e i poster. Adriano Pedrosa ha voluto presentare le due opere insieme, collocando anche i manifesti in uno spazio interno insieme alla tenda, anche se la loro naturale dimensione è quella urbana. Nei parchi e nelle strade delle città in cui vivono gli immigrati rappresentati, suscitano sempre delle reazioni molto forti; in alcuni casi vengono anche strappati con rabbia dai muri. Solo raramente sono stati esposti nei musei. La tenda sarà proprio quella originaria. Il Museo Arter di Istanbul, un’istituzione d’arte contemporanea molto stimata che ha aperto le sue porte circa dieci anni fa, ha acconsentito a concederla in prestito per la durata della Biennale. È la prima volta che le due opere sono esposte insieme.
Il suo lavoro esplora spesso temi legati all’identità, alla migrazione e al femminismo. Come vede il ruolo dell’arte nel trattare le questioni sociali. Crede che l’arte abbia il potere di catalizzare cambiamenti globali?
Penso che senza arte e cultura il mondo non esisterebbe più. Rimango però incerta sul fatto che l’arte determini davvero dei cambiamenti a livello globale. Potrebbe essere esagerato affermare che l’arte cambia il mondo, ma ho visto con i miei occhi come il mio lavoro ha influito nella vita delle persone con cui ho collaborato. Ricordo in particolare un episodio avvenuto nel 1977. Avevo deciso di invitare alcuni dei lavoratori a visitare, insieme alle loro famiglie, la Biennale di Parigi che ospitava un’esposizione dei miei poster. In quell’occasione il direttore si espresse in termini razzisti, dicendo che la loro presenza avrebbe potuto creare dei disagi. Questa sua presa di posizione portò ad un vero scontro, tanto che minacciai di rimuovere il mio lavoro dalla mostra. A quel punto, il direttore acconsentì. Conservo ancora oggi una foto che ho scattato io stessa, un’immagine molto potente in cui si vedono i lavoratori con le loro famiglie mentre discutono tra di loro di fronte alle foto e ai disegni che li ritraggono. Forse, in quel momento, un piccolo cambiamento è avvenuto davvero.

Lei si definisce un’artista autodidatta. Come questo aspetto ha influenzato la sua pratica creativa?
Quando dico che sono un’artista autodidatta intendo dire che non ho frequentato alcuna scuola d’arte o accademia formale. Ho avuto però un periodo di formazione durato almeno vent’anni, durante il quale ho imparato in modo indipendente come utilizzare diversi media, fra cui pittura, disegno, video, fotografia. Da sola ho imparato anche a creare immagini generate al computer. La decisione di rinunciare ad un’istruzione artistica tradizionale è stata intenzionale: ho preferito immergermi in esperienze all’estero. Considero i due anni trascorsi in India e in Iran una forma di istruzione determinante, ad esempio. In Turchia, all’Accademia di Belle Arti, gli studenti trascorrevano settimane o mesi in esercizi di disegno ripetitivi, facendo schizzi dello stesso soggetto più e più volte. Ma anche in Francia alla fine degli anni ‘50 trovavo che le scuole d’arte fossero terribili. L’apprendimento strutturato può avere i suoi meriti, ma non mi sono mai sentita obbligata a seguire quella strada. Forse questo percorso non convenzionale mi ha concesso una certa libertà in più.
Ebbene sì, sono una nomade. Ho viaggiato per tutta la vita, sempre curiosa di esplorare culture diverse. Come mi ha cambiato tutto ciò? Diciamo che mi ha reso più una ‘superdonna’ che una ‘supermigrante’ se vogliamo.
Lei è nata in Egitto, ha vissuto in Turchia e alla fine si è stabilita in Francia. Inoltre, ha menzionato di aver viaggiato in Iran, Pakistan e India. Come queste esperienze l’hanno plasmata e quale relazione percepisce tra identità personale ed espressione artistica?
Ebbene sì, sono una nomade. Ho viaggiato per tutta la vita, sempre curiosa di esplorare culture diverse. Come mi ha cambiato tutto ciò? Diciamo che mi ha reso più una ‘superdonna’ che una ‘supermigrante’ se vogliamo. Durante il mio tempo in India, ad esempio, con mio marito facevamo degli spettacoli di pantomima. Il teatro danza-tradizionale indiano è spesso silenzioso e le performance di pantomima ci permettevano di superare le barriere linguistiche. Questa esperienza ha profondamente cambiato la mia prospettiva artistica. Ho anche incontrato molti artisti importanti, come Ravi Shankar, e la loro influenza si riflette nel mio lavoro: nella tenda nomade così come nei miei dipinti degli anni ‘60 e ‘70, che richiamano motivi dell’arte classica indiana. Tuttavia allora non ho incontrato nessun artista contemporaneo. Era il 1957, può immaginarlo? Non c’erano né turisti né altri stranieri, a parte gli addetti ai consolati e alle ambasciate. Probabilmente anche questo isolamento ha influenzato il mio lavoro. Quindi, sì, la mia arte non sarebbe la stessa se non avessi navigato in contesti culturali così diversi, ma non sono in grado di dire precisamente in quale modo si sarebbe altrimenti sviluppata ed espressa. È una domanda stimolante, ci penserò su…
La sua pratica è caratterizzata da frequenti collaborazioni e incursioni in campi diversi dall’arte. In che modo questo approccio influenza il suo processo artistico?
Mi piace esplorare discipline diverse per garantire accuratezza al mio lavoro ed evitare errori. Collaboro soprattutto con persone provenienti dal campo delle scienze sociali, che spesso mi consigliano libri da leggere su argomenti rilevanti. Non pretendo di diventare una sociologa o un’antropologa, ma dalla loro letteratura o interagendo direttamente con loro acquisisco conoscenze e prospettive cruciali per il mio processo artistico.
Le nuove tecnologie, compresa l’IA, richiedono un’attenta considerazione e vanno maneggiate con molta cautela. Non dovrebbero dominarci o affascinarci; dobbiamo invece mantenere il controllo su di esse, specialmente come artisti.
Cosa la porta a scegliere un mezzo artistico piuttosto che un altro?
Quando decido di passare da un soggetto all’altro, come dalla tenda all’immigrazione e agli alloggi temporanei, seguo un processo che collega i due argomenti insieme. Durante questo processo, il mezzo si manifesta da sé. Proprio come quando l’esercito americano si è imbattuto nella videocamera Sony Portapak. Nam June Paik [artista coreano-americano, considerato il fondatore dell’arte video, ndr] la utilizzò per la prima volta nel 1965. Io la usai per la prima volta solo nel 1973. Tenendola tra le mani ne rimasi affascinata e lo stesso accadde a molti altri artisti in tutto il mondo. Ricordo di aver pensato: “La userò un giorno”. Quel giorno ha coinciso con l’inizio del mio lavoro sugli immigrati di Parigi. Anche molti attivisti e figure politiche in Africa, America e Sud America l’avevano utilizzata, e questo ha rafforzato la mia convinzione che fosse un medium del tutto adatto a ciò che stavo per fare. Anche la fotografia ha suscitato in me un richiamo simile. Questo è ciò che mi porta a scegliere un medium piuttosto che un altro: è il soggetto stesso che mi induce a utilizzarne uno specifico.
Anche l’Intelligenza Artificiale rientra fra i mezzi di cui potrebbe servirsi?
Le nuove tecnologie, compresa l’IA, richiedono un’attenta considerazione e vanno maneggiate con molta cautela. Non dovrebbero dominarci o affascinarci; dobbiamo invece mantenere il controllo su di esse, specialmente come artisti. Certo è che il progresso non può essere fermato. Personalmente, ho lavorato molto con CD-ROM interattivi e vari strumenti informatici, inclusi programmi per la creazione di animazioni tridimensionali e immagini virtuali. Tuttavia, non mi sento affascinata da queste tecnologie; le uso solo quando il soggetto del mio lavoro lo richiede.
Le sue due opere iconiche ai Giardini Biennale per la prima volta esposte insieme