
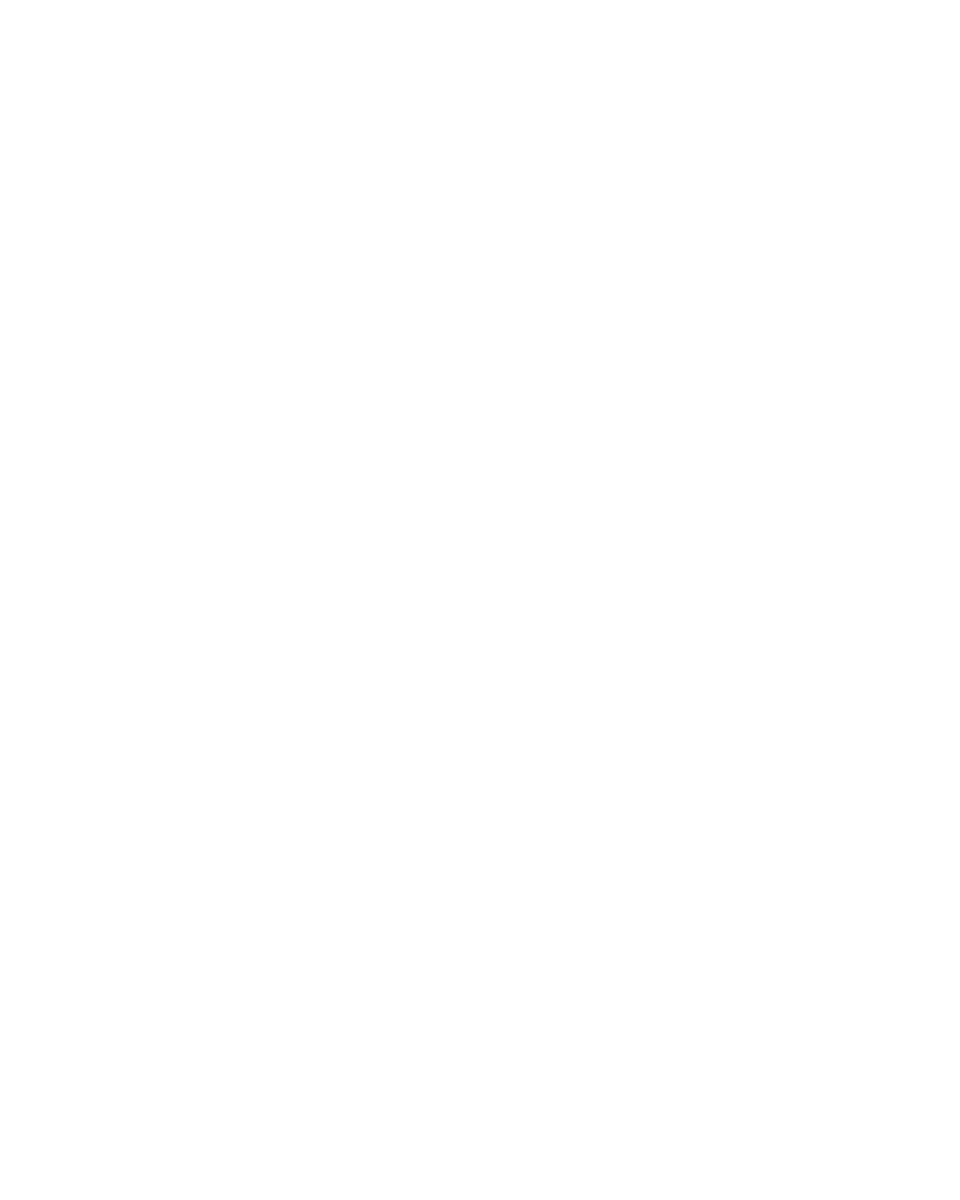
Scrittrice e ricercatrice sudanese-americana, Fatin Abbas esplora nel libro Black Time. Scritti sull’invisibile le relazioni tra diaspora, potere e rappresentazione. In questa intervista ci rivela come la scrittura possa diventare uno spazio critico per abitare il tempo, l’altrove e ciò che resta fuori dalle narrazioni dominanti.
Considero il mio ruolo come una sorta di ponte tra mondi
Autrice e intellettuale di origini sudanesi, cresciuta a New York e oggi residente a Berlino, Fatin Abbas si muove tra continenti, lingue e frontiere ideologiche con un pensiero acuto, radicato nell’esperienza della diaspora e proiettato verso nuove forme di appartenenza. Il suo sguardo attraversa con lucidità le faglie della contemporaneità – il colonialismo mai del tutto tramontato, le guerre dimenticate, la violenza dei confini – e trova nella letteratura uno spazio di resistenza e verità.
Black Time. Scritti sull’invisibile, secondo titolo della collana “Afterwords” curata da Maaza Mengiste per wetlands books, dedicata alle voci più innovative dell’Africa e dell’Afrodiscendenza, raccoglie le riflessioni nate durante il soggiorno dell’autrice a Venezia, tra passeggiate, esplorazioni e momenti di sospensione. Lontano da ogni pittoresco esotismo, il suo sguardo indaga le disuguaglianze radicate nel paesaggio urbano e nella storia, la persistenza dei privilegi coloniali, le forme dell’attesa e del tempo “sospeso” vissuto da chi è costretto a fuggire. In occasione della sua partecipazione a Incroci di Civiltà, e grazie alla casa editrice wetlands che l’ha ospitata in residenza e con cui noi iniziamo da qui un percorso insieme nella letteratura contemporanea, abbiamo parlato con lei di politica, migrazione, memoria e del suo libro, che fa di Venezia un luogo di riflessione globale.

Il primo incontro con Venezia. In Black Time la città è ben più di uno sfondo: è una presenza che innesca riflessioni profonde. Che tipo di effettiva risonanza ha avuto Venezia nel suo percorso di scrittura e pensiero?
Venezia è apparsa in un momento della mia evoluzione in cui ero profondamente preoccupata per la politica, soprattutto a causa dei drammatici sviluppi geopolitici di questo tempo: la guerra in Sudan, il genocidio a Gaza, l’ascesa dell’estrema destra a livello globale e così via. Grazie alla sua ricchezza d’arte e alle numerose storie e culture che vi si intersecano, la città mi ha offerto una tela ideale nella quale poter meglio definire e dipanare le mie idee su ciò che sta accadendo nel mondo oggi. Il paesaggio urbano mi ha ispirato a riflettere su una serie di diversi temi quali il capitalismo, la guerra e il genocidio, l’ambientalismo, il razzismo, la migrazione.
Al Festival Incroci di Civiltà è stata ospite, insieme a Elgas, dell’incontro “Africa Plurale”. Che spunti ha raccolto da quel dialogo? E quale contributo possono offrire manifestazioni di questo genere al dibattito globale attorno a temi di così stringente e drammatica attualità?
Per me, in quanto scrittrice con radici nell’Africa orientale, è sempre stimolante in questi festival letterari entrare in dialogo con autori provenienti da altre parti del continente, perché rappresentano occasioni in cui poter misurare quanto le nostre esperienze possano essere diverse o invece simili. Sono delle preziose opportunità per ricordare quanto l’Africa sia plurale e diversificata: restando a noi, il Senegal, da cui proviene Elgas, ha una storia e un contesto ben distinti dal Sudan, da cui vengo io. Al contempo abbiamo alle spalle importanti esperienze comuni, vedi il colonialismo, su cui Elgas e io siamo concordi nel dire che continua anche oggi, sebbene con modalità e sembianze diverse. Un festival come Incroci di Civiltà è però fondamentale anche per unire voci e prospettive radicalmente ancora più differenti, in particolare quando pone in relazione autori, persone che vivono nel Nord globale con altri che provengono dal Sud del pianeta. Quando ci troviamo nel Nord del mondo può sembrare che ciò che accade in luoghi come il Sudan o il Senegal sia molto distante e poco rilevante; per questo credo che tali manifestazioni siano davvero importanti nella prospettiva di incoraggiarci a riflettere più a fondo sulle relazioni transnazionali.
La sua scrittura è densamente politica, ma mai in chiave programmatica. In che misura scrivere è per lei un atto di resistenza? E come si relaziona a un pubblico europeo o nordamericano?
Stiamo vivendo un’epoca in cui è in atto uno sforzo sistematico per dissociare il linguaggio dalla realtà. Ci viene ripetuto, ad esempio, dalle potenze più influenti del mondo che il genocidio israeliano a Gaza non è un genocidio. C’è una frase dal romanzo distopico 1984 di George Orwell che così recita: «Il Partito ti diceva di rifiutare l’evidenza dei tuoi occhi e delle tue orecchie. Era il loro comando finale, più essenziale». Credo che, in tempi come questi, la scrittura possa rappresentare un atto di resistenza molto importante, perché insiste nel dare un nome alla verità, qualificandola e descrivendola con precisione proprio quando certi poteri cercano di rimodellarla e rinominarla a proprio vantaggio. In quanto scrittrice con radici in Sudan, ma anche americana e oggi legata all’Europa, considero il mio ruolo come una sorta di ponte tra mondi. Perciò mi rivolgo al pubblico nordamericano ed europeo sia come insider che come outsider: da un lato immersa in queste società, dall’altro capace di mantenere, grazie alle mie origini sudanesi, una distanza critica da esse.
Nasce a Khartoum, cresce a New York, vive a Berlino, lavora a Boston… Qual è per lei il rapporto con il tempo e lo spazio? Ma soprattutto, cos’è “casa”?
La mia esperienza di vita è decisamente transnazionale e transculturale ed è legata a esperienze formative di dislocamento e migrazione. La mia famiglia lasciò il Sudan nel 1990, all’inizio della dittatura di Omar al-Bashir, per trasferirsi negli Stati Uniti. Un’esperienza che ha profondamente plasmato il mio rapporto con il tempo e lo spazio. In termini spaziali, ciò significa che sono connessa a molti luoghi, continenti, culture e quindi che ho affondato le mie radici in diverse parti del mondo. Ho al contempo una percezione del tempo che attraversa queste realtà, il che comporta una consapevolezza del fatto che anche il tempo è culturalmente determinato. Il tempo viene vissuto e utilizzato in modo molto diverso a Khartoum rispetto a New York, come racconto nel mio libro Black Time. Per me “casa” non è un luogo preciso, bensì una molteplicità di luoghi, così come un insieme di relazioni, amicizie, alleanze che trascendono i confini geografici. Un altro modo in cui mi piace pensare all’idea di “casa” è ben restituito dalle parole dello scrittore John Berger, che si definiva un “cittadino dell’altrove”. Trovo molto bella questa espressione, perché suggerisce un’idea utopica di casa o di patria a cui si può appartenere, ma che resta ancora immaginata, una casa ideale che deve ancora realizzarsi.
La scrittura è un atto di resistenza molto importante, perché insiste nel dare un nome alla verità, nel nominare e descrivere la realtà con precisione, proprio quando certi poteri cercano di rimodellarla e rinominarla a proprio vantaggio
Negli ultimi tempi movimenti e governi di diversi paesi africani – penso al Sahel e alla nascita dell’Alleanza degli Stati del Sahel (AES) – stanno rivendicando una rottura radicale con l’eredità coloniale francese e con altri modelli ancora imposti dall’esterno. Sono segnali di un nuovo immaginario politico raramente analizzati dai nostri media. Lei come legge ed interpreta queste spinte decoloniali? Le considera parte di un processo reale di autodeterminazione o trova che siano connotate da una certa ambivalenza? E da scrittrice della diaspora, come si relaziona alle trasformazioni in atto nel continente?
Ritengo che i processi di sensibilizzazione verso la decolonizzazione siano importanti, perché hanno il potere di dimostrare con una certa radicalità che il colonialismo non è mai veramente finito con l’indipendenza ufficiale degli stati africani dal dominio europeo. La lotta per la decolonizzazione quindi continua ed è necessario portarla avanti al fine di contenere le pretese e i condizionamenti delle ex potenze coloniali, le quali continuano a esercitare un immenso controllo nel nostro continente attraverso politiche economiche e militari. Ciò detto, generalmente sono assai scettica nei confronti dell’idea di stato-nazione in quanto modello di liberazione. Lo stato-nazione è di fatto un’eredità coloniale ed è basato sull’esclusione, con relativo corollario di violenze, di coloro i quali sono considerati “altri” ed estranei ad esso. Sono più interessata a strutture e a modelli che vadano ben oltre a una dimensione così chiusa e restrittiv, vedi lo sviluppo concreto di un’Unione Africana che possa tenere conto, salvaguardandoli e valorizzandoli, degli interessi di tutto il continente. L’Africa è l’area geografica più giovane del Pianeta; in Sudan, ad esempio, il 61% della popolazione ha meno di 25 anni. Per decolonizzare e liberare davvero le energie positive di questi paesi è necessario infrangere gli schemi politici e ideologici ristretti ereditati dai colonizzatori, sviluppando nuove visioni e modelli che possano permettere a questa popolazione estremamente giovane di esprimere con incisività il proprio potenziale.
In Black Time scrive che la guerra non distrugge solo le case, ma anche il tempo condiviso: quello delle visite lunghe, dei pasti cucinati insieme, della quiete tra le persone care. Oggi il Sudan è di nuovo ferito, teatro di una delle più gravi crisi umanitarie degli ultimi anni. Come attraversa questa fase di tragica sospensione? E come cambia, per lei, il rapporto con la scrittura, la distanza, la memoria?
È stato per me difficile sopportare questa triste e desolante condizione, perché se da un lato sono molto fortunata a vivere da molto tempo in un luogo sicuro, da un altro lato molti membri della mia famiglia si sono visti sradicare dalla loro terra e dalle loro case contro ogni loro volontà, il che mi ha fatto soffrire tremendamente. I sentimenti di ansia, il senso di colpa e l’impotenza sono diventati parte della mia vita quotidiana. Tuttavia, sebbene la catastrofe in Sudan appaia sempre più devastante e ben lontana da una dignitosa soluzione, cerco comunque di fare ciò che posso con tutti i mezzi a mia disposizione: sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sta accadendo lì, supportare le persone finanziariamente, organizzare manifestazioni e protestare per porre fine alla guerra. Mi ritrovo a pensare sempre di più a quale linguaggio e quale letteratura sia meglio utilizzare per affrontare alcuni dei problemi di cui siamo testimoni nel mondo di oggi. Quel che so, e che in parte conforta il mio animo, è che la scrittura in un contesto bellico che ha provocato così tanta distruzione (compresa, tra la miriade di altre, anche la casa di mio nonno a Khartoum) ha rappresentato uno strumento fondamentale per permettermi di preservare alcune storie familiari, alcuni ricordi intimi, che nel loro insieme, nel loro piccolo, restituiscono più estesamente la memoria di un Sudan decisamente altro prima di questa devastazione.