
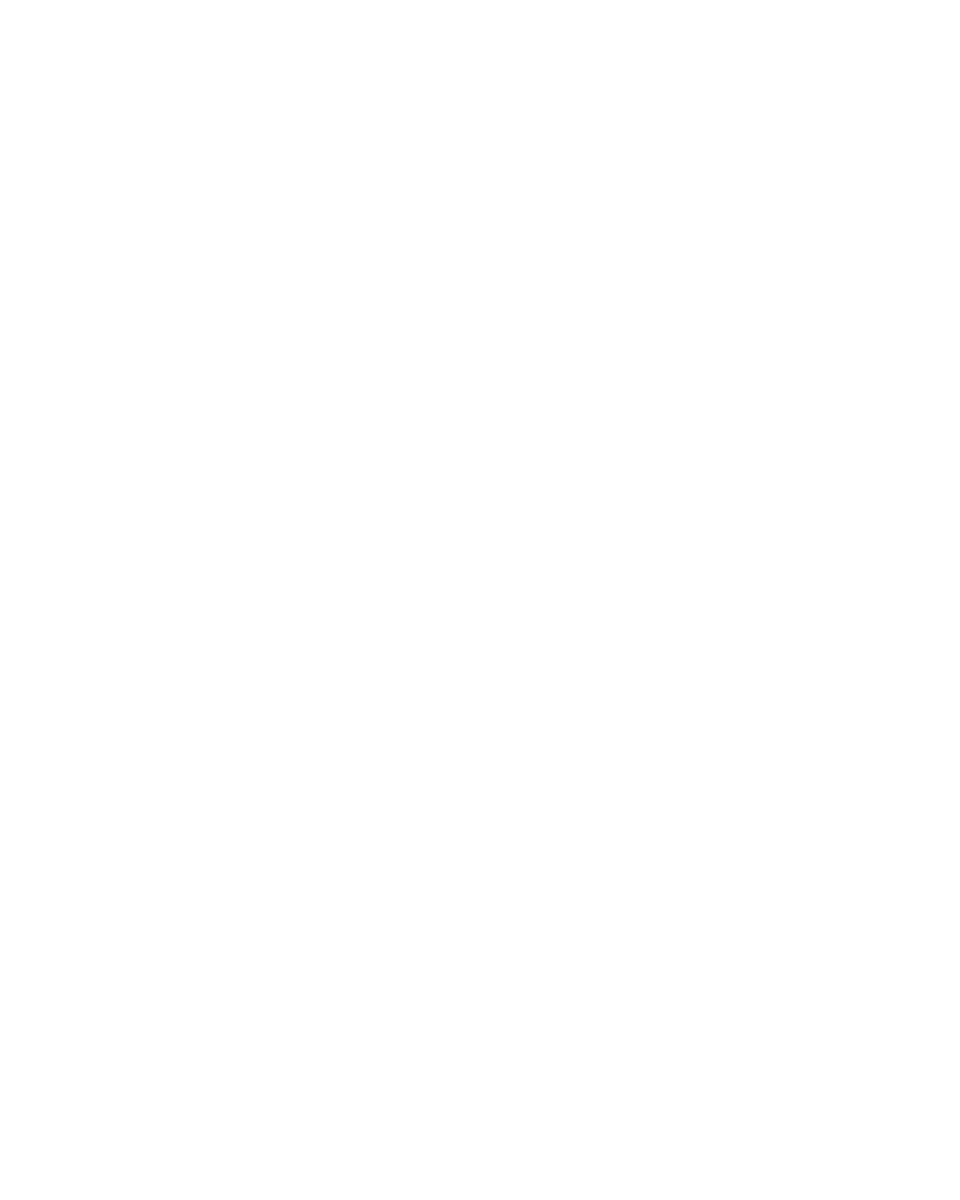
Un’intervista speciale a una persona speciale, l’artista Marina Apollonio, in occasione di un evento speciale, la mostra che celebra la sua arte ospitata dalla Collezione Peggy Guggenheim a Palazzo Venier dei Leoni, o per dirla con le parole dell’artista, «a casa di Peggy».
Una bellissima chiacchierata dove la vita e l’arte, ma soprattutto la curiosità sempre alle prese con l’invenzione e la creazione, l’intelligenza arguta, la passione indomita e l’ironia sagace si mescolano in un flusso di parole per raccontare un’idea di arte che, nello svolgersi del tempo, da movimento di avanguardia e di sovvertimento dell’ordine costituito diventa ora fluido pensiero contemporaneo. «Forse parlo troppo», si è chiesta Marina Apollonio nell’incedere della conversazione. Eppure, detto senza retorica alcuna, nel corso di questo dialogo il tempo era come se fosse un’entità astratta da non misurarsi, come i suoi cerchi in perenne movimento, suo heimat creativo; le parole risuonavano avvolgenti ed entusiasmanti in un racconto vivace che avremmo voluto non finisse mai. Così come la sua ricerca artistica, un corpo vivo e ancora in movimento. All’affermazione durante la conferenza stampa che la mostra alla Collezione Guggenheim fosse la chiusura del suo cerchio espressivo, lei ha ironicamente e prontamente risposto: «Eh no, guardate che c’è anche il quadrato!», invitando tutti a continuare a guardare alla sua arte come un processo in perenne divenire, a prescindere, per l’appunto, dallo scorrere meccanico delle lancette del tempo. Non è possibile di seguito riprodurre appieno l’unicità dell’esperienza di un dialogo aperto con questa straordinaria e affabile artista del nostro Novecento e dei nostri giorni, ma proviamo qui di seguito a restituire almeno in parte quanto abbiamo potuto imparare ulteriormente sulla sua arte facendoci liberamente guidare da lei stessa nel vortice vitale del suo instancabile creare.
Una bella emozione fu quando Karole Vail mi chiamò per propormi un’intervista per la mostra “Peggy Guggenheim. Ultima Dogaressa”, dedicata a sua nonna, che stava curando e a cui voleva partecipassi. Ero veramente sorpresa e onorata. Quello forse fu l’inizio di questa magnifica circostanza che ora mi regala una mia mostra alla Collezione Guggenheim. Ancora non riesco a crederci!

Partiamo dall’inizio, da suo padre, Umbro Apollonio. Quale fu la spinta che la sua figura intima e professionale offrì alla bambina prima, alla giovane poi e infine all’artista compiuta Marina?
Sono riuscita a vedere la mia mostra! Prima donna artista vivente esposta alla Collezione Guggenheim (ride). Sicuramente, lo spirito e l’ironia li ho ereditati dalla famiglia di mio padre, Umbro Apollonio, professore e critico d’arte triestino. Una famiglia molto spiritosa, ironica, e tutta irredentista: mio nonno, i suoi fratelli, mio padre stesso avevano nomi come Virgilio, Dante, Italia, Anita, Garibaldi. Anch’io sono nata a Trieste, ma già a cinque anni ci trasferimmo a Milano, perché mio padre fu chiamato alla Mondadori. Rimanemmo lì qualche anno, fino alla sua nomina a direttore dell’Archivio Storico delle Arti alla Biennale di Venezia (1949-72), e ci trasferimmo in Laguna. A Trieste, mio padre lavorava per Arrigoni e si occupava di pubblicità, scriveva ed era in contatto con grandi intellettuali dell’epoca, come Umberto Saba e Italo Svevo. Quando Svevo morì, mio padre si occupò di sistemare tutti i suoi scritti inediti. Di quegli anni ho ricordi bellissimi: vivevo, seppur piccola, circondata da queste persone interessanti, brillanti, che mi facevano giocare. Dopo Milano, arrivammo a Venezia. Mio padre era molto all’avanguardia, circondato da artisti che trovavano in lui una comprensione che altri critici spesso non avevano. Molti lo aspettavano fuori dal suo ufficio per parlargli, e lui ci raccontava di questi incontri, alcuni davvero esilaranti, come quello con un artista che si vantava di aver inventato una tecnica nuova usando burro invece che olio per dipingere! Ricordo bellissime tavolate con artisti come Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova, Carlo Scarpa e Luigi Nono. Mio padre mi portava spesso con sé, e anche se non parlavo, mi sentivo in soggezione davanti a queste persone così importanti. Questi incontri hanno avuto un forte impatto su di me, anche se da bambina non ne avevo piena consapevolezza. Crescendo, avevo deciso di frequentare il liceo artistico, ma mio padre si oppose, dicendo che gli artisti facevano la fame. Così mi mandarono in collegio a fare studi magistrali, che per me furono una grande sofferenza. Mio padre incontrava figure internazionali della cultura e dell’arte che arrivavano a Venezia da tutto il mondo, soprattutto in occasione della Biennale. Viaggiava molto per conferenze e mostre, e un giorno fu persino invitato dal re Gustavo VI Adolfo di Svezia a un pranzo in suo onore. Ora comprendo appieno quanto sia stato importante per me e per la mia formazione. Dire che lui e le sue conoscenze hanno influenzato la mia vita e la mia arte è riduttivo: è stato qualcosa di molto più profondo e grande.

Nel 1968 conosce Peggy Guggenheim che acquisterà, tra le prime e i primi, una sua opera esposta nella galleria Paolo Barozzi a Venezia, Rilievo n. 505. Quale fu l’importanza di questo primo incontro?
Peggy Guggenheim era amica di mio padre e spesso andavamo a trovarla. Per quanto fossero molto diversi, entrambi erano considerati delle celebrità. Da piccola, ero affascinata dalla sua casa e dal suo giardino. In occasione della mia mostra, ho rivisto con emozione il grande albero che ricordavo allora, oggi diventato immenso. Peggy era una persona forte e speciale: gentile, ma non era una di quelle che accarezzano i bambini sulla testa. Mi metteva un po’ soggezione. Nel 1968, qualche anno dopo l’inizio delle mie ricerche artistiche e dei primi rilievi metallici, fui invitata alla Galleria Barozzi alle Zattere per una personale. Fu lì che Peggy Guggenheim acquistò Rilievo n. 505, a dimostrazione del suo impegno nel sostenere le giovani avanguardie italiane. È un ricordo indelebile e un riconoscimento che mi ha dato la forza e la certezza di seguire la mia strada, confermandomi di essere nel percorso giusto, un sostegno fondamentale anche perché la mia famiglia non credeva particolarmente nelle mie capacità. Dopo le magistrali, avevo trovato lavoro in uno studio di architettura, una disciplina che mi sarebbe piaciuto molto studiare. Ero allora molto giovane, e ricordo che i miei, preoccupati, telefonarono all’architetto per sapere come me la cavassi, e lui rispose: «Vostra figlia è bravissima!». Dentro di me sapevo che era la mia strada, macinavo chilometri per conoscere architetti, artisti o ceramisti.
Nel 1968, qualche anno dopo l’inizio delle mie ricerche artistiche e dei primi rilievi metallici, fui invitata alla Galleria Barozzi alle Zattere per una personale. Fu lì che Peggy Guggenheim acquistò Rilievo n. 505, a dimostrazione del suo impegno nel sostenere le giovani avanguardie italiane.
Quale significato assume ora questa retrospettiva proprio a casa di Peggy? Come nelle sue opere il cerchio del tempo sembra proprio girare costantemente, ritornando al suo punto di partenza…
Questa retrospettiva mi ha dato l’emozione di rivedere e ripensare a tutta la mia vita. Mi sono trasformata da semplice attrice a protagonista. Quando con Marianna Gelussi, ora curatrice di questa mostra, stavamo lavorando alla mia installazione Open Works a Barcellona nel 2018, parlavamo della possibilità di una mia mostra in una sede istituzionale. Marianna insisteva che la facessimo alla Collezione Peggy Guggenheim, ma io pensavo fosse troppo per me! Poi, una grande emozione è stata quando Karole Vail mi ha chiamato per un’intervista sulla mostra Peggy Guggenheim. Ultima Dogaressa, dedicata a sua nonna, e voleva la mia partecipazione. Sono stata sorpresa e onorata. Forse quello è stato l’inizio di questo magnifico percorso, che oggi mi regala una mostra alla Collezione Guggenheim. Ancora non riesco a crederci!

Nel suo porsi senza filtri lei incarna perfettamente la contemporaneità. Non ammette e non considera distinzioni di genere nell’arte: un artista è artista, non un uomo o una donna. Tuttavia trovare uno spazio al femminile nei movimenti d’avanguardia crediamo non sia stata cosa propriamente facile in quegli anni…
Ero molto amica di Dadamaino, una grande artista. Ridevamo tantissimo e ci davamo man forte, perché come donne artiste facevamo fatica a trovare spazio. Quando non fu invitata a una grande mostra di arte cinetica a Milano, nonostante fosse amica di Manzoni, ci rimase malissimo. Negli anni ‘60 le donne erano spesso messe in secondo piano. Dadamaino era simpaticissima, divertente, bravissima, abbiamo condiviso moltissime avventure artistiche. Nel tempo lei è cresciuta moltissimo fino ad arrivare alla sua prima Biennale nel 1980 e alla definitiva consacrazione. Una mostra recente a Firenze da Tornabuoni Arte ha proposto le mie opere, quelle di Carla Accardi e di Dadamaino come le Avanguardie al Femminile. Una consacrazione? Non credo e non ho mai creduto al femminismo inteso come esclusività di genere, in questo credo di essere contemporanea.
Qual è la sua personale definizione di arte?
È un virus, è qualcosa che uno ha dentro. Dadamaino diceva: «Come artiste, ci siamo prese un virus da piccole e non ci passa più». In generale tutti gli artisti dell’Arte Programmata, Concreta, Cinetica e Optical, Minimalista, Geometrica hanno un comune interesse verso un certo pensiero razionale, la maggior parte di loro sono designer o architetti. Oggi c’è la corsa a voler stupire, a piacere a tutti i costi. Io allora ero cosciente di non piacere, la mia arte era troppo all’avanguardia. Ero consapevole delle difficoltà di essere compresa come artista e anche delle scarse possibilità di vendita delle mie opere. Era ricerca allo stato puro.
Lei non contempla l’idea di aleatorietà: “niente è casuale” afferma. Le regole che sottendono ai suoi lavori sono quindi quelle della logica, del rigore, della matematica al fine di creare stimoli percettivi attraverso una combinazione di forme pure e di movimento. Come nasce una sua opera?
Non riesco a fare qualcosa che non sia studiato, controllato. Deve essere tutta di cervello, connessa da un sistema rigoroso. Quando dal poco riesco a tirare fuori molto, allora ho raggiunto un’opera compiuta.
Quale il ruolo della percezione nelle sue realizzazioni?
In mostra c’è un’opera composta da un cerchio bianco e nero, con al centro un quadrato. Quest’opera piacque molto a Bruno Munari, che capì subito. Per me era un genio, anche lui un po’ pazzo.
Quale il ruolo del colore o dell’assenza di esso?
Il colore ha una sua forma, e dare una forma precisa al colore non va bene per la mia ricerca; deve essere puro. Le scanalature bianche favoriscono la percezione dei riflessi del colore fluorescente, mentre le altre creano una diffusione cromatica precisa e calcolata, mai casuale.