
81. Venice Film Festival

80. Venice Film Festival

79. Venice Film Festival

The Biennale Arte Guide
Foreigners Everywhere

The Biennale Architecture Guide
The Laboratory of the Future

The Biennale Arte Guide
Il latte dei sogni

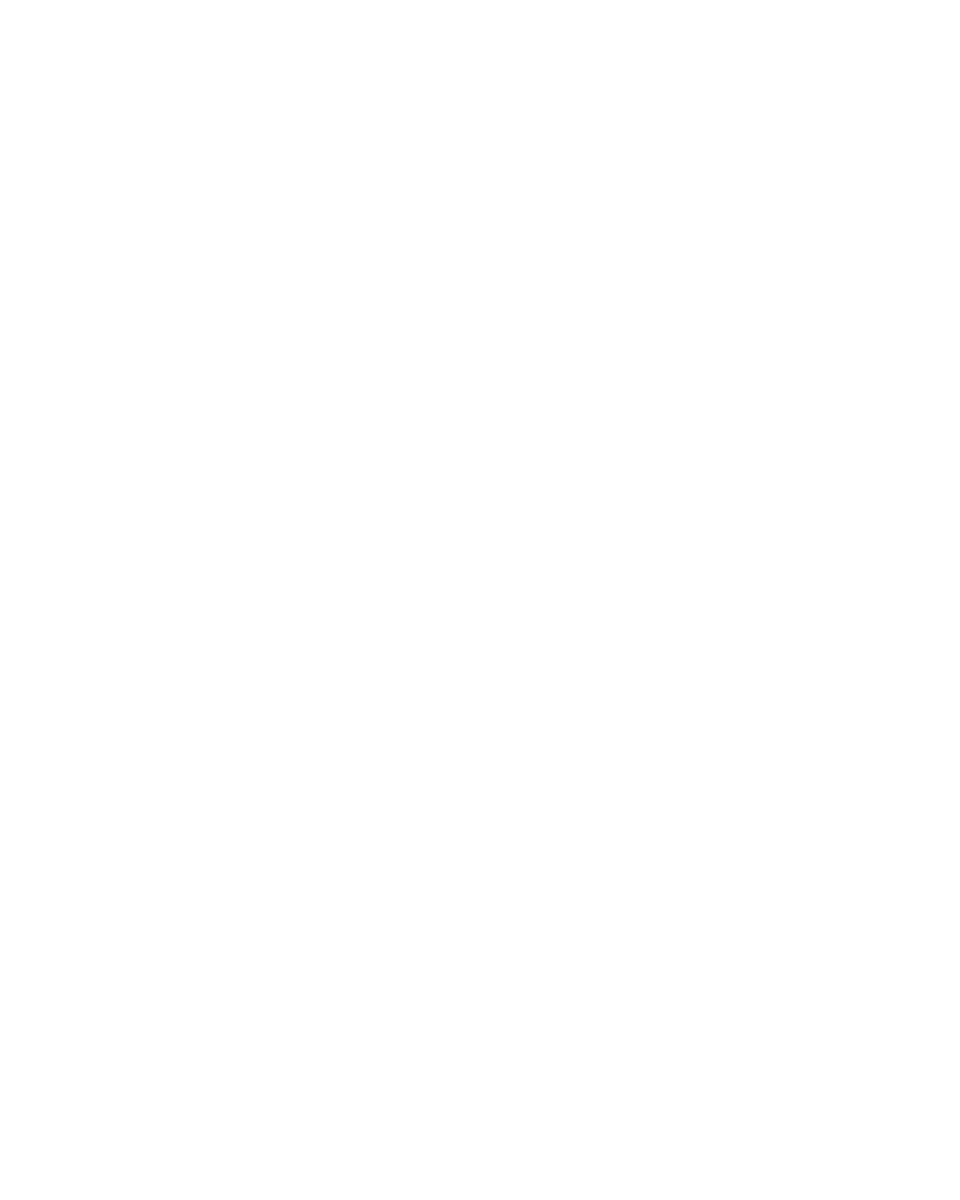
Il cuore della Biennale Architettura 2025 prende forma alle Corderie dell’Arsenale e ai Giardini con un percorso espositivo che si articola intorno ai diversi tipi di intelligenza evocati nel titolo di questa edizione: naturale, artificiale e collettiva. Ne parliamo con il curatore Carlo Ratti.
Con la sua formazione, la sua professionalità e anche la versatilità con cui riesce a dialogare con le altre discipline, Carlo Ratti va incontro a un’esigenza che è quella propria della scienza, orizzonte verso cui l’architettura, e con essa l’idea dell’organizzazione urbanistica, non ha stranamente sviluppato appieno sino ad ora la propria sperimentazione. […] E mai come oggi vi è bisogno di un’architettura capace di dialogare con le nuove scienze, i nuovi linguaggi, digitali e non, che stanno rivoluzionando il nostro esistere quotidiano.
Pietrangelo Buttafuoco
La sua proposta per la Biennale Architettura sembra avere una grande ambizione: ripensare a cosa possa essere e rappresentare oggi una biennale. Nella dimensione oramai sempre più diffusa, globale del fenomeno-biennale, che cosa intende dirci la ‘non ordinarietà’ di Intelligens?
Le biennali nascono come sappiamo con la Biennale di Venezia, archetipo indiscutibile di questo percorso dinamico della rappresentazione del contemporaneo, e hanno un obiettivo specifico: far conoscere e diffondere le idee più interessanti del mondo dell’arte e dell’architettura. Tuttavia oggi, grazie a internet, l’accesso immediato alle opere e alle idee rende meno necessaria la funzione originaria di una biennale in quanto mera vetrina espositiva. Conseguentemente diviene decisamente più interessante pensare al ruolo della Biennale non tanto come una mera esposizione di quel che si è fatto e c’è, quanto piuttosto come uno strumento per promuovere lo sviluppo di idee che ancora non esistono. Venezia quest’anno si fa così laboratorio aperto ad architetti, designer, ingegneri e professionisti di svariate altre discipline al fine di fornire una risposta a una domanda chiave: come possono intelligenze naturali, artificiali e collettive affrontare le sfide di un Pianeta in cambiamento?
Pure Lesley Lokko aveva proposto nella edizione da lei curata due anni fa una formula laboratoriale, anche se nella sua Biennale l’obiettivo era soprattutto quello di rendere visibile una molteplicità di pratiche diffuse nel mondo che restavano perlopiù nascoste o invisibili. Come interpreta l’‘essere un laboratorio’ la sua Biennale?
Lesley Lokko ha curato una Biennale molto interessante, con un forte focus su politica e decolonizzazione. In questo senso la sua è stata una ‘rivoluzione’. Personalmente – e qui forse entra in gioco la mia origine torinese – credo come Gramsci che le rivoluzioni debbano essere condotte anche dall’interno delle istituzioni, trasformandole gradualmente. Quest’anno, perciò, cerchiamo di innovare lavorando con autorevoli istituzioni scientifiche e università, oltre che aprendoci a una grande diversità geografica e generazionale per quel che attiene i partecipanti. In un’epoca di cambiamento climatico estremo è essenziale chiamare a raccolta non solo l’architettura, ma tutte le altre discipline che con essa dialogano e interagiscono, collaborando a livello transnazionale e transgenerazionale per trovare soluzioni concrete alle domande impellenti che ci pone il nostro tempo.
Intelligentia in latino deriva da intus légere, che significa “leggere dentro”, comprendere a fondo le cose. Un processo di comprensione necessario che ci permetta poi di agire in maniera congrua e incisiva. In che senso questa Biennale parla di intelligenza, o meglio, di intelligenze al plurale?
Il titolo della Biennale 2025 è formulato in latino. E non a caso, perché è la radice della parola latina intelligens, participio presente del verbo intelligere, che ha portato alle attuali derivazioni di “intelligence” in inglese e di “intelligenza” in italiano. Abbiamo scelto la versione latina, intelligens, come titolo di questa Biennale proprio per estendere il significato di “intelligenza” oltre la sua comune accezione attuale. Spesso, oggi, quando si parla di intelligenza si pensa subito all’intelligenza artificiale. Ma l’intelligenza ha molteplici forme e a noi interessa esplorare esattamente questa pluralità: intelligenza naturale, artificiale e collettiva. L’etimologia di gens richiama inoltre l’idea di comunità e di incontro tra persone. La nostra Biennale riflette su queste interazioni, cercando di superare la visione tradizionalmente riduttiva della parola “intelligenza”.
In questa Biennale, come da lei appena espresso più sopra, l’architettura pare innanzitutto rivestire il ruolo di disciplina che può mettere insieme altre discipline, al fine di produrre nuove idee all’insegna dell’interazione tra i molteplici linguaggi espressivi del presente. Ciò detto e inteso, cosa può o deve essere oggi, dunque, l’architetto? E cos’è l’architettura?
L’architettura è da sempre una convergenza di intelligenze multiple che ci ha permesso nel corso dei millenni di adattarci a climi ostili. Già nel ‘700 l’abate Marc-Antoine Laugier parlava della “capanna primitiva” come origine dell’architettura, ovvero della necessità di usare alberi, foglie e fronde per proteggersi dalle intemperie. Oggi, di fronte a cambiamenti climatici senza precedenti, dobbiamo continuare a raccogliere quelle stesse intelligenze che ci hanno permesso di plasmare l’ambiente costruito e integrarle con saperi diversi, al fine di elaborare nuove idee utili a progettare nuove soluzioni. Non parlerei più di “rifugio”, termine che, almeno in italiano, restituisce una dimensione quasi escapista, quanto piuttosto di “interfaccia” tra l’uomo e l’ambiente. È necessario a mio avviso individuare che cosa ci sia davvero di nuovo oggi nel rapporto tra architettura e cambiamento climatico. L’architettura si occupa di clima da sempre, ma lo ha fatto storicamente in un’ottica di mitigazione: ridurre l’impatto ambientale, diminuire le emissioni, progettare edifici più sostenibili. Già negli anni ’90 Richard Rogers e Renzo Piano, e con loro molti altri architetti, scrivevano di questi temi. Oggi, però, vi è un elemento aggiuntivo che necessariamente investe questo tipo di riflessione: oltre alla mitigazione, dobbiamo pensare ed elaborare nuove idee per quel che attiene la dimensione dell’adattamento. Su questo fronte l’architettura riveste un ruolo davvero centrale. Per la mitigazione, l’architettura può collaborare con altri settori – industria, trasporti, energia –, ma sul terreno dell’adattamento il suo ruolo è proprio insostituibile. Negli ultimi anni una delle critiche più rilevanti mosse alla Biennale di Architettura è stata quella relativa al fatto che l’architettura, in qualche modo, avesse abdicato al suo ruolo per così dire originario, fondativo, ossia quello connesso all’ambiente costruito, per spostarsi verso altri ambiti più aperti e scivolosi, quali l’arte o la politica. Bene, qui oggi, in questa edizione 2025, avviene esattamente il contrario: questa Biennale riafferma il ruolo centrale dell’architettura nell’ambiente costruito, con una chiamata collettiva in questa prospettiva di tutte le altre discipline in grado di contribuire, naturalmente ciascuna a modo proprio, ad elaborare nuove idee a riguardo.
Una chiamata collettiva che in questa Biennale non emerge solo dal coinvolgimento di ‘ogni disciplina’, ma che è indirizzata anche alle Partecipazioni nazionali, affinché da ‘ogni luogo’ possano giungere idee e pratiche utili a tutti. Come si inserisce in questo contesto la proposta One Place, One Solution per i Padiglioni?
L’idea è che ogni Paese possa condividere con gli altri una propria soluzione specifica, nata da un’esperienza locale e però potenzialmente estendibile altrove. Per la Biennale del 2014 Rem Koolhaas cercò per primo di unificare le tante voci dei Padiglioni attorno a un tema comune con una modalità top-down, ovvero proponendo il modernismo come tema unico da seguire. Con One Place, One Solution quest’anno abbiamo scelto un approccio più collaborativo, bottom-up, stimolando confronti tra i curatori nazionali al fine di riuscire in qualche modo a costruire una narrazione attorno ad un grande filo conduttore comune, fondato sul principio che idee e soluzioni possano venire da tutti i Paesi del mondo, pur nella diversità delle singole voci in campo.
Nel suo progetto anche Venezia si trasforma in uno straordinario campo di potenziale sperimentazione, una sorta di laboratorio vivente. Come è stato concepito questo laboratorio lagunare?
Venezia è un laboratorio naturale e culturale in sé, sintesi mirabile di varie intelligenze: naturale, artificiale, collettiva, per l’appunto. Naturale, perché la laguna è un ecosistema dinamico che si autoregola. Basti pensare a come le acque si rinnovano e si puliscono con cadenza giornaliera in una delle poche città al mondo che non dispone di un sistema fognario compiuto. Venezia è però anche uno straordinario esempio di intelligenza artificiale nel senso inteso dal grande economista e informatico Herbert Simon, ossia un’intelligenza che ha permesso all’uomo di trasformare il mondo costruito. Questa laguna, che nasce come sistema non abitabile, non propizio alla vita dell’uomo, si è trasformata nel tempo in un meraviglioso ‘manufatto’ unico al mondo e quanto mai favorevole all’abitabilità. La città, in terzo luogo, è anche il risultato di un’intelligenza collettiva, frutto di secoli di ingegnosità umana, del lavoro di generazioni e generazioni di donne e uomini che hanno imparato le une dalle altre come strapparla alle acque, creando, conseguentemente, nuovi spazi insediativi. Ciò che in definitiva oggi la rende ancor di più il luogo ideale per sviluppare e testare nuove soluzioni è il fatto che si tratta di una delle città più visibili e al tempo stesso più in pericolo di fronte alla sfida climatica, un vero laboratorio vivente nel quale poter sviluppare nuove soluzioni utili non solo per la città in sé e per sé, ma anche per altri contesti simili nel mondo.
Insieme all’idea di “laboratorio”, anche quella di “ingaggio” è centrale in questa Biennale. In questo senso ci pare che il programma GENS ribalti il concetto di public program, che non sembra qui voler costituirsi come un mero insieme di eventi, bensì come un progetto costruito dal pubblico e in cui i pubblici diventano attori.
Esattamente così, sì. Se, come abbiamo detto, non si tratta più qui solo di parlare di architettura, bensì di tutte le discipline che convergono nell’epicentro vitale dell’architettura, allora si rende necessario aprire la discussione ad un pubblico assai più vasto del solito e certamente non più limitato agli operatori di settore, ad architetti che parlano esclusivamente tra di loro. Quest’anno abbiamo deciso di trasformare la Biennale in una piattaforma aperta: invece di pochi incontri tra esperti, abbiamo coinvolto grandi istituzioni globali come il World Economic Forum e C40, così come gruppi di studenti o di professori che hanno proposto workshop e discussioni su svariati temi. Una piattaforma che intende parlare non solo agli architetti, ma a tutti coloro i quali, pur non essendo tecnici del settore, intendono conoscere, assorbire nuove idee e soluzioni del nostro vivere il mondo oggi.
Lei ha parlato in diverse occasioni di open source in relazione all’architettura. Come affronta questo approccio aperto la Biennale Architettura 2025?
Se potessi ricominciare la mia carriera, probabilmente studierei biologia, perché l’architettura, come la natura, si basa su un processo evolutivo fatto di tentativi, errori e adattamenti. Riesce a incorporare input plurimi per poi creare molti feedback loop, ovvero ritorni di vario tipo che poi evolvono. Questo principio è alla base dell’open source: condividere idee, testarle, modificarle e farle evolvere. Intelligens cerca di applicare proprio questo modello: un’architettura che parli più il linguaggio della biologia e meno il linguaggio dell’autorialità, aprendosi alla partecipazione e al contributo di molteplici attori.
Come si attraversa questa Biennale? Cosa direbbe al pubblico che si appresta a visitarla?
Gli direi di osservare come l’architettura risponde al cambiamento climatico in termini di mitigation o di adaptation e di considerare l’architettura come un processo, una progettualità che presuppone in sé il cambiamento. «L’architettura ha torto, ha ragione la vita», questo diceva Le Corbusier a chi gli faceva notare che nel bellissimo villaggio ideale di Pessac gli abitanti avevano poi completamente travisato e trasformato ciò che lui aveva progettato. Questa Biennale non è solo un’esposizione da guardare, ma un luogo in cui partecipare e interagire. Il visitatore è invitato a esplorare, discutere, contribuire. E Venezia tutta diventa un’arena di sperimentazione aperta, un terreno condiviso dove architettura e società si incontrano.
Per cosa vorrebbe venisse ricordata la sua Biennale in futuro?
Mi soffermerei su due punti fondamentali. Il primo può essere riassunto con la frase from mitigation to adaptation. L’architettura è centrale quando si tratta di adattarsi a un ambiente che cambia, come dobbiamo fare oggi. Il secondo è togetherness: questo processo può avvenire solo insieme. Quando organizzi una Biennale puoi scegliere se renderla divisiva o inclusiva. Di fronte alle sfide che siamo chiamati ad affrontare oggi l’unica risposta possibile è quella di unire comunità diverse, architetti e discipline varie per far fronte a un problema enorme che pretende visioni collettive.
Una curiosità infine: in tanti progetti passati ha spesso collaborato con grandi chef e anche in questa Biennale ci sono progetti costruiti in collaborazione con dei maestri della cucina. Da dove deriva questa sua disposizione a connettere due mondi così altri? Come descriverebbe la relazione, le possibili affinità tra cucina e architettura?
È vero, ho incontrato e collaborato con diversi chef. Mi viene in mente la famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio per il progetto di Mutti, oppure lo chef Niko Romito per un progetto all’Expo di Dubai. Ho anche vari amici chef, come Davide Oldani, che è presente in un progetto in questa Biennale, e Carlo Cracco, con cui però non ho realizzato progetti specifici. E poi David Barber, lo chef di Blue Hill. Mi piace cucinare, quindi questo mondo mi interessa naturalmente. Ma al di là della mia passione per i fornelli, credo vi sia effettivamente qualcosa di profondamente affine tra cucina e architettura, soprattutto se si vede questa affinità dal punto di vista degli ingredienti. Il modo più creativo di cucinare non è decidere prima il piatto e poi comprare gli ingredienti, ma partire da quello che si ha a disposizione per poi capire cosa si può creare. È quello che ha fatto ad esempio Massimo Bottura con il suo “pesto di pangrattato”. Così funziona anche l’architettura: la più interessante è quella che parte da ciò che già c’è cercando di infondergli un nuovo gusto.
Naturale, artificiale, collettiva: Carlo Ratti presenta la sua Biennale Architettura
Argentina, Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Svizzera
Brasile, EAU, Germania, Islanda, Turchia, Uzbekistan