
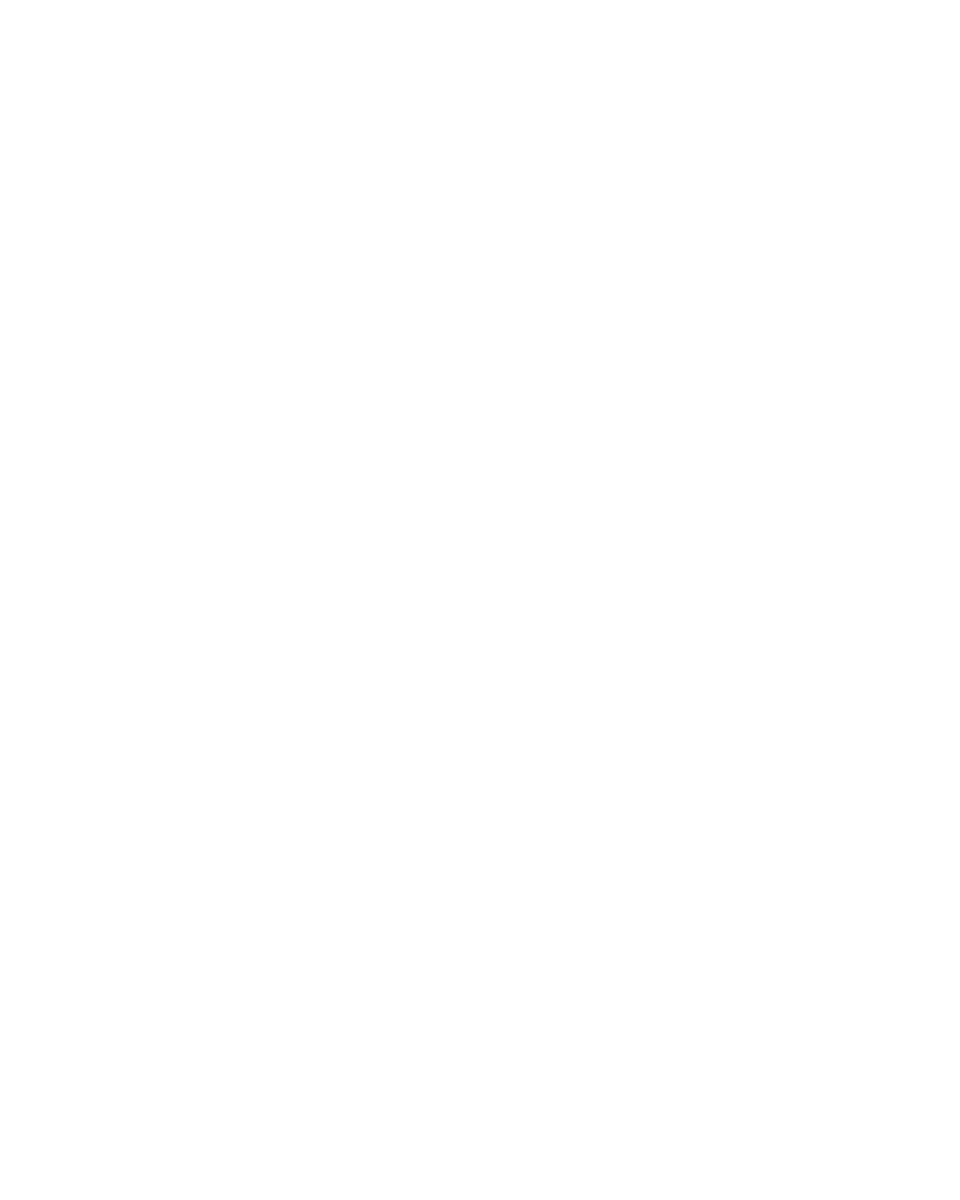
Tra gli ospiti più attesi del 50. Festival, il regista svizzero Milo Rau è protagonista di questa Biennale Teatro che gli dedica una vera e propria rassegna cinematografica, Milo Rau: Actvism and Intimacy a Palazzo Trevisan degli Ulivi. In attesa di vedere il suo spettacolo-manifesto La reprise. Histoire (s) du theatre, lo abbiamo incontrato via Zoom per parlare di teatro, di film, di politica, di mondo, di cose da cambiare…
Milo Rau è nato a Berna, ma è sin da subito cittadino europeo. Ha studiato a Parigi, Zurigo e Berlino e grandi sono stati i suoi maestri. Tra questi Tzvetan Todorov, autore dell’imprescindibile saggio sui formalisti russi con la sua analisi delle leggi del discorso letterario. In Milo Rau troviamo la sua teoria del testo come dialogo tra più anime e diverse culture. E ancora Pierre Bourdieu, sociologo tra i massimi del Dopoguerra, il cui studio sulla violenza simbolica si legge dietro le parole di Milo nella denuncia verso i ceti dominanti che impongono il loro universo di produzioni simboliche non solo come legittime, ma come le uniche veritiere. È attivo come giornalista con i suoi reportage sull’America Latina per la «Neue Zürcher Zeitung», ma presto si volge al teatro, a Berlino, Dresda, Parigi. Nel 2007 fonda una compagnia di produzione teatrale e cinematografica, con un’estensione editoriale, dal non accattivante nome “Istituto Internazionale di Omicidio Politico” attiva nella promozione di azioni politiche, il cui primo lavoro è dedicato agli ultimi giorni della dinastia Ceausescu, The Last Hour of Elena e Nicolae Ceausescu del 2010. Sono seguiti Hate Radio, sul genocidio in Ruanda, e Breivik’s Statement, sull’omonimo terrorista norvegese autore dell’attentato del 2011 che provocò 77 vittime. Nel 2013 Milo è sulle pagine di tutti i giornali per aver allestito una rappresentazione a Mosca della durata di più giorni: The Moscow Trials, un vero e proprio processo alla persecuzione di artisti e dissidenti da parte del governo di Putin, con un focus sulla storia delle Pussy Riot, movimento di artiste femministe.
A Venezia sarà uno dei protagonisti più attesi di questa 50. Edizione di Biennale Teatro, durante la quale presenterà una serie di opere filmiche e una messa in scena teatrale. È prevista una vera e propria rassegna cinematografica a lui dedicata, Milo Rau: Actvism and Intimacy, che si aprirà con Orestes in Mosul, The making of (2019) proiettato a Palazzo Trevisan degli Ulivi. Oreste, figlio di Agamennone, al centro di numerose tragedie greche, protagonista di una infinita catena di sanguinose vendette, viene riportato in Siria, nella piazza centrale di Mosul, teatro di reciproche esecuzioni nella guerra tra IS, esercito siriano e curdi, dando voce ad abitanti, testimoni e artisti locali. Vedremo poi The Congo Tribunal, un colossale processo – 7 le telecamere usate, 1000 le persone coinvolte – alle compagnie minerarie occidentali, al governo congolese, all’Europa e alla Banca Mondiale per le loro responsabilità nella ventennale guerra civile che è costata sinora oltre sei milioni di vittime. Una scenografia spettacolare e iperrealistica connota Familie, film che ci porta a Calais e all’ultimo giorno di vita di una normale famiglia francese che decise di suicidarsi nel 2007. La scena di intimità domestica pervade lo spettatore con l’uso spregiudicato della tecnica cinematografica, dove zoom, controcampi, primi piani dominano, mentre al contrario si cercano nei meandri taciuti degli atti privati le ragioni dell’estremo atto e del biglietto lasciato nel luogo della tragedia: «Scusateci, siamo andati troppo lontano». Girato nel 2019, il docufilm The New Gospel, opera che chiude la rassegna, è ambientato invece nel nostro Sud, dove migranti africani sono costretti ad un bracciantato schiavista nei campi di pomodori, arance e carciofi. Una schiavitù di cui è responsabile, ancor più del caporalato, un sistema economico dominato dalla ragione totalizzante del profitto. La domanda d’obbligo è: se oggi rinascesse Gesù, da che parte starebbe? Dove cercherebbe i suoi apostoli e i suoi fedeli? Il film segue le vicende di Yvan Sagnet, che guidò il primo sciopero di braccianti agricoli immigrati nel Sud Italia e che ritorna qui nei campi della rivolta.
Venendo infine al teatro, venerdì 1 e sabato 2 luglio Rau porta in scena al Teatro Piccolo Arsenale La reprise. Histoire (s) du theatre. Qui è rappresentato appieno il Manifesto di Gent, scritto e pubblicato dal regista svizzero, che al primo punto recita: «Non si tratta più di dipingere il mondo. Si tratta di cambiarlo. L’obiettivo non è rappresentare il reale, ma rendere la rappresentazione essa stessa reale». Di questa opera teatrale vanno evidenziati almeno due piani: il primo, la narrazio- ne della storia di Ihsane Jarfi, giovane omosessuale belga, ucciso quasi per divertimento, dove prevale l’indagine sociale, politica, psicologica attorno al fatto di cronaca; il secondo dove al centro vi è una riflessione forte sul teatro, sul corpo di attori professionisti e volutamente non professionisti e sul pubblico, che viene colpito e reso complice dei processi emozionali che il dramma innesca. Lo spettatore viene addirittura chiamato in causa, reso partecipe della scelta di vita o morte. E per riprendere uno scrittore caro a Milo Rau, Walter Benjamin, non sarà più possibile aprire una pagina di un libro amato e «consolarsi nell’indugiare, circondato da tutti gli strumenti della mia tortura – quaderni per i vocaboli, compassi, dizionari – là dove la loro autorità risultava vanificata», e sarà probabilmente necessario riprendere l’undicesima Tesi su Feuerbach di un forse non più famoso pensatore tedesco che si chiedeva se il compito di un filosofo fosse solo di interpretare il mondo o forse invece di provare a cambiarlo.
Wolfgang Borchert nel suo Draussen vor der Tür metteva in scena un Dio al quale nessuno portava più rispetto e che invidiava la Morte per essere diventata il nuovo vero Dio. Si era alla fine della Seconda Guerra mondiale. Tuttavia i tempi non sembrano molto cambiati. Secondo lei la violenza è connatu- rata nell’uomo? Vi può essere un ruolo propositivo dell’artista nel provare a depotenziarne i devastanti effetti o il teatro, il cinema, possono solo limitarsi a rappresentarla?
Ci sono molti modi per reagire o essere proattivo verso la violenza e la guerra. Ogni spettacolo, ogni produzione è la creazione di una “Repubblica” originale e collettiva, di una comunità che altrimenti non sarebbe sorta. Penso che vi sia bisogno di più progetti comuni; direi di sicuro di un progetto comune per l’umanità o quantomeno per l’Europa. I falsi dei abbondano: dittatori, nazionalismo, capitale… Ciò che l’arte può fare è rappresentare il passato e un possibile futuro, mostrarli da diverse angolazioni, sotto una luce diversa. Vogliamo vedere cose che non siamo stati capaci di vedere nel momento in cui sono accadute, vederle con gli occhi di qualcun altro, osservare la differenza quando lo stesso contenuto è mostrato in luoghi diversi. Una rappresentazione non è mai sempre la stessa; se la si metta in scena in Ucraina, in Italia, in Iran, la lettura e la percezione cambiano radicalmente. Una regola è bene impararla ed è molto democratica: non vi è significato indipendentemente dal lettore.

Come si può rispondere alla critica, che ancora oggi viene sollevata, che una continua riproposizione della violenza, la sua spettacolarizzazione al cinema, in televisione, nei media in genere, non fa altro che renderla abituale?
Penso che la violenza fisica non abbia senso. Ricorrere alla violenza significa disconoscere la situazione, svuotarla di ogni significato e ridurre il tutto a puro dominio, umiliazione, morte. Ciò che il teatro può fare è recuperare il significato, riprendere il senso nell’atto della rappresentazione. Ecco perché l’opera che porto a Venezia si chiama La reprise e non La repetition. È una differenza ben presente nel pensiero di Kierkegaard: guardare al passato per dargli un senso collettivo nell’atto della rappresentazione. Questo è il motivo per cui è nato il teatro: per dare un significato alla vita, evitare l’oblio, raccontare una storia.
L’arte e il raccontare storie hanno una funzione catartica, rendono possibile una trasgressione collettiva e poi ci ricordano che tutti prima o poi dovremo morire, che la violenza abita le nostre vite. Esiste e i media ne parlano. Vi sono ambienti elitari che cercano di crearsi uno spazio protetto e sicuro, di eliminare attorno a sé ogni violenza, o meglio, di esportarla nel Terzo Mondo o confinarla nell’industria del porno, escludendola dalla cosiddetta Arte. Questa è la nostra condizione, la nostra contraddizione: un sistema economico che crea attorno a noi uno spazio sicuro e che al contempo ci permette una cultura trasgressiva.
Per riprendere Kierkegaard, come rappresentare tecnicamente La reprise e non La repetition? Di certo abbiamo perso il credo religioso. Quando ho girato in Italia il film sul Vangelo, The New Gospel, un sacerdote mi ha detto: Milo, la Bibbia non è un libro di storia. Il Nuovo Testamento può solo essere messo in pratica. Non significa nulla se non nel momento della realizzazione dei suoi principi. Il mio atto di fede è una forma di rievocazione su un palcoscenico, oggi, con l’arte; o si potrebbe qualificare come una sorta di rituale, una ripresa della qualità, dell’atmosfera e del significato di un qualche evento.
Non si tratta più di dipingere il mondo. Si tratta di cambiarlo. L’obiettivo non è rappresentare il reale, ma rendere la rappresentazione essa stessa reale
Recentemente ho ripreso in mano Blok e il suo I dodici, il primo poema dedicato alla rivoluzione. I dodici marciano con la bandiera rossa, ma in testa, invisibile, vi è Dio. Lei pensa che la religione possa giocare un ruolo importante anche nel futuro?
Penso che la religione o ogni forma di credo in una qualche trascendenza rendano possibile dare un significato alla nostra esistenza. Se pensiamo alla nostra reazione alla pandemia, il nostro timore della morte è la paura di doversene andare, sparire per sempre. L’atto di credere, e di nuovo, l’atto di rappresentare, di produrre arte o qualsiasi altra forma di rituale che cerchino di dare eternità al momento funziona solo su base collettiva. È questo l’errore grave della Riforma Protestante del XVI secolo: il credere di poter avere un rapporto diretto, individuale, con Dio. Io non penso che questo sia possibile. Solo collettivamente si può pensare di creare qualcosa che si avvicini ad un rapporto con il Divino. E credo anche che questa idea di condivisione rappresenti la matrice fondante della fede, del messaggio della Bibbia. Il Nuovo Testamento non dice “se vi è un uomo, vi è Dio”. Dice: “se siete in due, tre o quattro, Dio è con voi, fra di voi”. Questo significa che Dio è solo nella pluralità degli esseri umani.
E questo è anche il significato di riunirsi per fare arte. Qualunque rituale, una manifestazione, un atto d’amore, un insegnamento…, senza questa convinzione che l’unione costruisca un senso mentre al contrario la solitudine lo distrugga non potrà che perdere di ogni significato, fallire da un punto di vista della ricerca di una fede in un qualche Dio.
Se si guarda indietro alla nostra storia, abbiamo certo Alexander Blok, ma si può andare ancora più indietro e arrivare allo Strutturalismo. Gli strutturalisti affermano che il linguaggio, la vita, il tempo esistono indipendentemente da noi. Non so se il senso della trascendenza possa essere materiale. Il pensare che la trascendenza non esista è una incomprensione razionale degli ultimi cento anni, ma in realtà è una sorta di convinzione apocalittica che tutto finisca quando si muore. Certo, a chi importa se sei morto? Ma tutto ciò che abbiamo creato insieme rimane. Si potrebbe dire che, essendo marxista, sono un credente. E penso sia necessario essere marxisti e strutturalisti per credere. Lo aveva detto Karl Marx: la società borghese smetterà di credere perché il capitalismo non lo richiede. Le persone si devono riunire insieme nel mercato, ma non in altre forme. Il pericolo della scomparsa della fede è che altri credo possano invadere la nostra società ed essere usati come strumenti di propaganda. È ciò che sta avvenendo oggi in Russia. L’assenza di credo è un pericolo: questo è il problema, non il fatto che non esiste più.

La critica in arte è un valore in sé premiato dalla società e dalle istituzioni?
I tempi della critica, della critica istituzionale e della strategia dei borghesi sono finiti. Per sessant’anni abbiamo detto: includeremo questa minoranza, includeremo questa critica. In Stato e rivoluzione, pubblicato prima della Prima Guerra mondiale, Lenin scrisse che nel momento in cui avrebbero eretto un monumento per il rivoluzionario la rivoluzione sarebbe finita. Ecco, penso che la nostra intera industria culturale sia una fabbrica di ‘statue’ per la critica.
Sono convinto che questo circolo vizioso stia per finire. Ritornando a qualche mio lavoro filmico, analizziamo ad esempio l’assemblea generale democratica del governo mondiale convocata a Berlino al centro del film General Assembly del 2017, o i processi del Congo, o quello ancora di Mosca: sono nuove istituzioni e “tribunali” che abbiamo creato semplicemente perché non esistevano, perché non esistevano strumenti idonei ad affrontare dei problemi dati. Venendo alla stretta, tragica attualità, non ha alcun senso a mio avviso indugiare a criticare a parole il regime di Putin. Vedo solo il senso di costruire un’istituzione come un tribunale contro Putin, che abbia il potere e la base legale per giudicarlo, creando così i presupposti sostanziali perché si determini un’altra condizione politico-istituzionale in Russia. E questa è la lezione del tardo capitalismo che è ultrainclusivo, capace di includere, come lei dice, la trasgressione e la critica all’interno del proprio funzionamento.
Una regola è bene impararla ed è molto democratica: non vi è significato indipendentemente dal lettore
Berlino, Avignone, Venezia, Bruxelles: i festival di teatro sono diventati le vetrine più importanti per presentare autentiche novità, anche forse perché liberi dalla regola di mercato degli incassi da parte del pubblico. È vera questa affermazione o i teatri locali possono competere? Penso a realtà quali NT Gent, Schaubühne Berlin, il Gorki…
Il punto vero è che abbiamo anche teatri che funzionano come i Festival. I Festival hanno una durata limitata, invitano e co-producono. I teatri sono aperti tutto l’anno e producono. I grandi Festival si tengono in estate anche perché in questa stagione i teatri sono chiusi. Ora che sono alla guida di una Istituzione (NT Gent) conosco la differenza. Con un team di oltre cento persone si deve ragionare in termini di uno, due, tre o quattro anni e naturalmente l’energia è diversa. Con una responsabilità collettiva di questa entità si è meno liberi di un curatore alle prese con una rassegna limitata nel tempo. Con un teatro puoi creare anche un legame particolare con il pubblico, che spesso viene agli spettacoli proprio perché è il pubblico di quel teatro. Entro certi limiti puoi presentare in palcoscenico ciò che vuoi. L’umanità ha una tendenza estrema a diventare simile. Talvolta penso che il festival di Bruxelles e quello di Berlino abbiano un programma molto più simile di quanto non lo possano avere due teatri di Berlino.

Quale è il ruolo del Dramaturg in tutto questo?
Per quanto riguarda il ruolo del Dramaturg dipende da come si affronta il problema. Se si vuole mettere in scena Cechov, il ruolo del Dramaturg è zero; diventa abbastanza superfluo quando si dispone di buoni attori. Per me l’idea è di partire, come descritto nel Manifesto di Gent, da una pagina vuota; questo sia per il direttore che per tutto il collettivo che dovrà con lui lavorare. Quando non sai ancora cosa vuoi fare ecco allora che il ruolo del regista, del Dramaturg, dell’attore, diviene importante. Ognuno esce dal suo ruolo strettamente professionale divenendo responsabile del tutto, del contenuto della storia, della sua forma. Ecco che tutti sono diventati Dramaturg. La figura è stata introdotta, penso, da Bertold Brecht nel teatro tedesco e si è affermata grazie a Göbbels durante la guerra. Egli affermò di essere il più grande Dramaturg della Germania, dell’arte tedesca. E lo ha saputo bene interpretare.
Un’ultima domanda: le opere che sta per presentare alla Biennale quale ruolo ricoprono nella sua produzione artistica?
Presenterò il mio metodo di lavoro. Porto La reprise che rappresenta la mia tematica di base. La questione della trascendenza, della violenza, del realismo, dentro vi è tutto. È la piattaforma programmatica, il Manifesto di Gent. Inoltre porto The New Gospel e altri tre film, Familie, The Congo Tribunal e Oreste in Mosul. Anche questi sono film metodologici di diverso tipo e vengono utilizzati per descrivere la società e soprattutto indurre in essa un cambiamento. Inoltre terrò seminari sulla sola domanda importante: ovvero come rappresentare la società e specialmente la sua parte oscura, la violenza che ne promana. Direi, quindi, che presenterò qui a Venezia una serie di lavori che non possono che attraversare e restituire in maniera forte i temi su cui mi interrogo incessantemente in altri luoghi, in altri contesti. Quindi opere centrali, nodali del mio percorso.