
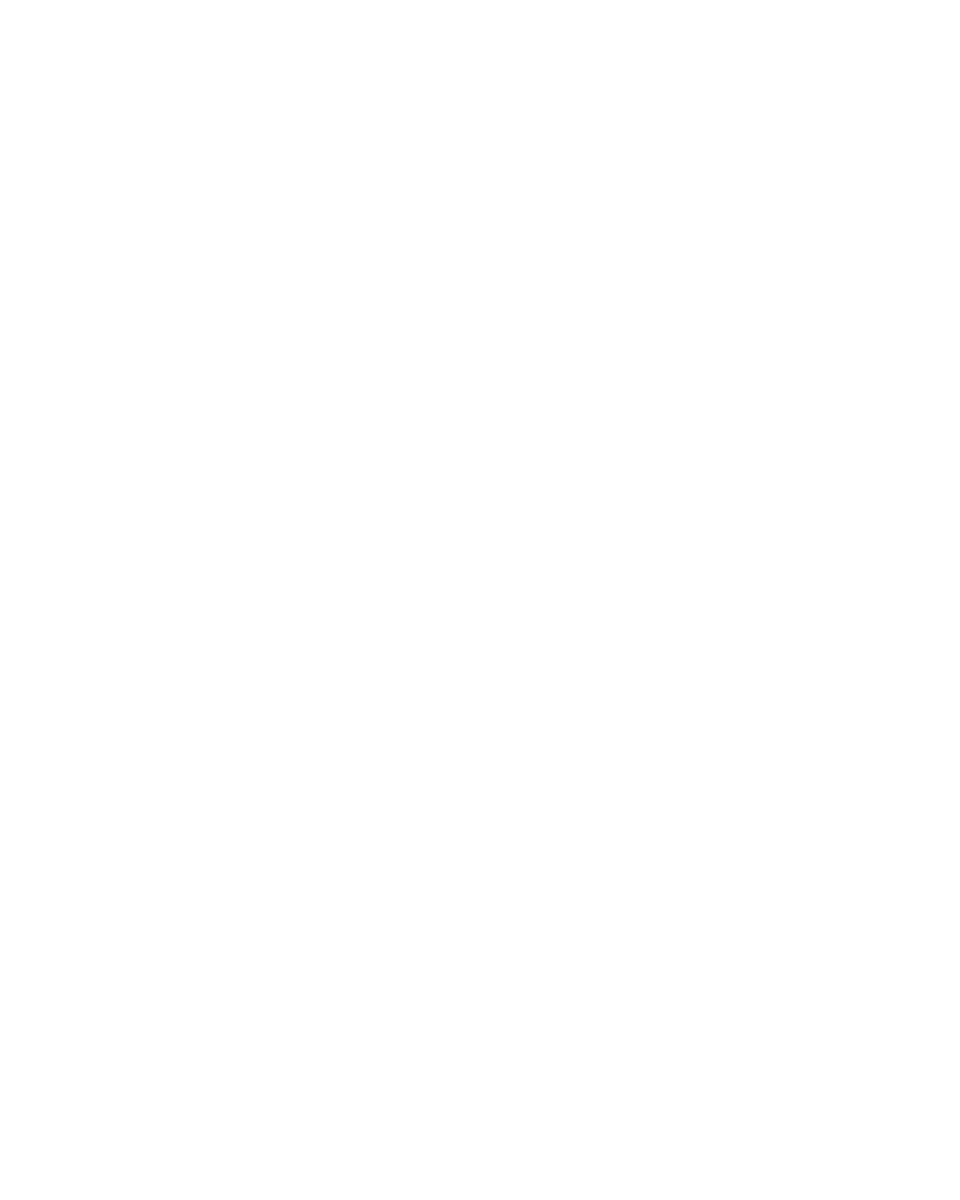
Esploriamo Il laboratorio del Futuro di Lesley Lokko attraverso le stesse parole della curatrice della 18. Biennale Architettura. Abbiamo pensato a delle domande sotto forma di parole chiave. Le 5 parole chiave che abbiamo scelto sono: ALTRIMENTI, FUTURO, NARRATOLOGIA e i due binomi TEORIA/PRATICA e TEMPO/IMMAGINARIO.
Quando ho iniziato a pensare alla possibilità di porre al centro della scena l’Africa, pensavo ad un’Africa allargata, perché in effetti quando si parla di Africa si pensa inevitabilmente anche alla diaspora
Ci sembra che il concetto di “altrimenti” (“otherwise”) sia un tema ricorrente per la Biennale. Ma mentre in italiano il termine “altrimenti” sembra riferirsi a una alternativa, a un “pianeta B”, la maggior parte dei partecipanti sembra attribuire a “otherwise” un significato diverso. Conseguenza di un processo di riformulazione della Storia, “otherwise” sembra essere inteso più come un “altrove”, come se nel ripensare il passato ci trovassimo in un presente che è già qui, ma è appunto altro, senza esserne un’alternativa. Alcuni partecipanti in particolare, come ad esempio atelier masomı, Theaster Gates Studio e Cave_ bureau, stanno sviluppando a fondo questo aspetto.
Abbiamo chiesto a L.L. qual è la sua idea di “altrimenti”.
Non so se intendo il termine “altrimenti” proprio nel modo in cui lo descrive lei. Per me non implica solo un’alternativa ma anche qualcosa di diverso: “avrei fatto questa cosa diversamente” per me può significare “avrei fatto qualcosa di diverso”. Il che implica una certa contingenza. La questione è che molti dei partecipanti non si pensano “altrimenti” rispetto alle pratiche contemporanee dell’architettura, bensì come a figure centrali del dibattito. In un certo senso è vero che molti di loro rientrano nella categoria dell’“altrimenti”, anche se non necessariamente nella modalità del “diverso”. Come ho già detto molte altre volte, però, appartenere all’Africa rende molto complesso definirsi nella dimensione di un “altrimenti”, in quanto si è semplicemente se stessi. È come se i partecipanti a questa mostra, per potersi esibire, stessero cercando di mantenersi in equilibrio su una fune tesa tra il sentirsi sufficientemente sicuri e il sentirsi sufficientemente a proprio agio, tra l’essere sufficientemente consapevoli di essere osservati attraverso altri occhi e l’essere sufficientemente coraggiosi da non permettere a questo sguardo di alterare quello che si vuole esprimere. È un modo molto complesso per dire, più semplicemente, che si è nello stesso tempo “altro” e “non altro”. Non so se questa riflessione complichi o semplifichi la domanda.
Credo sia stato Frantz Fanon ad affermare che una delle prime cose che capì quando si interrogò sul significato di essere nero fosse proprio il fatto di essere oggetto dello sguardo altrui [cfr. Pelle nera, maschere bianche, Frantz Fanon, cap. 5, n.d.r.].
La consapevolezza di essere osservati e di essere nello stesso tempo se stessi è un processo estremamente complesso. Penso che molti dei partecipanti a questa Biennale procedano su questa fune tesa con estrema attenzione.
La sua risposta mi ha fatto tornare alla mente un lavoro di Fred Moten e Stefano Harney, Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero. Mi sembra che la loro accezione di “undercommons” racchiuda già in parte gli aspetti che lei ha appena evidenziato. Si prova a suggerire qualcosa, si tenta di vivere in maniera diversa, ma in fondo la differenza è già qui, in un presente sotterraneo e condiviso, e non tanto in un altro mondo utopico.
Quando si prova a proporre delle voci nuove, che non sono mai state al centro dell’attenzione prima d’ora, la gente si aspetta di trovare qualcosa di radicalmente diverso. In fondo questa è solo una mostra e questi sono solo practitioner che esprimono idee, concetti, e io ho fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi altro curatore di una mostra. Penso che le persone che verranno a visitare Il laboratorio del Futuro con l’aspettativa di trovare qualcosa di completamente estraneo rimarranno deluse, perché noi non veniamo da un altro pianeta. La differenza sta piuttosto nella disposizione, forse anche nell’impiego delle risorse, nell’atteggiamento verso il modo di costruire, verso l’architettura in senso lato, verso il potere. Credo, insomma, che saranno le sfumature dell’approccio che potranno evidenziare delle differenze nel fare e pensare architettura rispetto a come tradizionalmente si è fatto e pensato sino ad oggi.

Si potrebbe quasi parlare di un “minore” che, per dirlo in termini kafkiani, prende una lingua maggiore per farne un altrimenti. Un “minore consistente” che in qualche modo corrisponde anche a quello di cui ci avvaliamo per capire meglio il futuro. L.L. ha affermato che il suo Laboratorio del Futuro è qualcosa di molto pratico, ma in cosa consiste esattamente il futuro?
Molti dei partecipanti suggeriscono un futuro inesistente o, al massimo, un futuro fatto di un insieme di memorie ancestrali e di scenari basati sulla pratica. Ciò che Lokko suggerisce è un’idea molto concreta e pragmatica, l’idea di un futuro inteso come un vero e proprio laboratorio collettivo, una sorta di atelier aperto. Forse qualcuno potrebbe definire questa Biennale una sorta di riflessione sull’Afrofuturismo, anche se guardando al modo di lavorare, per esempio, di Hood Design Studio, di MASS Design Group o di Craig McClenaghan possiamo affermare che ciò è solo in parte vero e che una definizione di questo tipo risulta alquanto riduttiva.
La necessità di attribuire un nome a un concetto è profondamente radicata in tutti noi. Per afferrare il significato di qualsiasi cosa è necessario poterlo innanzitutto ben articolare. Etichette quali laboratorio, Afrofuturismo, futuro, Africa possono in una certa misura essere utili nella comunicazione in quanto scorciatoie per restituire ad operatori e pubblico un’idea assai più articolata e complessa del fare e pensare, nel nostro caso, architettura. Personalmente sono però più interessata a lavorare sulla comprensione a lungo termine, in quanto è proprio in questo esercizio condotto con scavo e convinzione adeguati che si trova un possibile punto d’incontro tra diversi mondi, tra diversi modi di pensare e vivere in società e quindi di fare, conseguentemente, architettura. Tutti noi ci tormentiamo nel disperato tentativo di capire da dove veniamo, dove stiamo andando, che cosa facciamo e perché lo stiamo facendo. È un enigma universale. Invitando al tavolo di discussione voci, persone e luoghi che normalmente ne erano esclusi spero si possa capire meglio in che cosa effettivamente consista questo tavolo.
La Biennale ha una durata di sei mesi, un tempo relativamente lungo che permette di sviluppare a fondo un discorso su un argomento che si colloca tra la vulgata dell’Afrofuturismo, che evoca in qualche modo la magia, e la realtà delle concrete condizioni di vita, sia qui che altrove, in luoghi “altri”. Questa tensione tra l’“altro” e il “sé”, che rimanda peraltro alla prima domanda che mi ha posto, è presente in ogni cosa. Non considero Il laboratorio del Futuro una risposta a qualcosa, ma piuttosto un tentativo di porre un’intelligente serie di domande. Forse da un progetto come questo ci si aspetta una risposta, ma per me questa mostra si pone a monte della risposta, perché, prima di tutto, cerca di capire come formulare delle domande.
Una mostra di architettura è il connubio perfetto di questi due processi ideativi: da un lato il desiderio dello scrittore di esplorare e dall’altro il desiderio dell’architetto di creare
Ciò che colpisce di più della linea curatoriale di questa Biennale è quanto l’architettura si intrecci strettamente con il concetto di “narrazione”. Ciò si ricollega anche alla specifica attività della curatrice, che è decisamente poliedrica, occupandosi non solo di spazi ed immagini ma anche di scrittura. E lo stesso vale per molti dei partecipanti. Basti pensare, ad esempio, allo straordinario lavoro sulla “città giusta” (“the just city”) di Toni L. Griffin e il suo Urban American City Studio (urbanAC), o a Project Detroit o, ancora, alle immagini fantastiche di Olalekan Jeyifous. Qual è allora il ruolo della narrazione in un settore decisamente fondato sulla pratica costruttiva, quale è quello dell’architettura e dell’urbanistica? In altre parole, qual è la “pratica del narrare”?
Quando ho iniziato a scrivere romanzi, circa trent’anni fa, ero mossa dal senso di rabbia che provavo nei confronti dell’architettura. Avevo la sensazione che non mi lasciasse abbastanza spazio per esplorare, che mi chiedesse semplicemente di spiegare me stessa. Ciò che invece ho cercato di dimostrare fin da studentessa era l’estrema difficoltà di riuscire ad esplorare qualcosa cercando nello stesso tempo di spiegarla. Ho deciso dunque di abbandonare temporaneamente l’architettura per dedicarmi alla scrittura perché ho ritenuto che quest’ultima fosse capace di rispondere meglio agli stimoli e alle domande che avvertivo più urgenti. L’esplorazione fa parte della narrazione, è un dato assodato. Il modo in cui l’architettura mi veniva insegnata, raccontata sostanzialmente come una storia solida, escludeva invece l’idea di esplorare; si trattava ‘solo’ di memorizzare e di creare qualcosa di materiale e di concreto. All’inizio della mia attività di scrittrice sono rimasta sorpresa nel riscontrare una grande similitudine tra la scrittura di un romanzo e la realizzazione di un’architettura: per me erano due attività che seguivano uno stesso processo ideativo. L’esperienza maturata durante i dieci o quindici anni passati a scrivere romanzi mi ha dato la fiducia necessaria a considerare l’architettura stessa come una forma di narrazione, anche se ovviamente si avvale di strumenti diversi, quali lo spazio, il disegno, i materiali, e così via. In un certo senso una mostra di architettura è il connubio perfetto tra questi due processi ideativi: da un lato il desiderio dello scrittore di esplorare e dall’altro il desiderio dell’architetto di creare. Penso siano due facce di una stessa medaglia. In questa mia prima esperienza di curatrice posso affermare che mettere insieme questi due mondi è stato l’aspetto più intrigante e coinvolgente del lavoro sin qui svolto.
È come trovarsi di fronte a una riconciliazione formale tra teoria e pratica…
Sì, è proprio così. Penso anche di non aver mai capito appieno la differenza tra pratica e mondo accademico o tra quest’ultimo e lo scrivere romanzi. I confini tra questi mondi non mi sono ancora del tutto chiari. Sono anche pienamente consapevole che il mio approccio verso l’architettura è solo uno fra i tanti possibili. Vi sono svariati modi di affrontare questa materia, ma ciò che mi affascina di più dell’architettura è proprio la sua poliedricità. Ho scelto questa disciplina sperando che essa mi potesse fornire l’opportunità di studiare dei temi specifici in modo molto approfondito; è stata questa aspettativa ad attrarmi inizialmente. In realtà quando poi mi sono allontanata dall’architettura per avvicinarmi ad altre discipline mi sono resa conto di aver appreso molte pratiche e formulazioni teoriche rilevanti, ma al contempo ho capito che le avevo attraversate assai superficialmente.
In Italia diciamo spesso che gli ingegneri sanno tutto di una cosa sola mentre gli architetti sanno solo qualcosa, ma di un po’ di tutto…
Non era questa l’idea che mi ero originariamente fatta della figura dell’architetto. Pensavo che sarei diventata un po’ come un ingegnere o un dottore, che avrei maturato delle conoscenze disciplinari molto approfondite. Ma non è andata affatto così.

Parliamo del binomio teoria/pratica, polarità che forse non è propriamente corretto considerare in una chiave meramente oppositiva; si tratta piuttosto di un modo olistico di considerare l’architettura nella sua disseminazione di pratica e di teoria, o di pratica e di ricerca. Analizzando i lavori dei singoli partecipanti emerge un quadro che restituisce una prospettiva ancora più ampia. In passato in Europa è maturata una profonda riflessione sulla capacità di trasformare lo spazio condotta da Jeremy Till, Tatjana Schneider e Nishat Awan in Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture, 2011, un lavoro davvero eccezionale, un’analisi a dir poco strabiliante sulla nostra capacità di intervenire sullo spazio e sulla realtà. Ma prendendo in esame alcuni partecipanti della mostra, come ad esempio Ibrahim Mahama o Kibwe Tavares (Basis), sembra emergere qualcosa di diverso e di ulteriore. Probabilmente lo stretto legame con KNUST ad Accra e Kumasi ha influenzato enormemente il loro modo di lavorare: una pratica che combina architettura e arte che è decisamente qualcosa di molto diverso da quello cui eravamo sinora abituati. L.L. ci parla del contributo che secondo lei la diaspora africana ha dato a questo nuovo approccio verso la polarità teoria/pratica.
Quando iniziai a pensare a quali potessero essere i potenziali partecipanti a questa Biennale stavo leggendo The Black Atlantic [The Black Atlantic: L’identità nera tra modernità e doppia coscienza di Paul Gilroy, n.d.r.], un saggio che parla di una sorta di identità del futuro, uno spazio-nazione o identità nazionale che va al di là del tradizionale concetto di stato-nazione. Ho trovato questa idea molto interessante, ancor di più connettendola ad altri scritti di Paul Gilroy sulla musica nera. In sintesi, in questo saggio le persone sono accomunate non dal luogo geografico di appartenenza o di nascita, bensì da una serie di esperienze condivise. Quando ho iniziato a pensare alla possibilità di porre al centro della scena l’Africa, pensavo ad un’Africa allargata, perché in effetti quando si parla di Africa si pensa inevitabilmente anche alla diaspora. Quando si opera nel mondo dell’architettura e dell’arte è molto raro che si viva e lavori in un medesimo luogo, anche se in passato è invece sembrato che la condizione pressoché esclusiva del nostro stare al mondo fosse quella di esistere in un luogo specifico. Oggi più che mai, invece, siamo messi in relazione ad altri luoghi grazie alla tecnologia informatica, a internet, o anche semplicemente come conseguenza di trasformazioni di tipo culturale o ideologico. Per me era quindi molto importante riuscire a catturare questo specifico, nodale aspetto della contemporaneità nel Laboratorio del Futuro. La natura stessa del modo di lavorare dei practitioner invitati spiega in parte la presenza simultanea di molti di loro sia nella mostra all’Arsenale che in quella al Padiglione Centrale ai Giardini. Lo stesso vale in certa misura anche per i padiglioni nazionali. Quando ho incontrato i vari curatori – gran parte dei quali hanno accolto positivamente l’idea di Laboratorio del Futuro – uno degli aspetti interessanti emersi dalle nostre conversazioni è stato proprio il fatto che tutti stavamo creando nuovi territori di comunanza. Se a Grenada, per fare solo un esempio, si sta lavorando su un progetto che ha a che fare con l’acqua e ad Abu Dhabi si sta lavorando sulle risorse idriche in riferimento a qualcosa che sta succedendo in Finlandia, allora si viene a definire un concetto di territorio che non ha più nulla a che vedere con una sua specifica ubicazione geografica, riferendosi estesamente ad orizzonti concettuali di più ampio spettro nel segno di alcune globali criticità condivise, vedi nello specifico, in questo caso, il cambiamento climatico. Ed è così che ho iniziato a pensare alle grandi questioni legate alla decolonizzazione e alla decarbonizzazione, chiedendomi se potessero essere proprio queste ad anticipare, predeterminandole, nuove forme identitarie del vivere il nostro Pianeta. Recentemente stavo leggendo di quanto il concetto di genere sia vissuto in forme decisamente fluide tra i giovani della cosiddetta Generazione Z. È un modo di vivere la propria identità nuovo e decisamente diverso rispetto ai canoni seguiti nei secoli alle nostre spalle. Ora ci stiamo muovendo teoricamente verso un’idea molto più ibrida e fluida, per l’appunto, ma è come se il nostro comportamento, il nostro linguaggio, la nostra stessa architettura non si fossero ancora compiutamente adeguati a questa disposizione mentale. Ecco, diciamo allora che per certi aspetti il gruppo di practitioner invitati alla nostra esposizione esplora in particolare proprio questo nuovo concetto d’identità.

La nostra prossima domanda, che voleva aprire una discussione sull’immaginario e sui modi per superare l’onnipresente immaginario occidentale, andrebbe ora riformulata in ragione delle possibilità che L.L. ci ha prospettato di trovarci già di fronte a un immaginario decoloniale e postcoloniale, sostenendo che «la storia dell’architettura non è sbagliata, è semplicemente incompleta perché al suo tavolo mancano vaste fasce di umanità». I nuovi territori di comunanza che L.L. mette in evidenza fanno emergere il fatto che non si tratti tanto di cercare un altro immaginario, un immaginario decoloniale che ci permetta di superare i problemi del passato, quanto di riconoscere che questo immaginario altro è invece già qui, in quanto la presenza di practitioner neri è di per sé un immaginario esistente, contemporaneo. Significativo in tal senso è trovare ad esempio fra i partecipanti Courage Dzidula Kpodo, il quale, con la sua opera Postbox Ghana, osserva e descrive in modo personale e pregnante le varie forme in cui le persone si relazionano con l’architettura moderna. Se inizialmente la domanda era: “qual è l’immaginario che lei propone?”, preferiamo ora invece chiederle: “qual è il tempo dell’immaginario in cui sta cercando di addentrarsi?”
L’età media in Africa è al di sotto dei vent’anni, vale a dire la metà dell’età media in Europa e negli Stati Uniti. Ciò significa che la stragrande maggioranza delle persone nel nostro continente ha ancora tanti anni di vita davanti a sé. In un contesto di questo tipo se si dà a una popolazione così giovane la possibilità di agire – e per agire non intendo “autorizzare le persone a fare qualcosa”, come gli americani spesso intendono – è evidente che ciò può rappresentare un potenziale enorme, perché si tratta di un vasto insieme dinamico di persone che ha tutto il tempo di esplorare, di fare errori, di riprovare e di rielaborare proprie idee e progettualità. Ricordo di essermi trovata una decina di anni fa ad una conferenza dove un architetto austriaco aveva parlato di un suo progetto attorno al quale aveva riunito studenti e senzatetto proprio perché i primi avevano ancora tutta la vita davanti a sé, mentre i secondi consideravano la loro vita ormai finita. Mettendo insieme queste due categorie il suo obiettivo era quello di analizzare la tensione che viene a crearsi tra l’avere a disposizione molto tempo e l’averne poco o, meglio, tra l’averne molto e il non averne più.
Nello stesso modo per me portare così tante voci giovani alla Biennale è un modo per dire: «abbiamo tempo, il tempo è dalla nostra parte». Quello che affermiamo a 24 o 27 anni è spesso molto diverso da quello che affermiamo poi a 57 anni. Quando si è giovani si ha l’opportunità di dire qualcosa e di poterla rivedere in continuazione. Può sembrare strano che io dica questo considerando la mia età, 59 anni. Ho davanti a me forse solo una decina d’anni per portare avanti un progetto di questo tipo. Ma ho anche la sensazione di dire oggi la stessa cosa che dicevo trent’anni fa, solo che all’epoca il mondo dell’architettura non era ancora pronto a questo ascolto. È come se stessi dicendo la stessa cosa già da molto tempo, insomma; l’unica differenza è che in questo momento ho di fronte un pubblico pronto ad ascoltarmi.
I miei studenti vorrebbero chiederle come diventare practitioner del futuro…
L’unico consiglio che mi sento di dare agli studenti che mi chiedono come diventare dei practitioner è di cercare di esprimere la loro voce più autentica. Qualsiasi essa sia. Ho passato molto del mio tempo a studiare architettura cercando di essere quello che pensavo un architetto dovesse essere. Ma è solo quando ho realizzato che quella voce doveva essere la mia voce che mi sono sentita davvero libera.
Immagine in evidenza: Lesley Lokko, ph: Jacopo Salvi, courtesy La Biennale di Venezia