
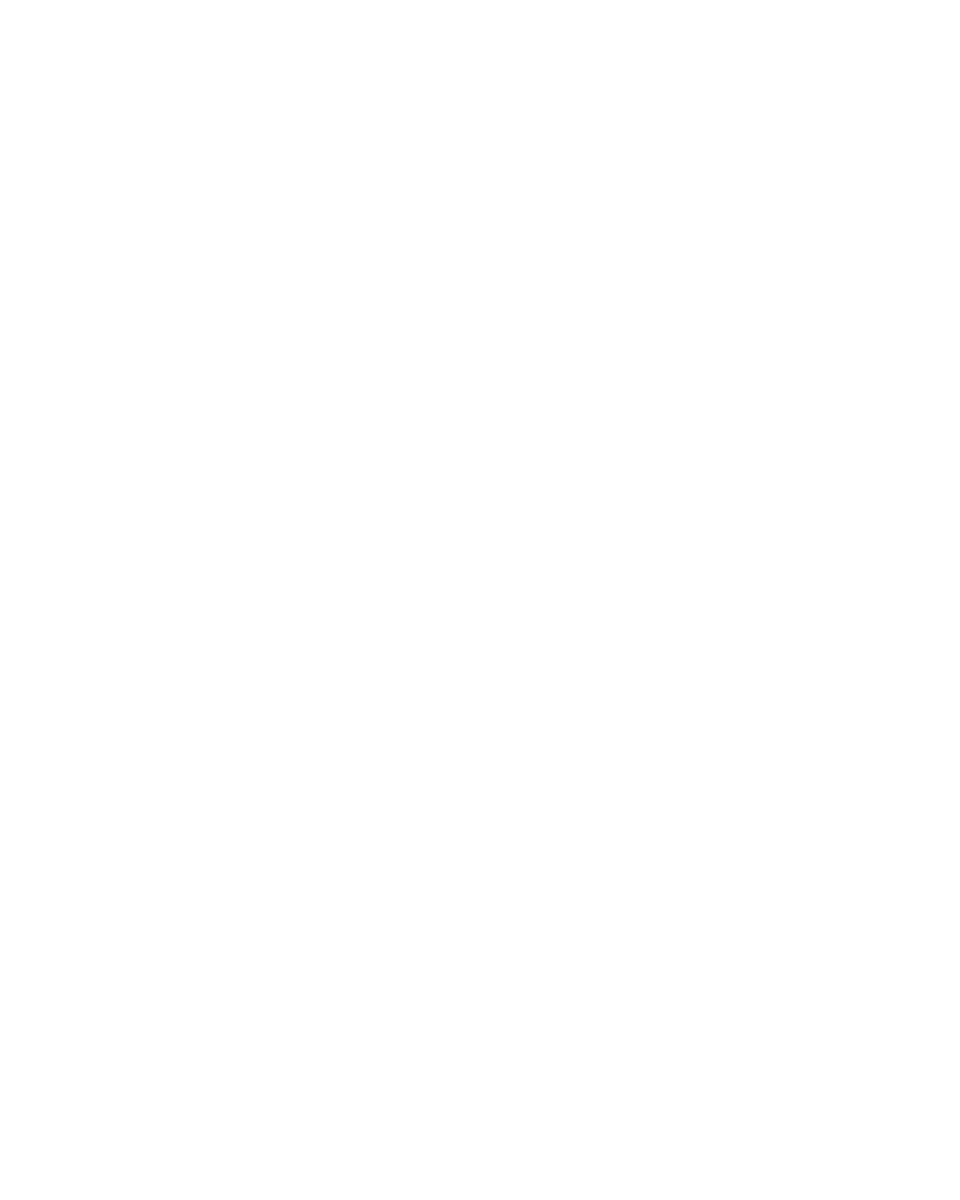
Per la prima volta il Padiglione Italia è presentato da un solo artista: Gian Maria Tosatti, selezionato dal curatore Eugenio Viola.
Storia della Notte e Destino delle Comete: quale la genesi del progetto e da dove avete preso ispirazione per questo ‘illuminante’ titolo?
EV_Il titolo è arrivato dalla genesi stessa del processo che ha dato vita al progetto, fin da quando ho deciso di coinvolgere Gian Maria nella selezione dei lavori. L’impianto così evocativo del titolo è merito principalmente suo, legato indissolubilmente alle tematiche che volevamo affrontare, in primis il rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante, un ambiente che in questo momento si potrebbe definire “metapandemico” e “farmapornocratico”.
GMT_Il titolo è una possibilità di racconto dell’opera stessa, una grande installazione ambientale che si snoda all’interno del Padiglione attraverso un vero e proprio percorso che tratta essenzialmente due momenti: da una parte il presente, nella declinazione di come affrontiamo il passato; dall’altra come cerchiamo di muoverci verso il futuro.
Anche quando qui parliamo di storia, non si sta parlando in realtà di passato: credo che l’opera non abbia nulla a che fare con il passato, esattamente come le rughe su di un volto non rappresentano il passato di una persona, ma il suo presente, il risultato delle esperienze che hanno creato la persona che oggi ci troviamo di fronte.
Un’espressione inglese molto interessante parla di “history faced man”, che potremmo tradurre come “l’uomo dalla faccia istoriata”. Cosa significa questo? Significa proprio che tutte le esperienze vissute fino a quel momento, materializzate nelle rughe, lo hanno portato ad avere l’aspetto che vediamo oggi. Il suo volto diventa manifesto della sua vita, un manifesto che è pieno del suo passato, dipendente dal suo passato, ma che è espressione autentica, tangibile del presente.
Esiste quindi una parte del Padiglione che si riferisce al tempo che stiamo vivendo, un presente che al momento in cui abbiamo iniziato a lavorare non pensavamo potesse corrispondere a una notte così buia, a un buio così pesto: credevamo, infatti, di stare affrontando in quel momento il punto più basso della nostra storia recente, senza immaginare che la tragica dimensione bellica potesse tornare di così stretta attualità. Naturalmente non ci eravamo illusi che la guerra non esistesse più, ma credevamo che fosse un’eventualità relegata a luoghi della Terra in cui problemi enormi hanno reso le armi quale unico strumento conosciuto per una lotta di sopravvivenza, in aree geografiche in cui mancano i mezzi di sussistenza minimi. Ovviamente non che questo giustifichi i conflitti bellici che si stanno svolgendo da molti anni in quelle aree; ritengo e riterrò sempre la guerra lo strumento più insensato che possa esistere per risolvere problemi e divergenze in qualsiasi luogo della terra. Di sicuro però non mi aspettavo una guerra del genere nell’Occidente che ha costruito la democrazia ormai diverse centinaia di anni fa, anche se quello che è successo ci fa vedere come parlare di “notte” fosse tristemente appropriato.
Quando ci è stato chiesto di realizzare questo Padiglione, confrontandomi con Eugenio abbiamo convenuto che fosse importante, urgente dover parlare del presente. Quindi di “notte”, per l’appunto. Dovendoci concentrare sul tempo che ci è dato vivere oggi, è venuto naturale a me ed Eugenio parlare dell’insostenibilità del nostro stile di vita, dal punto di vista energetico, ambientale, certo, ma ancora prima dal punto di vista dei nostri sogni, sempre più non sostenibili in chiave futura, non realizzabili. Il Padiglione che avevamo in mente era quindi di chiara prospettiva politica, in grado di affrontare tutti quei temi che oggi ci chiedono di cambiare strada e passo rispetto al cammino che abbiamo intrapreso fin qui.
Temi che abbiamo affrontato secondo una logica di interazione, anche perché ci è stato chiaro sin da subito che dovevamo cercare di formulare, di elaborare una sintesi alla luce delle dimensioni certo imponenti eppure non sconfinate dello spazio espositivo, circa 2000 metri quadri.
Guardando il Padiglione il mio pensiero va al lavoro che avevo fatto a Odessa nel 2020, dal titolo Il mio cuore è vuoto come uno specchio – Episodio di Odessa; i due progetti sono accomunati da questo aleggiare della morte, da questa “mancata presenza” di persone che restituiscono l’idea di un’umanità arrivata al capolinea. Come potrete vedere, il Padiglione sarà pieno di macchine ferme e potrebbe assolutamente essere associato a uno scenario di guerra, una guerra che ora come ora non sappiamo assolutamente a cosa potrà portarci.
Resto convinto che l’opera resti sempre più grande del proprio autore: chi realizza l’opera è convinto di fare una determinata cosa, ma poi l’opera assorbe da sé e per sé la coscienza dello Zeitgeist, un pensiero collettivo di cui l’autore cerca solo di farsi strumento.
Osservando il vuoto stridente di quanto fatto a Odessa mi trovo a pensare a quello che mi stanno scrivendo in questi giorni gli amici ucraini, descrivendo le fabbriche vuote. Leggevo una dichiarazione di Zelensky, il presidente ucraino, in cui invitava lavoratori e imprenditori a rimanere in Ucraina e andare a lavorare, per strappare giorni di normalità a un Paese che, fermandosi anche dal punto di vista industriale, capitolerebbe in tutto e per tutto.
Sembra quasi che la sensibilità che ha dato vita al Padiglione abbia in realtà previsto la guerra ancora prima che scoppiasse, immaginandone gli scenari e le tematiche principali.
Per questo motivo non mi considero autore vero e proprio delle mie opere, quanto piuttosto portavoce della sensibilità che le ispira.

Alla luce dei fatti attuali, il finale positivo della macchina narrativa del Padiglione secondo voi necessiterebbe di essere cambiato?
GMT_Il finale non lo cambierei; mantenerlo tale significa che nell’assurdità di questa situazione ci rendiamo conto di ascoltare soprattutto voci che questa guerra la ripudiano con forza. Ponendoci in una prospettiva più umana che meramente nazionale, intendiamo raccontare un’umanità che può farcela. Abbiamo la possibilità di tornare sui nostri passi, di correggere i nostri errori. E quindi non vogliamo cambiare il finale, no: è la cosa probabilmente più vera di tutto il nostro racconto. Esistono pagine della nostra storia di cui di sicuro non andiamo fieri, ma si tratta di pagine che nonostante tutto passano, che confermano come l’uomo possa sempre decidere del proprio destino, in qualunque momento. In passato siamo stati capaci di cose meravigliose e lo saremo anche nel futuro.
Il messaggio portato avanti dal Padiglione è precisamente questo: non darsi mai per vinti, non scoraggiarsi mai, non essere mai disillusi, anzi. Il problema principale della nostra generazione è proprio la disillusione, che spesso si accompagna al concetto di viltà. Ognuno di noi deve tirare fuori il coraggio di poter incidere, deve credere fermamente di poterlo fare. Il Padiglione parla di questo, mettendoci di fronte a una sconfitta, su questo non c’è dubbio, ma anche alla possibilità di riscattare questa stessa sconfitta riscrivendo un destino che non può essere prestabilito. La possibilità di cambiare rotta ci viene data continuamente, ogni giorno, più volte al giorno.
Una frase pronunciata dal portavoce di Putin in questi giorni mi ha molto colpito: «Nel nostro Paese c’è chi sostiene il Presidente; e poi c’è chi si occupa di cultura». Credo che questa frase dica molto dei tempi che stiamo vivendo. Ci dice, per esempio, che un Paese con un livello di cultura alto è un Paese che strappa i soldati dal campo di battaglia, uno per uno. È un Paese in cui la guerra non è possibile, un Paese in cui le pagine nere della storia non trovano spazio.
Non viviamo in un mondo messianico, non arriverà lo Spirito Pentecostale sulle nostre teste a salvarci da questa situazione: diventare un Paese migliore richiederà lo sforzo concreto di tutti. Nel nostro quotidiano noi operatori culturali per primi dobbiamo essere in grado di offrire alle persone strade diverse rispetto a quelle primitive dello scontro, fisico e ideologico.
Ognuno di noi deve tirare fuori il coraggio di poter incidere, deve credere fermamente di poterlo fare. Il Padiglione parla di questo, mettendoci di fronte a una sconfitta, su questo non c’è dubbio, ma anche alla possibilità di riscattare questa stessa sconfitta riscrivendo un destino che non può essere prestabilito. La possibilità di cambiare rotta ci viene data continuamente, ogni giorno, più volte al giorno (Gian Maria Viola)
Quali le fonti vive e i riferimenti imprescindibili del linguaggio ‘intermediale’ – arte, letteratura, teatro, musica, performance – utilizzato per la costruzione dell’opera?
EV_L’esperienza a cui abbiamo pensato ideando il Padiglione è fondamentalmente immersiva. Il lavoro di Gian Maria si è sempre distinto per una forte semantizzazione degli spazi, oltre che dei dispositivi di cui si serve per concretizzare lo spirito dell’opera.
Gli spazi del Padiglione andranno in questo modo a rievocare quelli descritti ne La Dismissione di Ermanno Rea (Feltrinelli, 2002), che considero l’ultimo romanzo industriale della letteratura italiana, incentrato sulla dismissione dell’Ilva di Bagnoli, una dismissione da intendersi più estesamente come la demolizione di tutto un sistema di pensiero. Da un accadimento specifico è possibile quindi parlare più ampiamente di un problema che coinvolge la società tutta e le idee che la sorreggono, o l’hanno sorretta, sino a un momento dato. Una disposizione mentale, una visione direi che connota sia questo importante romanzo che la progettualità del Padiglione, a testimonianza del grande potere metaforico peculiare del fare arte.
Tra i diversi riferimenti che troviamo nel Padiglione una parte fondamentale la riveste certamente l’opera di Pier Paolo Pasolini, come già peraltro avvenuto in lavori passati di Gian Maria, soprattutto se parliamo del Pasolini distopico e oracolare. In questo caso l’incipit è stato l’articolo intitolato Il vuoto del potere pubblicato sul «Corriere della Sera» del 1° febbraio 1975, poi diventato celebre come “L’articolo delle lucciole”. Una relazione intellettuale che si concretizza qui in una “Ut pictura poësis” dalla forte connotazione letteraria, caratteristica della ricerca artistica di Gian Maria e della mia indagine curatoriale.
Quali le radici profonde del vostro sodalizio e come riuscite ad essere complementari nel processo di creazione? Come Gian Maria definirebbe il ruolo della curatela di Eugenio nel proprio lavoro e come invece Eugenio spiega la scelta dell’artista Tosatti quale voce unica di un suo pensiero curatoriale?
EV_Si è trattata di una scelta dettata direttamente dalla consuetudine lavorativa, che ci vede insieme ormai da diversi anni a diversi livelli. Ci siamo conosciuti nel 2011 a Roma, quando ho visitato una sua installazione ambientale site-specific intitolata Devozioni alla Torre idrica dell’Ospedale San Camillo. Il suo lavoro mi colpì da subito fortemente. Sono convinto che nella sua opera vi siano potenti tratti psicanalitici significativi, visto che spesso i suoi dispositivi sono concepiti per un visitatore alla volta. Un viaggio fisico e metaforico che per ovvi motivi non sarà possibile replicare nel nostro Padiglione.
Ricordo che quando incontrai Gian Maria ai Professional Days a Venezia gli dissi: «Se vuoi fare qualcosa a Napoli, lo faremo insieme». Ragazzo perseverante, mi venne poi a trovare a Napoli e mettemmo su questo progetto assolutamente visionario, confrontandoci senza mai scontrarci; abbiamo entrambi caratteri forti ma ci conosciamo molto bene e la consuetudine di sicuro ci aiuta molto. Ovviamente non si riduce tutto a una questione di frequentazione: alla base della scelta c’è la capacità di Gian Maria di trasformare spazi anche tre volte più grandi del Padiglione, come nel caso della mostra Sette Stagioni dello Spirito nel 2016 a Napoli. La sfida più grande di questo progetto che ci vede ora impegnati era trasportare una forza e una coerenza plastico-dinamica negli spazi del Padiglione Italia: una sfida che solo Gian Maria poteva raccogliere e fronteggiare. Tutta ‘colpa’ della sua formazione eccentrica, del suo continuo confronto con gli spazi dell’abitare. Considero Gian Maria una sorta di ‘mistico contemporaneo’: la sua formazione teatrale lo ha portato a caricare gli spazi di una matrice emozionale che non credo abbia eguali nel panorama artistico contemporaneo, offrendo al visitatore una lunga serie di stimoli da recepire e rielaborare.
GMT_Eugenio e io siamo persone dalla temperatura molto diversa, ma mi sono accorto negli anni di quanti elementi di congiunzione ci fossero tra di noi, e molto forti, riferiti agli aspetti più fondanti del nostro percorso biografico e lavorativo. Eugenio è una persona molto calma, io è come se mi trovassi perennemente su una zattera che attraversa un fiume di lava; nonostante queste evidenti difformità, condividiamo tensioni molto forti, di carattere etico, politico, naturalmente culturale. Guardiamo a figure come Pasolini e Ortese non considerandoli ‘solo’ eccellenti narratori della letteratura italiana, ma ritenendoli testimoni di una vocazione morale molto forte, che sentiamo di condividere in pieno. Queste affinità si concretizzano quindi anche nel nostro percorso, che hanno portato me a frequentare parti del mondo da cui sarebbe meglio stare lontani ed Eugenio a operare in prima linea in un ambiente complicatissimo come il contesto colombiano, nel ruolo di Capo Curatore del MAMBO – Museo de Arte Moderno de Bogotá.
È come se fossimo due monaci, molto diversi da un punto di vista caratteriale, ma entrambi devoti alla medesima religione. Abbiamo scelto di aderire a una dottrina caratterizzata da regole talmente forti da mettere in secondo piano tutto il resto. Questa ‘religione’ a cui abbiamo deciso di aderire crede fermamente che la cultura possa costituire uno strumento di azione concreta, sulla società e sul presente. Una grande forza costruttiva che non considera importanti persone come me, Eugenio, Pasolini o Ortese, quanto piuttosto le idee e le tensioni che queste stesse persone esprimono, in un percorso di intervento e dialogo col presente che ci rende fratelli.
L’incontro con Eugenio è stato importantissimo per me. Ci unisce un rapporto forte e complesso che negli ultimi anni mi ha portato quasi a smettere di lavorare con altri curatori. Non ho problemi ad ammetterlo: non è facile lavorare con me. Tratto materie incandescenti, propongo dei percorsi in cui “non c’è spazio per il turismo”. So che potrebbe suonare inappropriata un’espressione del genere, ma non ne trovo altre: porto il visitatore in “zone di guerra dell’umano”. Chi attraversa questi percorsi lo fa per aiutare, per combattere, per fare qualcosa di concreto, deve avere la vocazione di stare lì.
Ormai sono vent’anni che faccio questo mestiere e mi rendo sempre più conto di come la cosa più importante non siano le personalità, quanto l’afflato che si condivide tra soggetti anche diversi tra loro, ma uniti da una forte vocazione, sia essa politica, etica, culturale.
Per questo motivo il mio rapporto con i curatori si riduce quasi a zero, a meno che questo rapporto non si trasformi in una collaborazione con un compagno di viaggio con cui condividere una vocazione che superi i confini del rapporto professionale.

E poi c’è Napoli… «Non ti disunire!» suggerisce Antonio Capuano a Fabietto/Sorrentino in È stata la mano di Dio. Quale imprinting partenopeo rimane fondamentale nel DNA del vostro Padiglione?
EV_Si tratta certamente di un Padiglione a trazione meridionale, che da Napoli parte, proprio come il nostro sodalizio, che guarda all’area partenopea anche nel riferimento specifico a Rea di cui parlavamo prima. Come Rea parla del particolare per passare poi all’universale, allo stesso modo noi partiamo da Napoli per estenderci all’universale e per successivamente infine ritornarci a Napoli.
GMT_Sono convinto che per molto tempo in ambito artistico ci sia stato un atteggiamento, dettato da una profonda ignoranza, che imponeva di essere considerati interessanti e originali svincolando la personalità dell’artista da tutto il resto, compreso il luogo di provenienza. Al contrario io penso che l’artista sia una figura caratterizzata da delle radici forti, che poi devono confrontarsi, intrecciarsi con altre. Non esiste una storia dell’arte senza parlare delle città e dei contesti in cui un artista nasce e sviluppa la propria personalità.
Esistono artisti che possiamo considerare ‘singolarmente’, avulsi da tutto ciò che li circonda, ma si tratta senza dubbio di eccezioni, figure particolari magari caratterizzate da storie personali molto difficili. Ma le grandi storie dell’arte ci parlano senza ombra di dubbio di città, di luoghi, di relazioni.
Napoli ha rappresentato per me una tappa, un incontro fondamentale, in primis con un’eredità culturale fortissima. Una relazione intensa a un punto tale che ho infine deciso poi di andarci anche a vivere. Inutile girarci intorno: noi in Italia abbiamo una città dalla potenza culturale fortissima, vale a dire Milano, ma non possiamo fare a meno di riconoscere come Napoli abbia prodotto a livello nazionale e internazionale la cultura più significativa dell’ultima generazione, praticamente in ogni ambito espressivo.
A Napoli è poi legata anche la prima performance veramente potente di Marina Abramović, Rhythm 0, andata in scena nella galleria Studio Morra nel 1974. Marina ha costruito innumerevoli progetti nel suo lunghissimo percorso, alcuni dei quali divenuti in tutto e per tutto “storia dell’arte”, una storia che ha visto alcune pagine scritte proprio a Napoli grazie ad alcuni straordinari protagonisti del contemporaneo con cui io ed Eugenio stessi collaboriamo, come Giuseppe Morra della Fondazione Morra, che ci ha sostenuto anche nella creazione di questo Padiglione.
Personalmente ho sempre negato in maniera netta l’idea di una supposta, asettica originalità che connoterebbe il profilo, il lavoro di un artista a prescindere dal contesto in cui egli si trova a pensare, operare, creare; l’idea di un fantomatico artista che spunta dal nulla, sostenuto dalla forza titanica della propria arte la considero un’emerita cretinata, uno Sturm und Drang molto adolescenziale. Per me l’arte è una storia fatta di persone, di comunità, di città. Per quanto ci riguarda siamo figli della storia di Napoli e del ventunesimo secolo, che a sua volta si poggia sulla storia di Napoli nel ventesimo secolo e via via a ritroso, fino alle sue radici culturali e antropologiche più profonde. Cosa c’è di Napoli nel nostro Padiglione? C’è che, semplicemente, senza Napoli noi oggi non saremmo qui.

Rapporto uomo/natura/territorio/sviluppo/industria. Sembra di leggere il destino comune di due città, Napoli e Venezia, le cui sopravvivenze sono legate alle volontà del Vulcano e delle maree. La creatività e la vitalità partenopea hanno dimostrato nel tempo come l’incertezza permanente possa divenire elemento sostanziale nel gestire il presente, mentre per Venezia, luogo d’arte e collettore d’arte, sembra destino di essere un deposito di idee generate altrove. Come può una progettualità artistica e curatoriale inserire elementi di vita oltre il dato fisicamente fugace di un’esposizione? Come possono le incertezze divenire fondamenta del futuro?
GMT_Non è un caso che i veneziani vengano definiti “i napoletani del Nord”.
Credo che uno stato d’incertezza corrisponda ad uno stato di veglia per la coscienza. È quando siamo soddisfatti, appagati e al sicuro che ci dimentichiamo di tutto e non guardiamo più all’esterno, ci addormentiamo. Nell’incertezza ci accorgiamo dell’altro, perché ne abbiamo bisogno; quando siamo incerti ci accorgiamo del valore delle cose, perché ne avvertiamo la precarietà, l’intrinseca fragilità, la concreta possibilità di non disporne più.
Di recente, parlando del tema della tragedia con il regista teatrale Romeo Castellucci, evidenziavamo proprio come l’arte servisse a bombardare le certezze: è brutto da dire in un momento in cui la realtà sta abbondantemente scavalcando l’arte nell’espletare questo ruolo, ma è la conferma di come l’arte possa risvegliare dal sonno la coscienza delle persone, soprattutto nell’opulento Occidente, sempre più addormentato nelle proprie presunte certezze.
In questa occasione il nostro lavoro entra in contatto con l’incertezza del reale, spingendo le persone a mettere in dubbio tutte le certezze che ci hanno portato fino a qui, sicurezze che riguardano i nostri consumi, abitudini spesso dannose per la vita del pianeta, o che magari hanno a che fare con la convinzione che non sia così fondamentale dialogare con l’altro, che soverchiare il prossimo con parole e atteggiamenti autoreferenziali e ‘sordi’ sia un’eventualità possibile, ordinaria.
In quale rapporto il Padiglione Italia si pone rispetto al tema/titolo della Biennale di Cecilia Alemani e come intercetta o interpreta la sua visione di arte in trasformazione?
EV_Ci siamo incontrati per pura coincidenza, come spesso accade. Non eravamo in contatto e non sapevamo su quali tematiche la sua ricerca curatoriale si sarebbe concentrata. Eppure si è creato un dialogo molto stringente tra l’afflato che ha dato vita al nostro Padiglione, una visione nonostante tutto ottimistica e catartica, e il nucleo tematico de Il latte dei sogni, le galassie concettuali che Cecilia Alemani ha costruito attraverso il meccanismo di mutamento, trasformazione e creazione di mondi possibili.
Ricollegandomi a quello che diceva Gian Maria, credo che un altro elemento di convergenza tra il nostro progetto e quello della mostra principale della Biennale sia la convinzione che l’arte debba fornire un punto di vista alternativo e complementare alle grandi questioni politiche e morali che ci troviamo ad attraversare in questo momento. Quando la realtà supera l’arte stessa nello scardinare le nostre certezze, ecco che immaginare dei mondi possibili e migliori diventa un atto di resistenza culturale.
Questo a sua volta si inscrive in quella che credo sia la ricerca curatoriale di Cecilia più ad ampio raggio, visto che il titolo del Padiglione Italia da lei curato nel 2017 era proprio Il mondo magico, uno dei migliori degli ultimi anni, testimonianza a sua volta di come la sua ricerca fosse già coerente con quello che quest’anno presenta in veste di curatrice dell’intera Biennale.
Qual è Il latte dei sogni di Eugenio Viola e Gian Maria Tosatti?
GMT_Per me credo corrisponda alla testimonianza che sempre trovo nelle persone che incontro. Viaggiare per il mondo mi dà la forza e l’ispirazione per svolgere quello che considero senza ombra di dubbio il lavoro dei miei sogni, l’occupazione che ho scelto di svolgere, non di certo una professione che mi sono ritrovato a svolgere per caso. Un lavoro che non si nutre della mia identità, ma della verità che incontro attraverso le persone con cui entro in contatto, una verità che queste persone mi consentono di poter maneggiare e riportare all’interno della mia arte.
EV_Per me Il latte dei sogni si materializza in una galassia di ottimismo.