
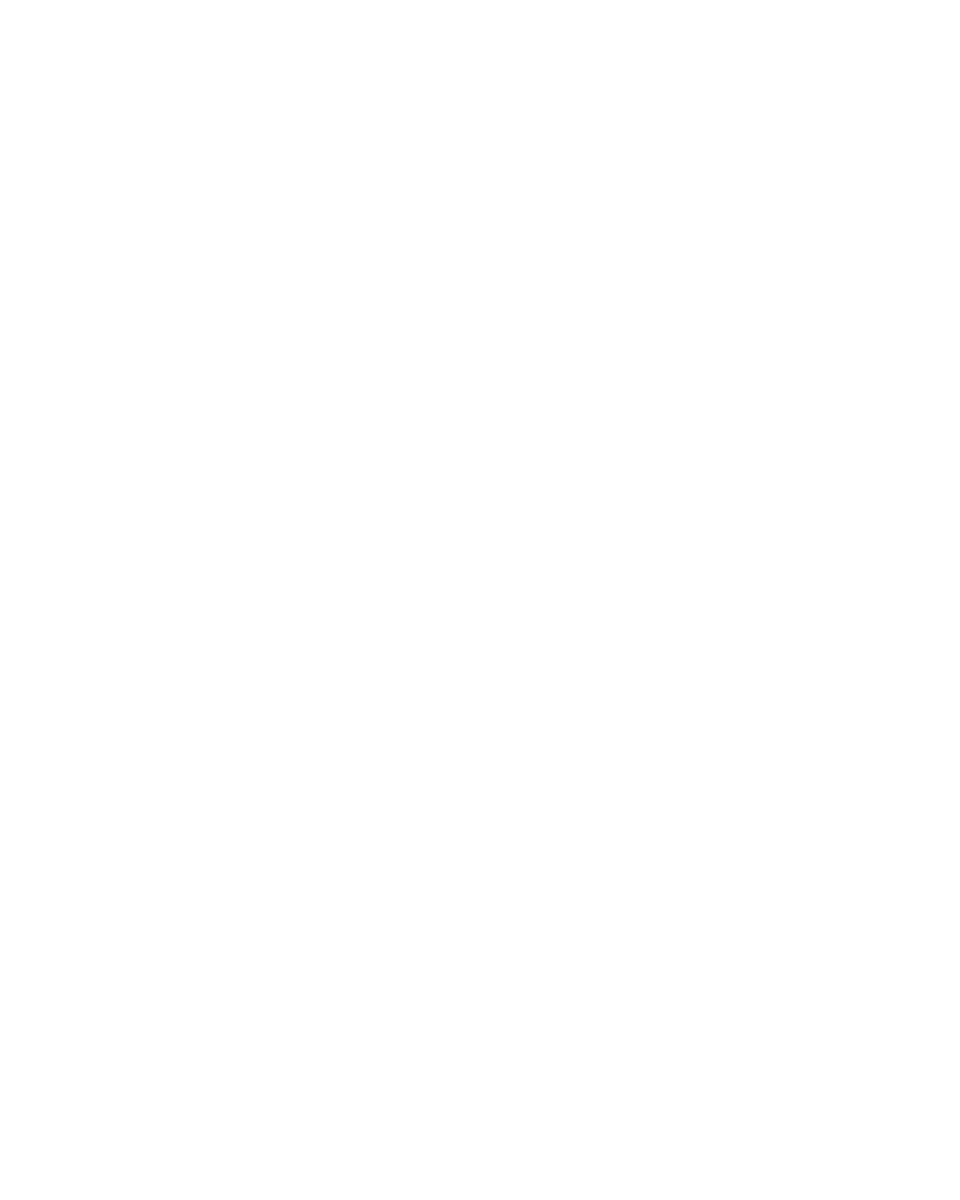
Il mondo dell’arte si riversa a Venezia come latte nei sogni. 213 artisti da 58 Paesi, 180 partecipano per la prima volta all’Esposizione. 1433 le opere e gli oggetti esposti, 80 nuovi progetti creati per la Biennale Arte. Un viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e le definizioni dell’umano.
Una mostra concepita in un tempo radicalmente insolito. Lei ha lavorato alla costruzione de Il latte dei sogni fra le pareti della sua casa a New York e riferendosi a quel periodo ha usato l’espressione molto evocativa “intimità da fine del mondo”. Cosa le ha tolto e cosa invece le ha dato in più questa condizione straordinaria nel suo rapporto con gli artisti invitati?
È stato davvero molto complicato. Innanzitutto c’è da dire che non ho mai curato una mostra così grande prima d’ora. A questo aspetto si sono aggiunte – ad appena quattro settimane dalla mia nomina – le condizioni assolutamente uniche e straordinarie che tutti conosciamo bene e che hanno indotto La Biennale a posticipare di un anno la Mostra. Da un punto di vista curatoriale, della ricerca, dello scavo, non posso certo dire che sia stato questo un fattore negativo, anzi. Rispetto ai miei predecessori ho avuto più tempo per studiare, per imparare, per conoscere meglio gli artisti, anche se spesso solo virtualmente. Al contempo, però, ho piena e sofferta consapevolezza di aver mancato uno degli aspetti secondo me più belli ed entusiasmanti di tutto questo processo lavorativo, ovvero viaggiare e incontrare gli artisti, magari anche in Paesi che conoscevo e conosco poco. Purtroppo non l’ho potuto fare. Da questo punto di vista il percorso di costruzione di questa enorme mostra è stato dunque piuttosto complesso e limitante. Sono riuscita comunque a mettere insieme un team di persone che mi ha aiutato a condurre ricerche in zone dove sapevo non sarei potuta arrivare e, anche se non è certo stata la stessa cosa, alla fine ce l’ho fatta. A pochi giorni dall’apertura mi rimane una strana sensazione legata al fatto che non ho potuto vedere tutti i lavori di persona. Alcune delle opere che saranno esposte le ho viste solo in video o in foto e, quindi, posso solo sperare che non ci saranno sorprese! E se dovessero esserci, bene: anche queste faranno parte de Il latte dei sogni.
Il libro di favole illustrate di Leonora Carrington, Il latte dei sogni, conteneva in sé tutto ciò su cui stavo lavorando: il meraviglioso, la metamorfosi, l’idea dello scontro tra umano e macchina…

Il titolo della mostra, Il latte dei sogni per l’appunto, è tratto da un piccolo libro apparentemente semplice di favole illustrate, da cui però si apre un mondo infinito di suggestioni evocate dall’autrice, l’artista surrealista Leonora Carrington. Qual è il significato profondo di questa scelta? Perché proprio la Carrington?
Il Surrealismo mi ha affascinato fin dai tempi dell’università, anche se in quell’ambiente decisamente accademico capita di conoscere e studiare principalmente la parte ‘maschile’ di questo straordinario movimento. Negli ultimi anni ci sono state delle importantissime mostre internazionali che hanno avuto il merito di generare una letteratura approfondita attorno ad artiste surrealiste quali, appunto, Leonora Carrington, ma anche Remedios Varo, Leonor Fini e molte altre ancora. Mi sono lasciata trasportare dalla piacevole riscoperta di queste figure, brave quanto i colleghi uomini ma per varie ragioni non altrettanto riconosciute e apprezzate. Se da tempo già conoscevo la Carrington artista, ho avuto modo qui, durante la preparazione della Biennale, di appassionarmi anche alla Carrington scrittrice. Ho letto tutti i suoi romanzi e i suoi bellissimi racconti. Uno dei miei preferiti è Il cornetto acustico, con protagoniste due vecchiette che si ribellano all’istituzione dell’ospizio e iniziano a praticare riti magici di stregoneria. È il ritratto di una vecchiaia ribelle e felice come solitamente non si legge nei libri e non si vede nei film, dove invece questa fase crepuscolare dell’esistenza è rappresentata come un mero fine-vita, o come una malattia. Poi mi sono imbattuta nel suo libricino di storie per bambini ed è stato come se tutto ad un tratto acquisisse un senso compiuto, come se mi si fosse improvvisamente spalancata davanti agli occhi una visione fisica ed intellettuale profonda, una rappresentazione visiva di tutti i miei interessi. Il latte dei sogni conteneva in sé tutto ciò su cui stavo lavorando: il meraviglioso, la metamorfosi, l’idea dello scontro tra umano e macchina… A quel punto non ho potuto davvero far altro che ‘rubacchiarne’ il titolo e usarlo. Non sono dunque partita né da Leonora Carrington né dal suo libro. Ad un certo punto, a processo avviato, ho semplicemente capito che quello era il titolo giusto.
Se Il latte dei sogni pare essere una sorta di catarsi finale, il punto di partenza di questo progetto curatoriale può coincidere in qualche modo con il percorso avviato con Il mondo magico, titolo del Padiglione Italia 2017 da lei curato? Esiste un filo che lega i due progetti?
Sono sempre stata molto affascinata da tutto ciò che è legato alla sfera dell’onirico, del magico, dell’inconscio. Tuttavia se esiste una linea evolutiva tra il progetto del 2017 e quello attuale essa può essersi sviluppata esclusivamente a livello inconscio. Non l’ho programmata o decisa a tavolino; tutto è nato in modo spontaneo. Ho iniziato a realizzare che esiste un legame con Il mondo magico solo a partire dalla conferenza stampa di presentazione de Il latte dei sogni, ovvero dal momento in cui ho cominciato effettivamente a parlarne. Sono due riflessioni che partono da premesse completamente diverse: il Padiglione Italia aveva un taglio più antropologico, con la presentazione di alcuni rituali specifici italiani illustrati da Ernesto de Martino, mentre in questo caso l’asse curatoriale della mostra si fonda su una concezione più ampia, più articolata e sfaccettata diciamo. Ma in un certo senso, sì, i due progetti hanno la stessa anima. In entrambi i casi non si tratta di rifugiarsi nell’inconscio o nell’onirico per fuggire dalla realtà, quanto piuttosto di trovare delle metodologie per vivere e per guardare il mondo con un occhio che non sia necessariamente quello occidentale o quello dell’uomo razionale. L’apertura a pratiche sovversive, magiche, indigene – o comunque lontane dal nostro odierno comune sentire – non conduce all’irrazionale, ma al raggiungimento di un punto di vista che ci permette di leggere e interpretare diversamente ciò che ci circonda. In questo senso sì, il discorso iniziato allora prosegue oggi qui.

Il contemporaneo è spesso visto come un’“astronave avulsa” da ciò che l’ha preceduta, come se fosse un’entità fuori dal tempo. In questa mostra lei intende fornire delle chiavi di lettura del fare arte oggi attraverso delle tracce storiche che contribuiscano a rendere più agevole la lettura, la comprensione di quanto realizzato ed esposto dagli artisti selezionati. Ci parli un po’ di queste attesissime, intriganti cinque capsule temporali, sorta di stazioni del tempo disseminate nel lungo percorso della mostra. Come mai questa scelta?
Ciò che mi premeva era non soltanto guardare alla Biennale e a questa esposizione come a una fotografia degli ultimi due anni di produzione artistica – che comunque la Mostra restituisce grazie alla presenza di tantissimi artisti giovani e di tendenza –, ma anche e più estesamente come a una sorta di “zoom out” che permettesse alla mia mostra e a quelle che l’hanno preceduta di essere parte di un’unica grande storia. Non è sufficiente affermare che la Biennale Arte è l’esposizione d’arte più antica del mondo: è fondamentale essere conseguenti, dare un senso concreto, tangibile a questo assunto creando delle connessioni plausibili tra ciò che si propone oggi e quanto è stato proposto nelle edizioni passate. Molto spesso cito la Biennale Arte del 1948 perché in un certo senso è la “Biennale della rinascita”, arrivata dopo i quattro anni di interruzione a causa della Seconda Guerra Mondiale. Un contesto storico certamente diverso rispetto al nostro, sicuramente più tragico, eppure con delle oggettive similitudini, perché anche il tempo che abbiamo vissuto e che stiamo in parte ancora vivendo è espressione di una frattura secca nel flusso ordinario dell’esistenza individuale e collettiva, sociale, il che fa sì che oggi come allora si viva un momento in cui vi è un’urgenza potente ad aprirsi al nuovo e allo stesso tempo una disposizione naturale a volgersi indietro e a ripensare ai linguaggi che sono stati ignorati, cancellati o censurati negli anni appena trascorsi. Mi interessava quindi inserire l’elemento storico nella conversazione perché in questo periodo si può avvertire nell’aria un fermento culturale proveniente da diverse istituzioni che si stanno interrogando e chiedendo se le proprie collezioni e mostre rappresentino davvero la nostra essenza, o se sia invece necessario riesaminare le circostanze attraverso le quali le opere sono arrivate. È in atto un processo di riscrittura e di reinterrogazione della storia importantissimo che è ciò che rende viva oggi ogni istituzione culturale. Non dobbiamo guardare alla storia della Biennale come a un monolite, ma prestare attenzione alle omissioni e a ciò che è stato in parte censurato, non necessariamente in maniera conscia. Un approccio che informa un processo che si sta sviluppando e seguendo un po’ in tutto il mondo.
Entriamo quindi in queste capsule storiche, a partire dalle visioni surrealiste e dal dominio del meraviglioso che troviamo nella prima di esse, La culla della strega. Quale il significato di questo recupero simbolico? Quali le linee o i solchi tracciati da queste artiste ancora attuali?
Come dicevo il Surrealismo è un interesse che porto avanti da molto tempo. La mia tesi di laurea era incentrata proprio su quegli anni, attorno al ‘29, anche se l’argomento riguardava il filosofo francese Georges Bataille e la sua rivista «Documents», che in realtà era alquanto critica nei confronti del movimento. Oggi mi sembra che ci sia un bel po’ di Surrealismo nell’aria e lo testimoniano le tantissime mostre dedicate al movimento in diversi musei del mondo, dalla Tate al MET. Possiamo dire che qualcosa si sta muovendo ed è un qualcosa di estremamente reale. Basti pensare al clima in cui anche il secondo Surrealismo è sbocciato, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, un momento di svolta radicalmente reazionario della società europea, un clima che purtroppo abbiamo potuto respirare, pur in proporzioni decisamente più contenute, anche noi negli ultimi anni. Con lo scoppio della tragica e inattesa guerra in Ucraina questa evidenza, questa consonanza si è fatta ancora più drammaticamente tangibile. Può essere uno statement un po’ azzardato, ma forse gli artisti stanno tornando a utilizzare metodologie simili a quelle dei surrealisti proprio perché ci troviamo in una situazione analoga. Forse la loro non è nemmeno un’appropriazione conscia, ma il ritorno all’introspezione è sicuramente inevitabile in un periodo di grande crisi. Alla fine di due anni di pandemia, durante i quali siamo rimasti bloccati in casa, la cosa più naturale che un artista possa fare è cercare di processare i drammi del mondo attraverso una visione del presente più personale, onirica, surreale.
Tutto questo converge in opere che per noi oggi risultano molto semplici, ma che a quel tempo apparivano incredibilmente contemporanee e futuristiche, perché erano creazioni che usavano la fascinazione delle nuove tecnologie in modo sorprendente.
Un percorso nell’arte del Novecento di cui forse non abbiamo in pieno colto la portata nelle sue composite articolazioni, vedi la lezione fondamentale dei movimenti degli anni ’60, che lei propone nella seconda capsula temporale dal titolo Tecnologie dell’incanto. La tecnologia e la percezione, il rapporto attivo fra opera e spettatore, temi che proprio ora stiamo indagando nelle nuove frontiere del digitale. In che cosa consiste l’incanto della tecnologia nel tempo di ieri e in quello di oggi?
Quando mi riferisco alla tecnologia ne parlo in un’ottica la più vasta possibile; non mi interessano in particolare, che so, la VR o qualsivoglia altra nuova espressione della ricerca digitale. Ciò che mi coinvolge, che stimola la mia curiosità, la mia immaginazione è invece riflettere sulla fascinazione che l’innovazione tecnologica ha esercitato nel tempo sugli artisti. I mezzi attuali sono ben diversi da quelli degli anni ’60; medesima però è la propulsione che deriva dalle nuove scoperte e che anima gli artisti e le loro menti. Pensiamo all’arte cinetica, all’arte programmata, all’introduzione di nuove tecnologie come i computer, ma anche all’avvento di nuovi materiali, come il plexiglass o il neon… Tutto questo converge in opere che per noi oggi risultano molto semplici, ma che a quel tempo apparivano incredibilmente contemporanee e futuristiche, perché erano creazioni che usavano la fascinazione delle nuove tecnologie in modo sorprendente. Ho voluto quindi dare spazio a un gruppo di artiste italiane che in quegli anni già riflettevano su un’idea di interfaccia, di membrana, di schermo, di epidermide, concetti che ispirano molti artisti contemporanei. Sono tematiche che si impongono oggi con forza e ho voluto ricondurle a un linguaggio che naturalmente esiste da decenni ma che, soprattutto pensando a queste sei artiste presenti nella capsula – Grazia Varisco, Laura Grisi, Nanda Vigo, Marina Apollonio, Lucia Di Luciano, Dada Maino –, era stato sino ad ora trattato solo marginalmente.
Proprio alla luce dei nuovi mezzi digitali che hanno occupato centralmente il nostro tempo come sta cambiando la fruizione dell’arte?
Lavoro da dieci anni alla High Line di New York e questo significa pensare soprattutto a come comunicare con gli otto milioni di persone che passano di lì non necessariamente perché vogliono visitare un museo, perché sono alla ricerca di arte. Ed è proprio qui che scatta il ruolo del curatore: rendere le opere d’arte comprensibili e fruibili in un contesto in cui chiunque possa avere un suo punto di accesso. Un’opera d’arte funziona quando si apre a tanti punti di vista e a differenti interpretazioni, capaci di ‘solleticare’ l’intelletto e stimolare reazioni forti, anche, perché no, di disgusto. Ciò che conta è che questi lavori abbiano una loro valenza emotiva importante. Questo è il lavoro dell’artista, certo; ma è anche il lavoro del curatore. Il nostro obiettivo è creare dei percorsi che possano essere stimolanti per tutti. La storia della Biennale, già indagata dalla mostra Le muse inquiete, sembra rivestire un ruolo assai rilevante nell’economia complessiva del suo percorso espositivo. Eloquente a riguardo il riferimento alla poesia visiva e concreta della mostra Materializzazione del linguaggio allestita per la Biennale Arte 1978, che ritroviamo ora nella capsula dedicata al Corpo orbita. Come questo lavoro di scavo nei giacimenti dell’ASAC diventa motore per rileggere e riscrivere parti dell’arte del Novecento e quali di queste tracce si ritrovano vive nel nostro presente? È stato per me un fantastico lusso avere a disposizione un anno di tempo per studiare ed è stato bellissimo scavare nell’Archivio Storico della Biennale (ASAC), anche senza poterci andare fisicamente, purtroppo. Sicuramente il lavoro di ricerca svolto per Le muse inquiete ha influenzato la mia decisione di includere delle opere storiche nella ‘mia’ Biennale, lavori non necessariamente provenienti dall’ASAC, ma in grado tutti comunque di suscitare una riflessione sui diversi cicli della storia della Biennale e su come l’Istituzione in sé abbia reagito ai grandi ‘cataclismi’ della storia: guerre, rivoluzioni sociali, inondazioni. Mi hanno inoltre sempre appassionato molto la Poesia Visiva e la Poesia Concreta, forme d’arte che attraversano gli ultimi due secoli della nostra storia ma che oggi hanno assunto un valore nuovo. Ho cercato di trasmettere quel tipo di espressione artistica e il dialogo che è capace di instaurare con il contemporaneo attraverso la terza capsula, che raccoglie artisti, artiste e scrittrici che a partire dall’‘800 utilizzano forme espanse di linguaggio come strumenti di emancipazione e che con i loro racconti di vita hanno immaginato nuove possibilità dell’essere.

Il pensiero di Donna Haraway, filosofa statunitense, teorica di una branca del pensiero femminista che studia il rapporto tra scienza e identità di genere, accompagna la linea della capsula dedicata a opere che raffigurano dei recipienti, i “vessel”, presumibilmente un riferimento all’oggetto-contenitore in quanto archetipo femminile. In una mostra che sradica i confini di genere, con una preponderante partecipazione di artiste, in che modo il dato ‘femminile’ ha guidato il suo progetto curatoriale?
Non penso necessariamente che sia la capsula più femminile o femminista, anzi. È di sicuro la capsula meno storica, nel senso che se le altre in un certo modo sono connesse a un particolare movimento artistico, sia esso il Futurismo, il Surrealismo o il Bauhaus, questa invece è più metaforica. La definirei un’iconologia delle forme-recipiente e dei loro legami simbolici, spirituali e metaforici con la natura, includendo in maniera trasversale opere che vanno dal 1600 in poi. L’idea della capsula dei recipienti ha avuto origine da The Carrier Bag Theory of Fiction, un libretto della visionaria scrittrice di fantascienza Ursula K. Le Guin che ho letto quasi per caso, attirata proprio dalla prefazione di Donna Haraway. Il testo di Le Guin offre una rilettura molto affascinante dell’origine della tecnologia e, allo stesso tempo, dell’origine della narrazione, della finzione. La prima invenzione tecnologica, dice Le Guin, è da ricercare non più nelle armi utilizzate dall’uomo cacciatore, quanto piuttosto nei contenitori con cui le donne raccoglievano granaglie e semi, tenendoli tra le mani, nella sacca, in un guscio. Il contenitore, quindi, come primo esempio di invenzione tecnologica. Partendo da questo primo assunto, Le Guin allarga la sua analisi alle grandi narrazioni, come ad esempio quella prometeica o mitologica, che andrebbero riviste proprio perché assomigliano a grandi borse in cui lettere, frasi e racconti si intersecano simbioticamente.
L’interesse per il postumano è nato dalle mie letture, ma è evidente che si tratta di un tema che sta calamitando ampiamente anche l’attenzione degli artisti.
Nel suo libro The Posthuman (2013) la filosofa Rosi Braidotti dice: «La condizione postumana ci spinge a pensare in modo critico e creativo su chi e cosa stiamo effettivamente diventando». Una delle suggestioni più forti e, potremmo dire, ‘scandalose’ del suo programma, che ritroviamo nell’ultima capsula dal titolo La seduzione di un cyborg, riguarda proprio la fine della centralità dell’essere umano, il suo farsi macchina, terra. Perché questo tema è così urgente?
L’interesse per il postumano è nato dalle mie letture, ma è evidente che si tratta di un tema che sta calamitando ampiamente anche l’attenzione degli artisti. Si tratta di tematiche che stanno diventando con insistenza molto attuali. Tutta l’impostazione culturale che abbiamo dato alla nostra società, con l’uomo al centro e al vertice della piramide e tutto il resto sotto di lui, è da riconsiderare alla luce degli ultimi due anni di pandemia, durante i quali la fragilità e la mortalità dei nostri corpi è stata esibita molto chiaramente. È doveroso ricercare un rapporto diverso con le altre persone ma anche con le altre specie e con il mondo che ci circonda, come fossimo arrivati a un punto di non ritorno. E non lo dice solo Rosi Braidotti. Sono ormai molti, infatti, gli intellettuali che sostengono che sia arrivato il momento non soltanto di immaginare, ma anche di attualizzare un rapporto diverso che ci leghi alla natura e alle altre specie. Sta diventando indispensabile fare un passo indietro, renderci conto che non siamo decisamente più al centro del mondo e impostare la nostra esistenza sulla condivisione, sulla simbiosi, slegandoci dalle manifestazioni più palesi e preminenti del capitalismo votate a sfruttare senza remora alcuna le risorse del pianeta e della natura. Dobbiamo immaginare un mondo più orizzontale, regolato da rapporti paritari e di coesistenza tra le specie.
Le cinque capsule presentano quindi temi decisamente forti, che coinvolgono la sfera esistenziale di tutti noi. Ma quando usciremo dalla Biennale saremo più ottimisti o pessimisti?
Un po’ con entrambi gli umori. Non voglio dire che saremo soltanto ottimisti, perché ci saranno dei lavori anche oscuri e perturbanti, però la grande forza dell’arte e degli artisti è quella di digerire la crisi drammatica di questi ultimi anni e di riproporcela in chiave creativa, in una declinazione più ottimista o più pessimista a seconda delle personali visioni di ciascuno. È un processo di rivisitazione che si traduce in un esercizio importantissimo, anche se poi sta allo spettatore trarne le conclusioni che vuole. Il nostro lavoro è creare le condizioni per poter parlare di questioni urgenti; il fatto che si possa iniziare a confrontarsi, o almeno ad avere una consapevolezza diversa, penso sia davvero fondamentale. È il ruolo della stampa e della letteratura, ma anche quello delle mostre: assorbire i fermenti e le preoccupazioni di ogni epoca e tradurli in modo visivo per il pubblico.
Cecilia Vicuña e Katharina Fritsch. Cosa rappresentano per lei queste due figure che ha scelto di celebrare con il Leone d’Oro alla carriera?
Katharina Fritsch è un’artista incredibile, alla pari di Jeff Koons e Charles Ray, anche se purtroppo non è riconosciuta allo stesso modo, nonostante abbia impresso nella scultura alcune innovazioni di linguaggio se non prima, sicuramente negli stessi anni dei suoi colleghi uomini. È un’artista che ha ancora una carica e una straordinaria voglia di dire e creare senza badare a mode o tendenze, portando avanti un lavoro molto unitario e serio. Cecilia Vicuña lavora con un tipo di scultura che trova nella fragilità dell’assemblaggio di oggetti semplici la poesia di cui è una grandissima esponente, essendo lei stessa poetessa e avendo svolto per decenni il lavoro di editor di poesie sudamericane che sarebbero altrimenti andate perdute. Sono due visioni molto diverse e per certi versi opposte: da un lato la scultura di Fritsch ‘super-prodotta’ anche in modi innovativi, industriali e complessi; dall’altro la scultura ‘precaria’ di Vicuña, che nasce dall’incontro/scontro di piccoli oggetti nella natura, nello spazio pubblico.

L’ombra nera e angosciante della guerra sta naturalmente investendo anche la cultura e l’arte. Il Padiglione russo rimarrà chiuso, ci sarà invece la partecipazione ucraina all’Arsenale. Sono presenti inoltre artisti russi e ucraini nella mostra principale. Si è molto parlato in queste settimane, con toni spesso opposti e conflittuali, circa l’opportunità o meno in questo momento così drammatico di coinvolgere istituzioni e artisti provenienti dal territorio, dalla nazione che questa guerra ha scatenato, ossia la Russia. Come si pone di fronte a questo clima assai scivoloso che certamente ci pone tutti di fronte al tema della limitazione della libertà di espressione, libertà di cui l’arte si è sempre nutrita più di qualsiasi altra forma comunicativa?
La guerra ci ha messo di fronte ad una situazione drammatica e parlare di arte oggi sembra quasi superficiale e inutile. Sono convinta che gli artisti e le istituzioni artistiche debbano avere la forza di prendere una posizione anche politica, ma credo fermamente nell’arte come luogo di massima libertà di espressione. Forse ci può essere per alcuni una specie di soddisfazione immediata nel censurare l’arte russa in questo momento, come è successo in vari ambiti in questi giorni soprattutto sui canali social, ma si tratta di una soddisfazione effimera; la ‘felicità’ di un secondo di cui poi non resta nulla e che non lascia spazio alla riflessione critica. Più utile e interessante è invece creare spazi di discussione per meglio comprendere la condizione degli artisti coinvolti, la loro posizione, che in questo momento è decisamente difficile. Il caso del Padiglione Russo è un po’ diverso e va ben oltre l’arte, in quanto i Padiglioni e gli artisti che espongono in questi spazi rappresentano istituzionalmente delle nazioni. In questo senso capisco bene, quindi, gli artisti e il curatore del Padiglione Russo che hanno deciso di ritirarsi. Sono riuscita a mettermi in contatto con l’artista russa presente invece nella mostra principale, Zhenya Machneva. Le mancava il visto e purtroppo stava avendo delle enormi difficoltà a lasciare il Paese. Con il Padiglione ucraino siamo in contatto giornaliero e, grazie al cielo, sia il curatore che l’artista, insieme all’opera, sono riusciti a lasciare il Paese. La Biennale li sta aiutando il più possibile. Il Padiglione ci sarà di sicuro e speriamo di riuscire a fare anche altro, a supportarli in altri modi, perché per quanto possa sembrare futile pensare alla Biennale in un momento del genere, per loro potersi occupare di questo progetto significa ritrovare una quasi normalità in mezzo alla tristezza e alla disperazione. Per quanto possa essere simbolico, è questo un vero valore per loro. Che il Padiglione ci sia e il poter dare il massimo supporto e la massima solidarietà agli artisti ucraini in questo momento è per noi una priorità.
Le contingenze storiche hanno rimesso spesso al centro della discussione l’opportunità di una suddivisione in padiglioni nazionali di una grande mostra internazionale quale è la Biennale. Una struttura che d’altra parte è il nucleo fondante, un po’ la spina dorsale di questa fondamentale esposizione del contemporaneo. Come si trova dentro questa “architettura”?
Non trovo affatto obsoleta la struttura dei Padiglioni nazionali. Abbiamo spesso visto molti Paesi utilizzare il proprio padiglione per parlare di tematiche stringenti e universali. Certo, è una struttura che nasce da una visione delle relazioni internazionali novecentesca; una visione forse obsoleta oggi, certo, ma solo fino a che non assistiamo a un’invasione di un paese da parte di un altro… A quel punto i padiglioni nazionali escono dalla carta, dall’ambito del simbolico e diventano estremamente reali e attuali.
Il latte dei sogni è un mondo popolato di storie fantastiche, esseri ibridi e mutanti, un mondo in cui chiunque può trasformarsi. In cosa vorrebbe trasformarsi Cecilia Alemani? Qual è il suo Latte dei sogni?
In cosa vorrei trasformarmi? In questo momento mi verrebbe da dire in una nuvola, per volare su, lontana e leggera in mezzo al silenzio. Mi vedo come un cadavre exquis surrealista, fatto di tanti pezzettini disconnessi che cercano di parlarsi tra di loro ma senza troppo successo. Non saprei dire di preciso qual è il mio Latte dei sogni; penso sia l’arte ovviamente, il poter ‘sguazzare’ nelle creazioni degli artisti.